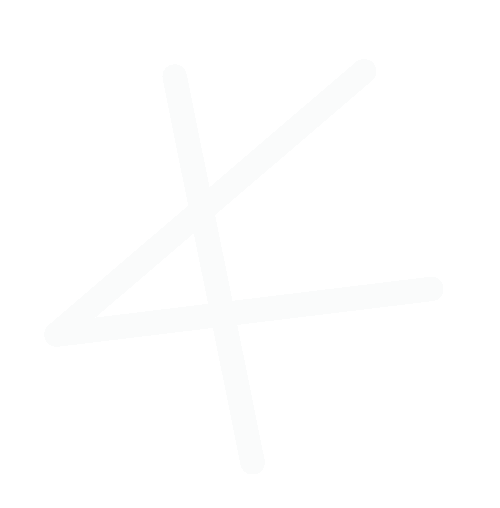Biblioteca:Apollonio Rodio, Argonautiche, Libro IV
Vai al Libro III - Torna all'Indice
Ora tu stessa, Musa divina, figlia di Zeus,
dovrai cantare il travaglio e i pensieri della fanciulla di Colchide;
ché dentro di me la mia mente ondeggia in uno sgomento
[senza parole,
se devo dire che fu per angoscia infelice d'amore
o per terrore fatale che lasciò la terra dei Colchi.
Eete nel palazzo, assieme ai grandi della sua gente,
per tutta la notte tramava un inganno astuto contro gli eroi;
e nel suo cuore nutriva un'ira terribile
per l'odiosa prova, e pensava che tutto
s'era compiuto non senza l'aiuto delle sue figlie.
A lei, Era infuse nel cuore una paura penosa:
- tremava come una cerbiatta veloce, terrorizzata
dall'abbaiare dei cani nel folto di un bosco profondo.
D'improvviso vide chiaro e capì che il suo aiuto
non gli poteva restare nascosto, e la sciagura era al colmo.
Temeva le donne, che sapevano tutto. I suoi occhi
furono pieni di fuoco, le orecchie rombavano terribilmente.
Spesso portò le mani alla gola, spesso, strappando
ciocche di capelli, piangeva un disperato dolore.
E là in quel giorno sarebbe morta contro il destino,
ingoiando il veleno e rendendo vani i progetti di Era,
se nella sua angoscia la dea non l'avesse spinta a fuggire
insieme ai figli di Frisso: allora nel petto
si calmò il cuore inquieto; tornata in se stessa,
vuotò il cofanetto e nascose i filtri nel seno.
Baciò il letto, baciò dentro e fuori i battenti,
accarezzò le pareti; con le mani strappò un lungo ricciolo
e lo lasciò nella stanza per la madre, ricordo
della sua vita di vergine, e gemette con voce convulsa:
"Questa lunga ciocca ti lascio al mio posto, madre mia,
[e me ne vado;
addio e sii felice, anche se vado tanto tanto lontano;
addio, Calciope, addio a tutta la casa. Oh se il mare
ti avesse sbranato, straniero, prima d'arrivare alla terra
[dei Colchi!".
Così disse, e versava dagli occhi copiose lacrime.
Come, trascinata per una casa ricca, una schiava di guerra
che il destino ha appena strappato via dalla patria
e ancora non ha avuto esperienza delle aspre fatiche,
non ha provato miseria e lavori servili,
si muove infelice sotto le dure mani della padrona,
così la splendida donna corse fuori della sua reggia.
Davanti a lei cedettero da soli i battenti
spalancandosi in dentro al rapido suono degli incantesimi.
Correva a piedi nudi per le vie strette;
con la sinistra, sollevava il peplo sugli occhi,
sopra le belle guance e la fronte, e intanto
la destra reggeva in alto un lembo di tunica.
Andava rapida nel suo terrore per una strada oscura
oltre le mura della grande città. Non la riconobbe
nessuna delle sentinelle, non s'avvidero della sua corsa.
Pensava di andare al campo: sapeva bene
le strade: tante volte le aveva percorse cercando
cadaveri ed erbe malefiche, come usano fare
le maghe; ma il cuore batteva forte, di tremore e terrore.
La vide correre, levandosi appena dall'orizzonte,
la Luna, la dea titania, e gioì con malizia,
e tra sé e sé disse queste parole:
"Non io soltanto ricerco l'antro di Latmo,
non io soltanto brucio per il bell'Endimione,
io che spesso mi sono mossa per i tuoi astuti incantesimi
nel pensiero d'amore, perché tu celebrassi i tuoi riti
tranquilla nella notte oscura, come a te piace.
Ora anche tu hai parte di questa stessa sventura:
il dio del dolore ti ha dato Giasone come tua pena
ed angoscia. Va' dunque, e preparati a sopportare,
per quanto sapiente tu sia, dolori infiniti".
Così disse, ma l'altra i piedi la portavano rapida, in fretta.
Lietamente giunse alle rive del fiume, e vide sull'altra sponda
risplendere i fuochi che, nella gioia della vittoria,
gli eroi avevano acceso per tutta quanta la notte.
Di là dal fiume, nel buio, con voce limpida e acuta,
chiamò il più giovane tra i quattro figli di Frisso,
Frontis. Ne riconobbe la voce, lui e i fratelli,
e il figlio di Esone: i compagni stupirono
muti, quando capirono ch'era lei, proprio lei.
Tre volte gridò, e tre volte, per invito degli altri,
Frontis rispose al richiamo, e intanto gli eroi
remavano in cerca di lei, facendo forza sui remi.
Non avevano ancora gettato le cime alla riva di fronte
e dalla tolda subito Giasone balzò a terra
con rapido piede, e assieme a lui saltarono Argo
e Frontis, figli di Frisso. La giovane donna
abbracciò i loro ginocchi, e disse queste parole:
"Salvatemi, amici, salvate me infelice
e voi stessi da Eete. Tutto è già stato scoperto
e non c'è più rimedio. Presto, presto, fuggiamo
sulla nave prima che monti i veloci cavalli.
Io vi darò il vello d'oro, addormentando il serpente
custode: ma tu, straniero, davanti ai compagni,
prendi gli dei a testimoni della promessa
che hai fatto, e non lasciare che io, andando lontano,
sia, per l'assenza dei miei, disprezzata e derisa".
Così disse, afflitta, ma era lieto il cuore di Giasone.
Subito e dolcemente la rialzò dalle sue ginocchia,
e le fece coraggio e le parlò in questo modo:
"Mia cara, sia testimone Zeus Olimpio, custode dei giuramenti,
ed Era, la sposa di Zeus, la dea delle nozze,
che ti porterò nella mia casa come sposa legittima
quando avremo fatto ritorno alla terra di Grecia".
Così disse, e mise la mano destra nella sua mano.
Medea ordinò di condurre presto la nave
al bosco sacro, per poter prendere il vello
durante la notte, ingannando il volere di Eete.
Così disse, e così fecero, pieni di slancio:
la presero a bordo e si staccarono subito
dalla riva: era grande il frastuono del battito intenso
dei remi. Lei, slanciandosi indietro,
tendeva alla terra le mani, disperata: ma Giasone
le faceva coraggio, la sosteneva nel suo dolore.
Nell'ora in cui i cacciatori scacciano il sonno
dagli occhi e, fidando nei cani, non dormono
l'ultima parte di notte, perché la luce dell'alba
non cancelli, colpendo la terra coi limpidi raggi,
le tracce e l'odore delle fiere selvagge;
in quell'ora Medea e il figlio di Esone sbarcarono
in un luogo erboso che chiamano il letto
del montone: là per la prima volta piegò le ginocchia sfinite,
quando portava sul dorso il minio Frisso, figlio del re Atamante.
Erano là vicine le fondamenta, coperte di ceneri,
dell'altare che Frisso innalzò a Zeus patrono
degli esuli, e gli consacrò il vello d'oro,
obbedendo al comando di Ermes, che gli apparve benevolo.
Qui per consiglio di Argo li fecero scendere.
Per un sentiero giunsero al bosco sacro,
cercando la grande quercia dov'era il vello,
simile ad una nuvola che si fa rossa
sotto i raggi infiammati del sole nascente.
Ma già con gli occhi insonni li aveva visti il dragone
al loro arrivo, e tendeva verso di loro il collo
lunghissimo; soffiava terribilmente, e risuonava
la riva del fiume e la sconfinata foresta.
L'udivano i Colchi, anche quelli che vivevano molto lontano
dalla terra Titania di Eea, lungo il corso del Lico,
che, staccandosi dal fragoroso Arasse, riunisce
le sue sacre correnti a quelle del Fasi, e correndo
insieme sfociano insieme nel Mare Caucasio.
Le donne a letto si svegliarono per lo spavento:
e piene d'angoscia abbracciarono i bimbi
che dormivano sul loro seno, anch'essi scossi dal sibilo.
E come, in una foresta che brucia, si volgono
innumerevoli ardenti spire di fumo,
via via montando dal fondo, l'una di seguito all'altra;
così il mostro scuoteva le sue enormi volute,
coperte di aride squame. E mentre lui si allungava,
ecco che Medea fu davanti ai suoi occhi
e con voce soave invocò il Sonno in aiuto,
il dio supremo, che affascinasse la fiera;
e chiamò anche la regina notturna, infernale,
che le fosse benevola, e le concedesse l'impresa.
La seguiva atterrito il figlio di Esone; ed il serpente
stregato dall'incantesimo scioglieva la lunga spina
dalle spire nate dal suolo, e allungava i suoi infiniti
anelli, così come quando sul mare in bonaccia
si rovescia un'onda scura, muta, senza frastuono;
ma tuttavia teneva alzata l'orribile testa,
bramoso di avvolgere entrambi nelle mascelle mortali.
Medea intinse un ramo di ginepro, tagliato da poco,
nella mistura, e sparse il filtro possente sopra i suoi occhi,
pronunciando le formule: lo circondò l'odore
del filtro e lo addormentò. La bocca cadde,
poggiata a terra, e gli anelli innumerevoli
si distesero dietro nel folto della foresta.
Obbedendo a Medea, Giasone staccò dalla quercia
il vello d'oro; ed essa intanto, immobile,
spargeva il suo filtro sopra il capo del mostro,
finché Giasone ordinò di tornare alla nave;
e a quel punto lasciarono il bosco ombroso di Ares.
Come una fanciulla riceve sopra la veste
la luce della luna piena, che splende sul tetto
della sua stanza, ed il suo cuore è lieto
dell'incantevole lume; così godeva
il figlio di Esone, alzando il vello nelle sue mani;
sopra le bionde guance e sopra la fronte
al baleno del vello venne un rossore, come di fiamma.
Grande come la pelle d'una giovenca d'un anno o di un cervo,
quello che i cacciatori chiamano cerbiatto,
così era il vello, tutto d'oro e coperto
di bioccoli, pesante; e mentre Giasone avanzava
la terra ai suoi piedi rifletteva passo su passo la luce.
Andava portandolo, ora sopra la spalla sinistra,
lasciandolo pendere fino ai piedi dall'alto del collo,
ora lo raccoglieva tra le mani, temendo
d'incontrare un uomo o un dio che glielo rubassero.
L'aurora si spandeva sul mondo, quando arrivarono
presso i compagni. Stupirono i giovani nel vedere il grande vello
splendente, simile al lampo di Zeus: ed ognuno
si slanciava a toccarlo, a prenderlo in mano.
Ma Giasone li allontanò tutti e vi gettò sopra
un mantello nuovo. Sollevando Medea, la fece sedere
a poppa, e in mezzo a tutti disse queste parole:
"Non indugiate più, amici miei, a tornare alla nostra patria;
l'impresa per cui osammo il viaggio angoscioso
soffrendo pena e fatica, l'impresa è bene compiuta
grazie ai consigli di questa fanciulla. lo, com'essa desidera,
la porterò nella mia casa, e sarà la mia sposa
legittima; ma voi proteggetela, lei che è venuta
in soccorso vostro e di tutta la Grecia:
penso che presto Eete verrà con il suo esercito
a sbarrarci il cammino che porta dal fiume nel mare.
A turno, seduti sui banchi, fate forza sui remi,
e l'altra metà di voi, protendendo gli scudi
di cuoio a difesa dalle frecce nemiche,
protegga la via del ritorno. In mano nostra
abbiamo i figli e la cara patria, ed i vecchi
padri: da noi dipende la Grecia
che sia umiliata, o che riceva grandissimo onore".
Disse, e vestì le armi di guerra: gli altri gettarono
un grido immenso. Lui sguainò la spada
e recise le cime di poppa; poi si sedette
armato, di fianco alla donna e vicino ad Anceo,
il pilota. La nave correva, spinta dai remi:
avevano fretta di portarla fuori del fiume.
Intanto al superbo Eete e a tutti i Colchi era noto
l'amore di Medea, e ciò che essa aveva compiuto.
Si radunarono armati in assemblea ed erano tanti
quante sono le onde del mare in tempesta,
agitato dal vento, o quante sono le foglie
che cadono in autunno, e chi potrebbe contarle?
In folla immensa occuparono, con grandi grida
di guerra, le rive del fiume. Eete, sopra il suo carro,
spiccava fra tutti per i cavalli, dono del Sole,
e veloci come un soffio di vento; nella mano sinistra
teneva lo scudo rotondo, nella mano destra
una grande fiaccola; la sua lunghissima lancia
era lì accanto, distesa in avanti; ed Assirto
reggeva ai cavalli le redini. Ma già la nave,
spinta da rematori robusti e dalla corrente
del grande fiume, solcava le onde del mare.
Il re, colpito dall'aspra sventura, levò al cielo le braccia,
chiamando il Sole e Zeus a testimoni del male subito,
e rivolse a tutto il popolo gravi minacce:
se non avessero trovato sua figlia, per terra,
o sulle strade del mare, e non gliel'avessero
riportata a casa, perché saziasse il suo animo
punendola di tutto questo, sapessero che sul loro capo
ricadrebbe tutta la collera e la rovina.
Così parlò Eete. I Colchi in quel giorno stesso
misero in mare le navi e le armarono, e quel giorno stesso
presero il largo. Avresti detto che erano
non una flotta, ma un popolo enorme d'uccelli
che volavano a stormo sul mare con grande strepito.
Ma gli eroi - il vento soffiava fortissimo per volere di Era,
perché al più presto Medea giungesse alla terra pelasga
e portasse la rovina alla casa di Pelia - al terzo giorno,
all'alba, legarono gli ormeggi di Argo alle rive
di Paflagonia, nei pressi del fiume Halys:
là aveva imposto Medea di sbarcare ed onorare
con sacrifici Ecate. E ciò che ella fece,
apprestando la cerimonia - mai nessuno lo sappia,
e il mio cuore non mi spinga a cantarlo -
ho ritegno a dirlo; ma resta tuttora il santuario
che gli eroi costruirono su quelle rive alla dea,
offerto alla vista delle generazioni future.
In quel momento Giasone e gli altri compagni si ricordarono
di Fineo che aveva predetto un altro cammino
al ritorno da Eea; ma a tutti loro era ignoto.
Argo così parlò agli eroi ansiosi: "Noi torneremo
alla città di Orcomeno per quella via che vi ha detto
il profeta infallibile che avete incontrato.
È vero, c'è un altro cammino, quello che rivelarono
i sacerdoti nati in Tebe Tritonia. Non c'erano
tutte le stelle che volgono in cielo il loro corso,
nessuno aveva sentito parlare del popolo sacro
dei Danai; c'erano solo gli Arcadi Apidani,
gli Arcadi che si dice siano ancora più antichi
della luna, e mangiavano ghiande sulle montagne;
sul paese pelasgo non regnavano gli illustri figli di Deucalione,
ma già si dava il nome di Eeria, terra brumosa,
al fertilissimo Egitto , origine dei primi uomini,
e di Tritone al grande fiume che la bagna tutta:
dalle sue acque fiorisce sempre il raccolto,
poiché mai non lo bagna la pioggia di Zeus.
Di là si racconta che un uomo percorse tutta l'Europa
e tutta l'Asia, fidando nella potenza e nella forza
e nel coraggio del proprio esercito; ed infinite città
fondò nella marcia, alcune ancora abitate,
altre no: ché moltissimo tempo è trascorso.
Ma Eea resta ancor oggi ben salda, e restano i figli
degli uomini che aveva installato colà per popolarla,
ed essi conservano le iscrizioni dei loro padri;
tavolette sopra le quali sono segnate le strade e i confini
di mare e terra, a beneficio di chi si mette in cammino.
C'è un fiume, l'ultimo corno d'Oceano, largo, profondo,
tanto che può navigarlo una nave da carico:
lo chiamano Istro, e lo segnano molto lontano:
per un tratto attraversa da solo quella immensa regione,
perché le sue sorgenti mormorano al di là del soffio di Borea,
lontano, sui monti Rifei; ma quando percorre
le terre abitate dai Traci e dagli Sciti,
si divide in due bracci: da un lato si getta
nel Mare Orientale, dall'altro attraversa
il golfo profondo dove s'insinua il mare Trinacrio,
accanto al vostro paese, seppure è vero
che nel vostro paese sgorga il fiume Acheloo".
Così disse, e la dea mandò loro un messaggio
propizio, per cui tutti insieme gridarono
di seguire la strada indicata: là dove stavano per andare comparve
un solco di luce celeste. E lietamente, dopo avere lasciato
in quel luogo il figlio di Lico, spiegarono
al vento le vele, e corsero il mare guardando
i monti di Paflagonia. Ma non doppiarono il Capo Carambi
perché non cessarono i venti, né lo splendore del fuoco celeste,
finché non furono giunti alle grandi correnti dell'Istro.
I Colchi intanto, alcuni, cercandoli invano,
lasciarono il Ponto attraverso le rupi Cianee,
altri si diressero al fiume: Assirto, che li guidava,
tagliò di lato il percorso per la Foce Bella,
e dunque giunsero prima oltre il braccio di terra,
entrando nel golfo estremo del mare Ionio.
C'è un'isola infatti, chiusa dalle acque dell'Istro,
triangolare, che ha nome Peuce, e nel suo lato più largo
guarda alla costa, l'angolo è verso il fiume; perciò le acque
si dividono in due: da una parte
il nome è Nareco; dall'altra, in basso, la Foce Bella;
e in questa entrarono Assirto ed i Colchi,
più rapidi degli eroi, che passarono al largo,
oltre la punta dell'isola. Sugli umidi prati i pastori
lasciavano le ricche greggi, atterriti, come a vedere dei mostri
che uscivano fuori dal mare meraviglioso.
Prima, non avevano visto mai altre navi,
non gli Sciti misti ai Traci, non i Siginni,
non i Trauceni, e neppure i Sindi, che vivono ora
nella grande e deserta pianura attorno al Laurio.
Quand'ebbero oltrepassato il monte Anguro
e al di là dell'Anguro la roccia del Monte Cauliaco,
là dove l'Istro divide il suo corso e da due parti
si getta nel mare, e la pianura del Laurio,
i Colchi entrarono dentro il mare di Crono,
e bloccarono tutti i varchi, che non fuggissero.
Ed essi, dietro, scesero il fiume, ed arrivarono
alle vicine isole Brigie, sacre ad Artemide.
In una di esse aveva il suo tempio; ma per sfuggire
agli uomini di Assirto, gli eroi sbarcarono
nell'altra: quelle isole fra tutte quante
le trascurarono per rispetto alla figlia di Zeus, mentre le altre,
gremite di Colchi, bloccavano le vie del mare.
Ed anche nelle coste vicine alle isole Assirto aveva raccolto
[degli uomini,
fino al Salangone ed alla terra dei Nesti.
Qui, in una battaglia luttuosa, pochi contro moltissimi,
gli eroi sarebbero stati sconfitti; ma strinsero
un patto per evitare la guerra: il vello d'oro
apparteneva a loro, saldamente e a buon diritto;
lo stesso Eete l'aveva promesso se avessero superato
la prova; era loro, preso in qualsiasi maniera,
contro il volere del re, con l'inganno o agli occhi di tutti;
quanto a Medea, lì era tutto il conflitto:
sarebbe rimasta sola, senza di loro, presso la figlia di Leto,
finché qualcuno dei re che hanno il potere di fare giustizia
avesse deciso se doveva tornare alla casa del padre
[o alla ricca città del nobile Orcomeno]
o seguire gli eroi e andare in terra di Grecia.
Ma quando Medea ebbe pensato nella sua mente ogni cosa,
acuti dolori le scossero l'anima e non le davano
respiro. Subito chiamò Giasone, senza compagni,
in un luogo segreto, e guardandolo in viso
e singhiozzando gli disse queste parole:
"Figlio di Esone, quale progetto avete tramato
sopra di me? La fortuna ti ha forse tolto memoria
e non ti curi più di quanto dicevi una volta,
nella stretta della necessità? Dove sono finiti
i giuramenti in nome di Zeus protettore dei supplici,
dove le dolci promesse? Per quelle ho lasciato la patria,
contro l'uso, senza ritegno; ho lasciato la gloria della mia casa
e i genitori, e tutto quello che mi era più caro,
e sono partita lontano, sul mare, con i malinconici alcioni,
a causa delle tue imprese, perché tu compissi la prova
incolume contro i tori e gli uomini nati dal suolo.
E anche il vello hai preso, quando tutto è stato scoperto,
grazie alla mia follia, e a tutte le donne ho portato vergogna.
Per questo dico che ti seguirò in terra di Grecia,
come tua figlia, come tua sposa e sorella.
E tu dunque devi proteggermi con tutto il cuore, e non lasciarmi
sola, senza di te, a cercare non so che sovrano;
difendimi tu, senz'altro: e restino salvi
la giustizia e il diritto che entrambi abbiamo accettato.
Oppure tagliami in mezzo la gola con la tua spada, ma subito,
che per la mia passione io abbia il compenso dovuto.
Sciagurato! E se il re al quale affidate questo patto crudele
mi assegnerà a mio fratello, come potrò io giungere
davanti agli occhi del padre? Sì, certo, con molta gloria!
Quale castigo, quale tremenda sventura
dovrò mai soffrire per ciò che ho fatto,
mentre tu avrai il ritorno che tanto desideri?
No, non lo voglia la sposa di Zeus, la regina del mondo,
che tu vanti amica! E di me un giorno dovrai ricordarti,
quando sarai sfinito dai mali, e allora il tuo vello sparisca
simile ai sogni nell'Erebo, e dalla tua patria
presto le mie Erinni ti scacceranno, lo stesso che io ho sofferto
per la tua crudeltà. E ti dico che queste parole
non cadranno nel vuoto, poiché tu spietatamente
hai violato una sacra promessa: coi vostri patti
non resterete a lungo tranquilli, a schernirmi".
Così disse, e ribolliva di aspra collera; e desiderava
bruciare la nave, e distruggere tutto quanto,
e cadere essa stessa nel fuoco. Il figlio di Esone
ebbe paura, e le rispose così con dolci parole:
"Mia cara, calmati: neanche a me questo piace,
ma stiamo cercando di ritardare la guerra,
tanto è grande la nube dei nostri nemici che ci circondano,
e vogliono te. Tutti quelli che vivono in questa terra
sono pronti ad aiutare Assirto a riportarti
a tuo padre, a casa, come tu fossi una preda rapita.
Se combattiamo, avremo una fine luttuosa,
e sarà anche un dolore più grande, morendo,
lasciarti in mano loro. Però questo patto
compie un inganno col quale noi lo trarremo a rovina.
Le genti vicine non ci saranno più ostili
per fare sul tuo conto cosa gradita ai Colchi, quando
non ci sarà più il tuo fratello e tutore.
E neppure mi sottrarrò a combattere contro i Colchi,
faccia a faccia, se non mi daranno libero passo".
Così disse per addolcirla, e lei rispose una parola tremenda:
"Rifletti: è necessario, dopo le orribili cose compiute,
pensarne un'altra ancora: giacché sono stata accecata
e per volere divino ho compiuto azioni colpevoli,
tu pensa a difenderti dalle lance dei Colchi, in battaglia:
lui, sarò io a ingannarlo perché cada nelle tue mani.
Trattalo come amico, mandagli splendidi doni;
io cercherò di persuadere i suoi messi,
quando torneranno da lui, che devo parlargli
da solo a sola. E se a te così piace, non te lo impedisco,
uccidi, e dopo attacca battaglia con le genti di Colchide".
E insieme, d'accordo, ordirono un grande inganno
contro Assirto; gli offrirono molti doni ospitali
e tra essi anche la tunica sacra d'Issipile,
purpurea. La tesserono un tempo le Cariti,
per Dioniso, all'isola Dia, e Dioniso ne fece dono
più tardi al figlio Toante, e Toante la lasciò a Issipile,
e lei la diede a Giasone, splendido dono ospitale,
insieme a molti altri. Mai non avresti saziato
il desiderio soave di vederla e toccarla con mano;
perché restava in essa un profumo immortale,
da quando vi aveva dormito il signore di Nisa,
inebriato dal vino e dal nettare, tenendo stretto
il bel corpo di Arianna, che aveva seguito Teseo
da Cnosso, e l'eroe l'aveva lasciata nell'isola Dia.
Quando ebbe fatto il suo discorso ai messaggeri,
e li ebbe convinti a farlo venire, appena lei fosse giunta
nel tempio secondo il patto, e la notte avesse disteso
le sue nere tenebre (avrebbero insieme pensato un inganno,
così da prendere il grande vello d'oro, e tornare
alla casa di Eete; a forza i figli di Frisso
l'avevano consegnata in preda a quegli stranieri);
dopo queste parole ingannevoli, diffuse i filtri
incantati nell'aria, nel soffio dei venti, filtri capaci
d'attirare una fiera da lontano, dall'alto dei monti.
Funesto amore, grande sventura, abominio degli uomini:
da te nascono le contese mortali, i gemiti ed i travagli,
e ancora si agitano infiniti dolori.
Sui figli dei miei nemici vieni armato, signore,
quale gettasti nell'animo di Medea l'odiosa rovina.
In che modo diede ad Assirto, che si recava da lei,
una morte atroce? Questo adesso deve narrare il mio canto.
Dopo che secondo i patti la lasciarono al tempio
di Artemide, si divisero ed approdarono, ognuno
con la propria nave: Giasone si dispose in agguato,
attendendo Assirto e poi i suoi compagni.
Assirto, ingannato dalle più atroci promesse,
s'affrettò ad attraversare il mare per nave,
e nella notte, nel buio, sbarcò sull'isola sacra;
andò solo di fronte alla sorella, e prese a saggiarla con le parole,
come fa un dolce bambino con un torrente
che neppure gli uomini forti si arrischiano ad attraversare,
chiedendole se aveva pensato all'inganno per gli stranieri.
Si accordarono l'uno con l'altra su tutti i punti;
e all'improvviso il figlio di Esone balzò dallo scaltro agguato,
con in mano la spada nuda. Medea distolse
subito gli occhi, coprendosi con il velo,
per non vedere il fratello colpito ed ucciso.
Giasone, come fa il macellaio con un toro dalle ampie corna,
colpì: l'aveva spiato nei pressi del tempio di Artemide,
che una volta costruirono in suo onore le genti Brigie,
le quali vivevano nella terra di fronte. L'eroe cadde in ginocchio
nel vestibolo; e all'ultimo, mentre esalava il respiro,
raccolse con ambo le mani il nero sangue della ferita
e, mentre lei si schermiva, le arrossò il bianco velo ed il peplo.
Ma con occhio acuto ed obliquo, l'Erinni spietata, signora del mondo,
vide l'orrenda azione che i due avevano fatto.
L'eroe figlio di Esone tagliò le estremità del cadavere,
leccò tre volte il sangue e tre volte sputò la macchia del sacrilegio,
come vuole il rito che gli omicidi espiino la morte data con frode.
Poi nascose sottoterra il morto, tiepido ancora,
là dove ancor oggi giacciono fossa, in mezzo ai popoli Assirti.
Gli altri intanto avevano visto la fiamma del fuoco,
che Medea aveva levato in alto come segnale
per farli venire, e lanciarono la loro nave
contro quella dei Colchi, e li uccisero come gli sparvieri
uccidono gli stormi delle colombe, oppure i selvaggi leoni,
piombati dentro le stalle, un grosso gregge di pecore.
Nessuno di quelli sfuggì alla morte; come il fuoco, assalirono
l'intero stuolo, e lo massacrarono. Giasone li raggiunse più tardi
desideroso di dare il suo aiuto, ma non ne avevano alcun bisogno,
e invece già cominciavano a preoccuparsi per lui.
Sedettero, e pensarono a prendere il miglior consiglio
per il viaggio, e Medea venne a partecipare ai loro discorsi.
Peleo, primo fra tutti, disse queste parole:
"Penso che dobbiamo imbarcarci subito, mentre è ancor notte,
e procedere a remi, all'opposto di dove i nemici
sorvegliano. All'alba, quando sapranno ogni cosa,
non credo che si troveranno concordi,
che si persuadano ad inseguirci più oltre;
senza più il loro capo saranno divisi
da aspre contese, e se si dividono, allora
sarà facile per noi la via, quando ritorneremo".
Così disse, ed i giovani approvarono il figlio di Eaco.
Salirono subito in nave, e fecero forza sui remi,
senza tregua, finché arrivarono all'isola sacra di Elettride,
ultima fra tutte, accanto al corso dell'Eridano.
Quando i Colchi s'accorsero della morte del loro signore,
si lanciarono per tutto quanto il mare Cronio,
alla ricerca di Argo e dei Minii, ma li trattenne
Era, scagliando terribili lampi dal cielo.
Alla fine, ripudiarono le loro case in terra Citea,
temendo l'ira selvaggia del loro signore,
e stabilirono la propria dimora in quei luoghi.
Sbarcarono chi qua chi là, nelle medesime isole
degli eroi, e ancora vi abitano, e portano il nome di Assirto;
altri sulle rive del nero profondo fiume d'Illiria,
dov'è la tomba di Cadmo ed Armonia, e vi costruirono una fortezza
nel paese degli Enchelei; altri ancora vivono sulle montagne
che sono dette Ceraunie, i monti del fulmine,
dal momento in cui le folgori di Zeus, il figlio di Crono,
impedirono loro di passare nell'isola che sta di fronte.
Gli eroi, quando il ritorno parve senza pericoli,
procedettero innanzi, e gettarono a terra le gomene
nel paese degli Illei: sporgevano fitte le isole,
lasciando ai naviganti, in mezzo, un passaggio rischioso.
Gli Illei non erano più, come prima, nemici,
anzi facilitarono loro la strada, e ne ebbero
in ricompensa il grande tripode di Febo Apollo.
Il dio aveva donato due tripodi a Giasone, da portare lontano
nel viaggio che gli veniva imposto di compiere,
quando si recò a Pito sacra, per consultarlo
sulla navigazione. Era destino che la terra dove
fossero stati fissati non sarebbe mai stata distrutta
da armi nemiche. E per questo motivo ancor oggi
il tripode è nascosto, profondamente fissato nel suolo,
presso la bella città degli Illei, invisibile agli uomini.
Là non trovarono ancora in vita il re Illo,
che la bella Melite partorì ad Eracle in terra feacia.
Eracle giunse infatti alla corte di Nausitoo e presso Macride,
la nutrice di Dioniso, per purificarsi dell'uccisione
orrenda dei figli, e s'innamorò di Melite,
figlia del fiume Egeo, e la possedette,
ed essa diede alla luce il fortissimo Illo.
Quando fu cresciuto, non volle più vivere
nell'isola, sottomesso allo sguardo del re Nausitoo,
e andò nel mare di Crono, con un gruppo di nativi Feaci
che aveva raccolto. Lo stesso sovrano dispose
il suo viaggio. Si stabilì colà; e lo uccisero i Mentori,
mentre cercava di difendere le sue mandrie nei campi.
Ma ditemi, Muse, perché al di là del mare, attorno
[alla terra Ausonia,
alle isole Ligustidi, cui danno il nome di Stecadi,
restano in gran numero e chiari i segni di Argo?
Quale necessità, o bisogno, li portò tanto lontano?
Quali venti li condussero verso quei luoghi?
Ucciso Assirto, un'ira terribile prese Zeus, il re degli dei.
Cosa avevano fatto! E decretò che soltanto dopo essersi
purificati del sangue maledetto per mano di Circe,
ed avere sofferto innumerevoli pene, soltanto allora
avrebbero avuto il ritorno. Ma nessuno di loro
lo seppe; correvano via dalla terra Illea,
e si lasciavano dietro tutte le isole Liburnie,
già occupate dai Colchi, l'una di seguito all'altra:
Issa e Discelado e la bella Pitiea.
Dopo di esse, arrivarono a Corcira, dove il dio Poseidone
collocò la figlia di Asopo, Corcira dai bei capelli,
che per amore aveva rapito dalla città di Fliunte,
e i marinai che da lontano, sul mare, la vedono,
annerita da tutte le parti da una buia foresta,
la chiamano Corcira Nera. Poi costeggiarono Melite,
godendo di un vento leggero, e l'alta Cerosso,
e, più lontano, Ninfea, là dove viveva
la figlia di Atlante, la potente Calipso;
e già sembrava loro di scorgere dentro la nebbia
i monti Cerauni, quando Era comprese
i disegni di Zeus, e la sua collera immensa.
Preoccupata per il compimento del viaggio, suscitò le tempeste
contro di loro, e, in preda a quelle, furono ancora portati
alla rocciosa isola Elettride. Qui, all'improvviso,
mentre avanzavano, parlò con voce umana un legno
[della concava nave,
che Pallade Atena ricavò da una quercia a Dodona,
e lo collocò nel mezzo della carena.
Un terrore angoscioso li prese nell'udire la voce,
e la grande ira di Zeus. La voce diceva
che non sarebbero mai sfuggiti alle pene
del mare infinito, né alle tempeste terribili,
se Circe non li purificava dalla feroce uccisione di Assirto.
A Castore ed a Polluce ordinava di supplicare gli dei immortali
che aprissero loro la strada del mare Ausonio, dove dovevano
trovare la maga Circe, figlia di Perse e del Sole.
Così gridò Argo quando calava la sera. I Tindaridi
si alzarono in piedi, e stendendo le mani agli dei immortali,
pronunciarono la preghiera punto per punto, ma l'abbattimento
prese gli altri Minii. La nave era corsa lontano
a vela: entrarono profondamente nel corso del fiume Eridano,
là dove un tempo Fetonte, colpito al cuore dal fulmine ardente,
e bruciato a metà, cadde dal carro del Sole
nelle acque di questa profonda palude, ed essa ancor oggi
esala dalla ferita bruciante un tremendo vapore:
nessun uccello può sorvolare quelle acque
spiegando le ali leggere, ma spezza il suo volo
e piomba in mezzo alle fiamme. Intorno, le giovani
Eliadi, infelici, mutate negli alti pioppi,
effondono tristi lamenti, e dai loro occhi
versano al suolo le gocce d'ambra splendente.
Le gocce si asciugano sopra la sabbia ai raggi del sole,
e quando le acque della nera palude tracimano
a riva, sotto il soffio sonoro del vento,
rotolano tutte insieme verso l'Eridano
e i suoi flutti agitati. I Celti hanno inventato una storia,
che sono le lacrime del dio Apollo, il figlio di Leto,
a formare i vortici, lacrime sparse un tempo, infinite,
quando giunse al popolo sacro degli Iperborei
e lasciò il cielo splendente per le minacce del padre,
irato a causa del figlio che gli partorì Coronide,
nella splendida Lacerea, presso le rive del fiume Amiro.
Questo è ciò che si racconta tra quegli uomini.
Gli eroi non avevano voglia di bere né di mangiare;
la loro mente non andava ai piaceri. Durante il giorno
giacevano affranti, sfiniti dall'odore cattivo
che mandavano le correnti dell'Eridano dal corpo
riarso di Fetonte, intollerabile; e poi la notte
sentivano i gemiti acuti, il triste lamento
delle Eliadi. E le lacrime delle Eliadi correvano
sopra le acque, come fossero gocce di olio.
Di là entrarono nel profondo corso del Rodano,
che si getta nell'Eridano, e nel confluire le acque
rimbombano e ribollono. Questo fiume nasce agli estremi
confini del mondo, dove sono le porte e le sedi
della Nyx, e di là si riversa da un lato
alle coste d'Oceano, da un altro nel mare Ionio,
da un altro ancora nel mare sardo, nel suo golfo immenso
con sette bocche. Usciti dal fiume, avanzarono
nei laghi tempestosi, che si stendono all'infinito
per le terre dei Celti. Qui avrebbero avuto
una sorte infelice: giacché uno dei bracci
portava in un golfo d'Oceano e, senza saperlo,
stavano per entrarvi, e non ne sarebbero usciti a salvamento.
Ma Era, scesa dal cielo, gridò dalla rupe Ercinia:
tutti furono scossi dal terrore a quel grido,
il grande etere ebbe un tremendo rimbombo.
Per ordine della dea tornarono indietro, e capirono
quale era la via per la quale si apriva loro il ritorno.
Dopo un lungo cammino giunsero alle rive del mare,
passando incolumi per volere di Era in mezzo ai mille popoli
dei Celti e dei Liguri: la dea aveva diffuso
attorno a loro una grande nebbia per tutti i giorni del viaggio.
Passarono con la nave attraverso la bocca centrale
e sbarcarono alle isole Stecadi, salvi grazie all'aiuto
dei figli di Zeus: perciò dedicarono ad essi altari e sacrifici,
che hanno valore per sempre; né questo solo viaggio seguirono
benevolmente, ma Zeus affidò loro anche le navi dei posteri.
Lasciate poi le Stecadi, passarono all'isola Etalia
dove, sfiniti, detersero il copioso sudore con delle pietruzze;
molte simili ci sono ancora su quella spiaggia
e così pure i dischi, e altri resti illustri dei Minii,
là dove il porto ha preso il nome di Argo.
Rapidamente avanzarono sulle acque del mare Ausonio,
e furono in vista delle coste tirreniche.
Giunsero poi al porto di Eea, e gettarono
a terra le gomene. Qui trovarono Circe
che purificava il capo con l'acqua marina,
a tal punto era stata sconvolta dai sogni notturni.
Le era parso che tutti i muri e le stanze della sua casa
grondassero sangue, e le fiamme inghiottivano i filtri
coi quali prima incantava ogni straniero che veniva da lei,
e lei stessa con le mani attingeva a quel sangue
e spegneva le fiamme; così cessò il terrore mortale.
Perciò al risveglio, al sorgere dell'aurora,
essa lavava i capelli e le vesti nel mare.
E con lei mostri, non simili a fiere selvagge,
e neanche ad uomini, misti di membra diverse,
venivano in massa, così come un gregge di pecore,
lascia le stalle, tenendo dietro al pastore.
Già in passato la terra aveva fatto fiorire dal fango
esseri come questi, fatti di membra commiste,
quando ancora non era condensata dall'aria secca
e non le avevano ancora tolto l'umido i raggi
prosciuganti del sole: poi mise ordine il tempo, distribuendoli
in specie. Ma allora avevano forma indicibile i mostri
che la seguivano, e uno stupore grandissimo prese gli eroi.
Subito ognuno di loro, guardando negli occhi e nella figura di Circe,
capì facilmente che era sorella di Eete.
Quand'ebbe cacciati i timori del sogno notturno,
tornò subito indietro e ordinò di seguirla,
con un gesto affettuoso, ma pensava all'inganno.
Lo stuolo d'eroi rimase lì fermo, indifferente,
per ordine di Giasone, che prese con sé la fanciulla di Colchide:
entrambi seguirono Circe per la sua strada
finché giunsero alla casa. Allora li fece sedere
su ricchi seggi, e si chiedeva il perché della loro venuta.
Muti, senza parole, si slanciarono sul focolare
e vi sedettero, come è costume dei miserabili supplici:
lei poggiava la fronte su ambo le mani,
e Giasone piantò per terra la grande spada,
che aveva ucciso il figlio di Eete: né l'uno né l'altra
osava alzare gli occhi. Circe comprese
la loro sorte di esuli, e l'orrendo delitto.
Perciò rispettando la legge di Zeus, protettore dei supplici,
che colpisce gli assassini, ma anche dà loro soccorso,
compì il sacrificio nel quale i colpevoli supplici
sono purificati, quando s'accostano al focolare.
In espiazione della morte irreparabile,
tenne alto sopra di loro un porcellino (la madre
aveva ancora le mammelle gonfie dal parto), e gli tagliò il collo,
immerse le loro mani nel sangue, e con libagioni
e con preghiere placò Zeus, il dio che purifica,
che soccorre gli omicidi, che rispetta le suppliche.
I rifiuti li portarono fuori di casa
le ancelle Naiadi, che la servivano in tutto;
ed essa intanto bruciava, accanto al focolare,
focacce e libagioni senza vino, pregando
che le terribili Erinni smettessero la loro collera,
e Zeus stesso potesse sorridere ed essere
benigno ai due supplici, fossero le loro mani
macchiate di sangue straniero, o di parenti.
Quando ebbe compiuto ogni cosa, li fece alzare
e sedere su seggi ben levigati, e sedette essa stessa vicino,
in faccia a loro. Subito li interrogava,
punto per punto, sui motivi del loro viaggio;
da dove e perché venivano alla sua terra e alla sua casa,
e s'accostavano al focolare. Il ricordo del sogno
s'insinuava atroce nel suo cuore sconvolto,
e desiderava sentire dalla fanciulla la voce del suo paese,
da quando la vide alzare lo sguardo da terra.
La stirpe del Sole si riconosceva ben chiara dal lampo
degli occhi, che tutti loro mandavano
lontano, e brillava come la luce dell'oro.
Alle domande, la figlia del terribile Eete
raccontò tutto, parlando soavemente la lingua dei Colchi,
il viaggio, la strada percorsa dagli eroi e quanto soffrirono
nelle aspre prove, e come per le ansie di sua sorella
aveva commesso là colpa, e come, coi figli di Frisso,
fuggì lontano dal feroce terrore
del padre. Tacque l'uccisione di Assirto,
che pure non restò nascosta alla mente di Circe,
ma tuttavia ebbe pietà del suo pianto e le disse:
"Sciagurata, un viaggio funesto e vergognoso
è quello che hai intrapreso, e non credo che sfuggirai
[lungo tempo
all'ira di Eete: verrà anche in terra di Grecia
presto, per vendicare la morte del figlio. Hai compiuto
un'azione orribile. Ma poiché vieni da me, mia supplice
e mia parente, non ti farò nessun altro male;
ma vattene da questa casa, insieme allo straniero
che hai scelto contro la volontà di tuo padre.
E non abbracciarmi i ginocchi accanto al focolare;
io non approvo le tue decisioni e la tua disonorevole fuga".
Così disse: un tremendo dolore prese Medea: sollevò il peplo
sugli occhi e piangeva, finché l'eroe la prese per mano
e la condusse fuori, scossa dallo sgomento:
in questo modo lasciarono la dimora di Circe.
Ma non sfuggirono alla sposa di Zeus, giacché Iride
glielo disse, quando li vide lasciare la sala;
la dea aveva ordinato di sorvegliarli
nel ritorno verso la nave, e le diede questi altri comandi:
"Iride cara, se mai in passato hai eseguito i miei ordini,
orsù, corri da Teti con le rapide ali,
dille che esca dal mare e si presenti da me:
ho bisogno di lei. Poi recati subito
sulle rive dove i duri martelli di Efesto
battono sulle incudini, e digli di addormentare
i soffi del fuoco, fino a che Argo non abbia
attraversato quel luogo. Poi va da Eolo,
Eolo il signore dei venti, nati dall'etere;
e anche a lui di' la mia volontà, che s'arrestino
tutti i venti nell'aria, e che nessuna brezza perturbi
il mare, ma soffi il solo Zefiro, finché saranno
giunti all'isola dei Feaci, la terra di Alcinoo".
Così disse: subito Iride balzava giù dall'Olimpo,
e fendeva l'aria stendendo le ali leggere.
Entrò nel mare Egeo, dove sono le case di Nereo,
e subito andò da Teti e le parlò secondo il comando
di Era, e le ingiunse di andare presto da lei.
Poi si recò nell'officina di Efesto,
e fece tacere i martelli di ferro e fermare i soffi
ardenti di fuoco. Infine andò da Eolo, l'illustre
figlio di Ippota. Mentre anche a lui riferiva
il messaggio di Era e riposava i veloci ginocchi,
Teti lasciava Nereo e le sorelle, e usciva dal mare
per recarsi da Era in Olimpo. La dea la fece sedere
accanto a sé e le disse queste parole:
"Ascolta, divina Teti, quello che voglio dirti.
Sai quanta stima nutre il mio cuore per il figlio di Esone,
e per gli altri che gli sono compagni in quest'impresa:
† io li ho salvati † nel passaggio attraverso le Plancte
dove ruggono orrende tempeste di fuoco ed i marosi
schiumano sugli aspri scogli. Ma adesso
li attende una strada tra la grande rupe di Scilla
e Cariddi, che manda uno spaventoso muggito.
Ora, quand'eri bambina io t'ho educata e t'ho amata
più di tutte le altre dee che vivono in mare,
perché non hai voluto l'amore di Zeus che ti desiderava
- sempre gli interessano queste cose, fare l'amore
con donne, non importa che siano dee o mortali.
Ma tu, per rispetto verso di me e per timore,
gli sei sfuggita, e lui allora giurò il giuramento più grande
che non saresti mai stata la sposa di un immortale.
Non smise però di spiarti, contro tua voglia,
fino a quando la venerabile Temi non gli disse ogni cosa:
era destino che tu avresti dato alla luce
un figlio più forte del padre; così rinunciò alle sue voglie,
temendo che un altro regnasse al suo posto sugli immortali,
e lui per sempre voleva proteggere il suo potere.
Ma io ti ho dato per sposo il migliore degli uomini
perché avessi nozze gradite, e partorissi
dei figli; al banchetto ho invitato tutti gli dei,
e io stessa reggevo la fiaccola, in ricompensa
dell'onore e dell'affetto che mi avevi donato.
Orsù, ti voglio dire una parola infallibile:
quando tuo figlio arriverà ai campi Elisi,
quello che ora allevano senza il tuo latte
le Ninfe Naiadi presso il centauro Chirone
- il suo destino è di sposare la figlia
di Eete, Medea. E dunque, soccorri tua nuora
ed anche Peleo. Perché tanta ira tenace?
Sì, è stato cieco, ma l'accecamento prende perfino
gli dei. Sono certa che per mio ordine Efesto
smetterà di ardere il fuoco, e il figlio di Ippota,
Eolo, tratterrà i rapidi soffi dei venti,
eccetto il costante Zefiro, finché giungeranno
ai porti Feaci. Tu pensa a dare loro un viaggio sicuro:
il solo pericolo sono le rocce, e gli immensi marosi,
che devi evitare, assieme alle tue sorelle.
Non lasciare che, senza saperlo, si gettino dentro a Cariddi,
che li inghiottirebbe, li porterebbe via tutti quanti;
e neppure che passino accanto all'odioso antro di Scilla,
la terribile Scilla ausonia, figlia di Forco
e della notturna Ecate, che chiamano anche Crataide:
balzerebbe addosso a loro con le tremende mascelle
e ucciderebbe i migliori. Tieni tu dunque la nave
dove si trova, stretta, la via di scampo alla morte".
Così disse, e a lei Teti rispose con queste parole:
"Se davvero si fermeranno la furia del fuoco vorace
e le feroci tempeste, allora posso essere certa
di salvare la nave dall'assalto delle onde,
purché Zefiro soffi lieve. Ma è tempo
di mettersi in strada: una strada lunghissima
se debbo andare a ritrovare le mie sorelle
che mi verranno in aiuto, e poi dove Argo è ormeggiata,
perché all'alba riprendano il loro viaggio".
Disse, e balzò giù dal cielo, nei vortici
del mare azzurro. Chiamò le sorelle in aiuto
le figlie di Nereo: udirono la sua voce
e si radunarono. Teti riferì gli ordini
di Era, e le mandò tutte nel Mare Ausonio.
Lei stessa, più rapida del baleno, del raggio
di sole quando si leva sull'orizzonte,
si slanciò in mezzo alle acque, finché fu giunta
alla terra Tirrena, alla spiaggia di Eea.
Li trovò accanto alla nave, che si divertivano
a lanciare il disco, e le frecce, e si fece loro vicino
sfiorando la mano di Peleo - era pure il suo sposo!
Senza che nessun altro potesse vederla,
si mostrò a lui solo e gli parlò in questo modo:
"Non restate più a lungo, qui, sulle coste tirreniche;
all'alba sciogliete le gomene della nave veloce
obbedendo a Era, che veglia su voi. Per suo comando
sono corse in folla le Ninfe Nereidi,
e proteggeranno la nave, attraverso le rupi
che chiamano Plancte: è quello il cammino segnato.
Ma tu non indicare la mia persona a nessuno
quando mi vedrai giungere con le sorelle: tienilo a mente
e non irritarmi più di quanto hai fatto una volta, senza riguardo".
Disse, e sparì invisibile negli abissi del mare.
Lui, lo prese un tremendo dolore: non l'aveva più vista
da quando una volta lasciò la sua casa e il suo letto,
irata per il glorioso Achille, che era ancora bambino.
Essa bruciava alla fiamma del fuoco le carni
mortali in piena notte: poi, durante il giorno,
ungeva d'ambrosia il tenero corpo, perché divenisse
immortale e gli stesse lontana l'odiosa vecchiaia.
Ma Peleo, balzato dal letto, vide suo figlio
agitarsi in mezzo alle fiamme e mandò un grido
terribile a quella vista. Sciocco, sciocco davvero:
uditolo, Teti gettò di colpo per terra il bambino
piangente e, simile ad un soffio o ad un sogno,
lasciò veloce la casa e s'immerse nel mare
adirata; né più da allora tornò sui suoi passi.
Lo sconforto gli legò il cuore; ma nondimeno
disse ai compagni tutti i comandi di lei.
Allora subito gli eroi interruppero i loro giochi
e si prepararono il pasto e il letto, dove dormirono
dopo avere mangiato, com'erano usi.
Quando l'aurora che portala luce toccò l'orizzonte.
e su di loro scendeva lieve il soffio di Zefiro,
salirono sopra i banchi e tirarono le ancore
lietamente dal fondo del mare, e arrotolarono insieme
gli attrezzi secondo il bisogno e levarono in alto
la vela, e con le scotte la tesero all'albero.
Un vento propizio spingeva la nave, e ben presto
furono in vista di Antemoessa, l'isola bella
dove le melodiose Sirene, figlie dell'Acheloo,
incantano e uccidono col loro canto soave
chiunque vi approdi. Le partorì ad Acheloo
la bella Tersicore, una Musa; un tempo servivano
la grande figlia di Deo, quando ancora era vergine,
e cantavano insieme; ma ora sembravano
in parte uccelli, in parte giovani donne.
E stando sempre in agguato al di sopra del porto,
tolsero a molti, consumandoli nel languore,
il dolce ritorno. E anche per loro, senza esitare
mandavano l'incantevole voce, e quelli già stavano
per gettare a terra le gomene, se il figlio di Eagro,
il tracio Orfeo, non avesse teso nelle sue mani
la cetra bistonica, e intonato un canto vivace,
con rapido ritmo, in modo che le loro orecchie
rimbombassero di quel rumore, e la cetra
ebbe la meglio sulla voce delle fanciulle;
Zefiro e l'onda sonora che spingeva da poppa
portavano avanti la nave, e le Sirene mandavano suoni indistinti.
Ma anche così uno di loro, il nobile figlio di Teleonte,
Bute, fu lesto a saltare in acqua dal banco,
preso dalla voce soave delle Sirene, e nuotava
attraverso le onde agitate per giungere a riva,
infelice! Subito le Sirene gli avrebbero tolto il ritorno,
ma Afrodite, la dea protettrice di Erice, ebbe pietà:
gli venne incontro benigna, lo salvò strappandolo ai gorghi,
e gli assegnò il promontorio di Lilibeo per dimora.
Gli eroi si allontanarono afflitti, ma altre cose più dure
li aspettavano, altre minacce alla nave sul quadrivio del mare.
Da un lato sporgeva lo scoglio liscio di Scilla,
dall'altro rumoreggiava Cariddi con scrosci infiniti;
altrove ruggivano, sotto gli enormi marosi, le Plancte,
e là dove prima era scaturita la fiamma
dalla cima degli scogli, sopra la roccia infuocata,
l'aria era scura dal fumo e non si vedevano
i raggi del sole. E anche allora, sebbene Efesto
avesse smesso il lavoro, il mare esalava un caldo vapore.
Da tutte le parti arrivavano le Nereidi:
e la divina Teti, da dietro, prese il timone
per guidare la nave in mezzo alle Plancte.
Come quando nel tempo sereno i delfini
girano in branco attorno a una nave in cammino
e si mostrano ora davanti, ora di dietro
e di fianco, e allietano i marinai,
così le Ninfe correndo giravano in folla
intorno ad Argo, e Teti dirigeva la rotta.
Quando già stavano per toccare le Plancte,
alzarono sulle bianche ginocchia le vesti,
e, dividendosi dall'una parte e dall'altra,
balzarono sopra le rocce e sulla cresta dell'onda.
La corrente investiva Argo di fianco, e attorno i violenti marosi,
levandosi in alto, s'infrangevano contro le rupi,
ed esse ora s'innalzavano al cielo come montagne,
ora stavano giù, sommerse dentro il profondo,
e si stendeva su loro l'enorme onda selvaggia.
Come fanciulle che sulla riva del mare,
con le tuniche avvolte sui fianchi, giocano a palla
e la ricevono l'una dall'altra, e la mandano
in alto, senza toccare mai terra, a questo modo
ora l'una ora l'altra spingevano in corsa
la nave alta sopra le onde e sempre lontana
dalle terribili rupi; attorno a loro
ribollivano l'onde muggendo. Anche il dio Efesto
stava ritto in piedi. a guardarle dall'alto
della montagna scoscesa, appoggiando la spalla robusta
sul manico del martello, e dal cielo lucente
anche la sposa di Zeus, abbracciata ad Atena:
tale fu il terrore che, a quella vista, la colse.
Di quanto tempo s'allunga la giornata di primavera,
altrettanto le Ninfe faticarono a far uscire la nave
dalle rupi; poi ebbe vento propizio e corse in avanti.
Presto costeggiarono i prati della Trinacria
dove sono allevate le vacche del sole.
Le figlie di Nereo, compiuti i comandi di Era,
s'immersero nel profondo come gabbiani:
giungeva per aria il belato delle pecore e insieme
colpivano le orecchie dei naviganti i muggiti.
Portava le pecore al pascolo sui prati umidi per la rugiada
Faetusa, la più giovane tra le figlie del Sole,
che nella mano teneva una verga d'argento;
Lampezia scuoteva dietro le mandrie un bastone
d'oricalco splendente. Le videro pascolare
presso le acque del fiume, nei prati e nella piana
paludosa. Nessuna di loro era di pelo nero:
tutte, candide come il latte, portavano
corna d'oro superbe. Durante il giorno,
costeggiarono l'isola; poi, durante la notte,
navigarono al largo lieti, fino a quando l'aurora
sorgendo al mattino ridiede la luce ai naviganti.
C'è davanti allo stretto Ionio, in mezzo al mare Ceraunio;
un'isola vasta e feconda dove, si dice, è interrata la falce
- perdonatemi, Muse, malvolentieri riporto il racconto
degli antichi - con la quale Crono recise i genitali del padre
spietatamente; invece altri dicono che con quella falce
Deo, la dea della terra, mieteva il raccolto:
Deo abitava in quei luoghi, e, per amore di Macride,
insegnò ai Titani a cogliere la ricca messe
del frumento: per questo motivo porta il nome di Drepane;
che significa "falce", la sacra terra che nutre i Feaci;
e i Feaci stessi sono del sangue d'Urano.
Presso di loro Argo, trattenuta dai molti disagi,
arrivò finalmente, spinta dai venti sul mare della Trinacria.
Il re Alcinoo e il suo popolo li accolsero amichevolmente
con sacrifici, e per loro la città tutta si diede alla gioia:
avresti detto che facevano festa per i loro figli.
Ed anche gli eroi erano lieti in mezzo alla folla,
come fossero giunti nel cuore della Tessaglia.
Eppure dovettero prepararsi a combattere,
perché apparve vicino un immenso esercito: erano i Colchi
che, alla caccia degli eroi, avevano attraversato
le bocche del Ponto e le rupi Simplegadi
e venivano a chiedere senza indugi Medea
per riportarla al padre, o avrebbero dato
battaglia sanguinosa, implacabile, adesso
e poi ancora più tardi, all'arrivo di Eete.
Ma pure bramosi di guerra com'erano,
il re Alcinoo li trattenne: voleva tra le due parti
sciogliere senza guerra la dura contesa.
Ma la fanciulla, in preda a un disperato terrore,
spesso tornava a pregare i compagni di Giasone
e spesso abbracciava i ginocchi di Arete, la sposa di Alcinoo:
"Regina, ti supplico: abbi pietà di me; non mi consegnare
ai Colchi che mi riportino da mio padre, se tu pure appartieni
alla stirpe degli uomini, che hanno una mente
che corre veloce alla rovina per leggerezza
ed errore. Anch'io per questo sono caduta,
non per lussuria. Mi sia testimone la sacra luce del Sole
ed i misteri notturni di Ecate, che non per mio volere
sono partita di là, assieme a quegli stranieri:
un'atroce paura mi ha persuasa a questa fuga,
quando avevo sbagliato e non c'era più altro
rimedio. Ma ancora resta intatta, inviolata
la mia cintura, com'era in casa del padre. Abbi pietà
di me, mia signora, e persuadi il tuo sposo;
possano darti gli dei immortali una lunga vita
e gioia e figli e la gloria di un regno invincibile".
Così supplicava la regina Arete piangendo;
e poi, uno per uno, così pregava gli eroi:
"Per causa vostra, grandissimi eroi, e per causa
delle vostre imprese io sono in preda all'angoscia.
Fu per opera mia che avete aggiogato i tori e mietuto
la terribile messe degli uomini nati dal suolo,
e per opera mia tornerete presto in Tessaglia col vello d'oro.
Ma io ho perduto i genitori e la patria,
e la casa e tutta la gioia della mia vita,
io che a voi ho ridato la patria e la casa;
voi rivedrete con la dolcezza negli occhi i genitori,
a me un destino crudele ha tolto la gioia
e vado errando odiata in compagnia di stranieri.
Abbiate timore dei patti e dei giuramenti
e dell'Erinni dei supplici e della giustizia divina,
se cadrò nelle mani di Eete, e avrò morte oltraggiosa e tremenda.
Non guardo a templi, a fortezze che mi difendano,
a nessun altro che a voi. Sciagurati, crudeli,
senza pietà: nel vostro cuore non avete vergogna
a vedermi tendere disperata le mani
alle ginocchia d'una regina straniera; però per prendere il vello
eravate pure disposti a combattere contro i Colchi,
contro lo stesso possente Eete; ed ora avete scordato
il vostro coraggio, ora che sono pochi e isolati".
Così pregava; e tutti, uno per uno, la confortavano,
e cercavano di calmare il suo dolore; brandendo
le lance aguzze e sguainando le spade dal fodero,
promisero che non le avrebbero fatto mancare
il loro aiuto, se avesse subito un'ingiusta sentenza.
Mentre lei si struggeva, su di loro discese
la Nyx pacificatrice, ed addormentava
tutta la terra. Ma lei neppure un momento
la prese il sonno: s'agitava nel petto il cuore sconvolto,
come quando una povera donna fa girare il fuso
di notte - le è morto il marito e attorno piangono
i figli orfani e le lacrime colano
per le guance, pensando alla sua sorte infelice -:
così le guance di Medea si bagnavano e il cuore
si torceva trafitto dalle acutissime pene.
Intanto in città, stando, come sempre, nella loro casa,
il re Alcinoo ed Arete, la sua venerata
consorte, si consultavano attorno a Medea,
a letto, durante la notte; e la regina Arete
pregava così il suo sposo con calde parole:
"Sì, mio caro, ti prego, difendi dai Colchi la sventurata
fanciulla, fa' cosa gradita ai Minii. La città d'Argo
ed i Tessali sono vicini alla nostra isola;
mentre Eete è lontano: neppure lo conosciamo,
solo ne abbiamo sentito parlare. L'infelice Medea
mi ha spezzato il cuore con le sue suppliche: non consegnarla,
signore, ai Colchi che la riportino al padre.
Ha sbagliato quando ha dato a Giasone il filtro
per i tori; e, come spesso facciamo nei nostri sbagli,
ha voluto sanare un male con un altro male,
ed è fuggita dall'ira pesante del suo terribile padre.
Ma a quel che so, Giasone è impegnato coi giuramenti più grandi
a prenderla nella sua casa come sposa legittima.
Perciò, mio caro, non essere tu di tua volontà a fare spergiuro
il figlio di Esone, e non permettere che abbandonandosi all'ira
un padre colpisca orribilmente la figlia.
Verso le figlie i padri sono troppo severi,
come lo fu Nitteo con la bella Antiope,
o come Danae che per la ferocia del padre
soffrì tante pene sul mare; e poco fa, non lontano,
il superbo Echeto fece piantare aghi di bronzo
negli occhi alla figlia e ora la consuma un triste destino
in un carcere oscuro, macinando grani di bronzo".
Così diceva e pregava; il re fu commosso
dalle sue parole, e le diede questa risposta:
"Ben volentieri, Arete, scaccerei con le armi i Colchi,
facendo cosa grata agli eroi per la fanciulla.
Ma temo di violare la retta giustizia di Zeus;
e non è utile trascurare Eete, come tu suggerisci.
Nessuno è più regale di Eete, e se volesse,
per quanto lontano sia, potrebbe muovere guerra alla Grecia.
Ho deciso di fare giustizia nel modo che appaia
il migliore, e non te lo voglio tenere nascosto.
Se Medea è ancora vergine, la farò riportare
a suo padre, ma se divide il letto di Giasone,
non la strapperò al marito, non darò ai suoi nemici
il bambino che custodisce forse nel grembo".
Così disse, e subito il sonno lo prese. Ma la regina
accolse dentro di sé la savia parola e scese
dal letto per la casa: accorsero tutte insieme
le ancelle al servizio della loro signora.
In segreto mandò il suo araldo per dare a Giasone
il consiglio di unirsi con la fanciulla e non pregare
il re Alcinoo: lui stesso sarebbe andato dai Colchi
a pronunciare il giudizio: se Medea era vergine
gliel'avrebbe data da riportare ad Eete,
ma se invece già divideva il letto di Giasone
non avrebbe spezzato un'unione legittima.
Così disse e l'araldo lasciò immediatamente il palazzo
per portare a Giasone le fauste parole
di Arete, la pia decisione di Alcinoo.
Li trovò che stavano accanto alla nave
e vegliavano in armi nel porto di Illo,
nei pressi della città, e riferì l'ambasciata.
Gli eroi furono lieti: il discorso era loro gradito.
Subito mescolarono il vino in un cratere in onore
degli dei, e secondo il rito e piamente
portarono all'altare le pecore, e in quella notte medesima
prepararono per la fanciulla il letto nuziale
nell'antro divino dove viveva un tempo Macride,
la figlia del saggio Aristeo, che scoperse
il lavoro delle api ed il succo d'olivo.
All'inizio Macride accolse in seno, nell'Eubea degli Abanti,
Dioniso, il figlio di Zeus, e gli unse di miele le aride labbra
dopo che Ermes l'aveva strappato al fuoco, ma Era la vide
e la scacciò incollerita da tutta l'isola:
andò ad abitare lontano, nel sacro antro feacio,
e diede immensa prosperità agli abitanti del luogo.
Qui stesero il grande letto e sopra gettarono
il vello d'oro fulgente, perché le nozze
fossero onorate e cantate. Nel candido
seno le Ninfe portavano mazzi variopinti di fiori.
Le circondava tutte come una luce di fuoco,
tale era il lampo che si irradiava dai bioccoli d'oro;
un dolce desiderio brillava nei loro occhi
ma la vergogna trattenne tutte, per quanto volessero
mettervi sopra le mani. Alcune erano figlie
del fiume Egeo, altre vivevano sopra le cime
del Meliteo, ed altre nei boschi della pianura.
Era stessa, la sposa di Zeus, le aveva chiamate in onore di Giasone.
Ed ancor oggi si dà il nome di Medea a quella grotta
dove le Ninfe celebrarono la loro unione,
stendendo veli fragranti. Gli eroi nel frattempo
tenendo in mano le lance - che lo stuolo nemico
non piombasse su loro all'improvviso, assaltandoli -
e con la testa coronata di rami fronzuti,
cantavano l'imeneo davanti alla soglia,
seguendo il dolce suono della cetra d'Orfeo.
Non nella terra di Alcinoo desiderava celebrare le nozze
l'eroe figlio di Esone, ma quando fosse tornato
a Jolco nella casa del padre, e così anche Medea:
il bisogno li spinse ad unirsi in quel momento.
Ma noi stirpe infelice degli uomini non possiamo entrare
nella gioia con piede sicuro; sempre l'amaro dolore
s'insinua in mezzo ai momenti del nostro piacere.
E così anche loro, pure godendo del dolcissimo amore,
la paura li possedeva, temendo che non si compisse il
giudizio di Alcinoo.
L'aurora sorgendo scioglieva con la sua luce immortale
la nera notte nell'aria: le rive dell'isola
ridevano, ed anche i rugiadosi sentieri,
lontano nella pianura; il rumore riempiva le strade;
e gli abitanti si muovevano per la città,
i Colchi in lontananza, all'estremo della penisola
di Macride. Subito Alcinoo, secondo i patti, andò a riferire
la sua decisione circa la sorte della fanciulla:
teneva in mano lo scettro d'oro di giudice,
sotto il quale il suo popolo otteneva rette sentenze;
insieme a lui marciavano in fila, vestendo
le armi di guerra, i più illustri fra tutti i Feaci.
Dalle mura uscivano in folla le donne,
per vedere gli eroi, e con loro andavano i contadini,
che sapevano tutto: Era aveva diffuso
la notizia veridica. Chi portava un agnello scelto,
chi una giovenca ancora immune dalla fatica,
chi collocava lì accanto anfore colme di vino,
e lontano saliva il fumo dei sacrifici.
Le donne portavano, come è loro costume,
vesti ben lavorate, gioielli d'oro,
ed altri ornamenti delle giovani spose.
Stupivano a vedere l'aspetto e la bellezza
dei nobili eroi, e tra loro il figlio di Eagro
che percuoteva la terra col suo bel sandalo,
al ritmo del canto e della cetra sonora.
Le Ninfe tutte insieme, ad ogni accenno alle nozze,
intonavano il dolce imeneo e talvolta cantavano sole,
formando volute di danza, Era, in tuo onore,
poiché tu avevi messo nel cuore della regina
l'idea di rivelare la saggia parola di Alcinoo.
Il re, com'ebbe bandito i termini della retta sentenza
(e già la notizia del matrimonio s'era diffusa),
mantenne saldamente la propria parola,
e non lo colse il terrore dell'ira di Eete:
aveva già stabilito giuramenti inviolabili.
E quando i Colchi compresero che chiedevano invano,
e il re ordinò loro di rispettare la legge,
o tenere lontano le navi dai porti di quella terra;
allora, tremando per le minacce del loro sovrano,
chiesero d'essere accolti in amicizia.
Abitarono a lungo nell'isola assieme ai Feaci,
fino a quando i Bacchiadi, originari di Efira,
la presero a loro sede, ed essi allora passarono di fronte all'isola
e di là avrebbero quindi raggiunto i Monti Cerauni
dove sono gli Amanti, la terra dei Nesti ed Orico.
Ma questo doveva avvenire nel lungo corso del tempo.
Là ancor oggi ogni anno ricevono offerte
gli altari che Medea, nel tempio di Apollo pastore,
dedicò alle Moire e alle Ninfe. Alla loro partenza
Alcinoo diede loro moltissimi doni ospitali
e molti Arete, e inoltre dodici ancelle
come seguito per Medea, dal palazzo Feacio.
Il settimo giorno lasciarono Drepane. Soffiava un forte vento
dall'alba nel cielo sereno, e spinti dal soffio del vento
correvano innanzi. Ma non era destino
che gli eroi sbarcassero sulla terra di Grecia
prima d'avere penato agli estremi confini di Libia.
Già avevano oltrepassato il golfo di Ambracia,
e a vele spiegate il paese dei Cureti e le Echinadi,
e con esse una fila di piccole isole, e la terra
di Pelope cominciava appena a mostrarsi.
Allora una tremenda tempesta di Borea
li rapì e li portò verso il mare di Libia
per nove giorni e nove notti, fin quando
arrivarono profondamente dentro la Sirte,
dove non c'è più ritorno per le navi forzate ad entrare.
Dappertutto è pantano e un fondo di alghe
su cui si riversa muta la schiuma del mare:
fino al cielo si stende la sabbia: niente
striscia o si leva in volo. E lì la marea
- frequentemente l'onda rifluisce da terra
e poi di nuovo ribolle con selvaggio furore
contro le coste - li spinse rapida dentro la rada:
solo il fondo della carena rimase nell'acqua.
Saltarono dalla nave, e il dolore li prese alla vista del cielo,
e dell'immenso dorso di terra simile al cielo,
che si stendeva all'infinito. Non c'era un ruscello,
non un sentiero e, guardando lontano, non una capanna,
e una calma quieta possedeva tutte le cose.
E l'uno con l'altro, angosciati, si domandavano:
"Che terra è questa? Dove ci hanno gettato
le tempeste? Oh se avessimo osato, vincendo il maledetto timore,
rifare il cammino di prima attraverso le rupi!
E anche se fossimo andati contro il disegno di Zeus,
meglio sarebbe stato morire facendo qualcosa di grande.
Ora che fare, se siamo costretti dai venti
a restar qui, e fosse anche per poco? Come la solitudine
si stende lungo questa terra senza confini!".
Così dicevano: il pilota Anceo, disperato,
si rivolse in questo modo ai compagni, anche loro abbattuti:
"Siamo finiti in preda al destino più atroce,
e non c'è via di sfuggirgli: ci aspettano in questo deserto
le sofferenze più dure, anche se il vento
dovesse soffiare da terra. Per quanto guardi
il mare da tutte le parti, non vedo che fango,
e l'onda corre a rompersi sulla candida sabbia.
Da tempo la sacra nave sarebbe stata spezzata
orribilmente, lontano sul fondo, se la marea
venuta dal largo non la sollevava. Ma adesso
la marea torna a rifluire nell'alto mare,
e qui scorre soltanto un'acqua non navigabile
che copre appena la terra. E io vi dico
che la speranza di salpare e di ritornare è distrutta.
Qualcun altro mostri la sua abilità e si sieda al timone,
se brama partire. Ma Zeus, dopo tutte le pene,
non vuole che venga il momento del nostro ritorno".
Così disse piangendo, e chi era esperto di mare
consentiva con la sua angoscia. Si ghiacciò il cuore a tutti nel petto,
e sulle loro guance si stese il pallore.
Come s'aggirano gli uomini per la città somiglianti
a ombre prive di vita, quando s'aspetta
la guerra o la peste, e la bufera violenta
che distrugge a migliaia le fatiche dei bovi,
o come quando da sé le statue grondano sangue
e si crede d'udire muggiti nei templi,
e il sole a mezzogiorno riporta dal cielo
la notte e nell'aria appaiono gli astri lucenti,
così gli eroi vagavano sulla lunghissima
riva. E sopravvenne ben presto la fosca sera:
s'abbracciarono pietosamente dicendosi
addio in lacrime per andare a morire
ciascuno sulla spiaggia da solo. Chi qua, chi là,
andarono a scegliersi un posto e in questo modo,
con il capo avvolto nel mantello, restarono
tutta la notte e il mattino, senza mangiare né bere,
aspettando l'orrida morte. In disparte, raccolte
attorno alla figlia di Eete, le fanciulle piangevano.
E come, abbandonati e caduti dal loro nido
sopra la roccia, gridano acutamente gli uccelli implumi,
o come sul ciglio del bel fiume Pattolo
cantano i cigni e tutto attorno risuonano
i prati rugiadosi e le belle correnti,
così con i biondi capelli nella polvere, tutta la notte
esse gemevano il loro pietoso lamento.
E tutti in quel luogo avrebbero perso la vita
i più grandi eroi, senza gloria, senza memoria tra gli uomini,
senza avere condotto a termine la loro impresa;
ma ebbero pietà di loro, che si consumavano
nella disperazione, le eroine di Libia,
che, quando Atena balzò splendente dal capo del padre,
vennero e la bagnarono nelle acque del lago Tritone.
Era mezzogiorno, e i raggi acuti del sole
bruciavano la Libia, quando esse furono accanto a Giasone,
e dolcemente gli tolsero il mantello dal capo.
Lui stornò gli occhi da un'altra parte, per rispetto alle dee,
ma esse si rivolsero all'eroe angosciato,
visibili a lui soltanto, con queste dolci parole:
"Infelice, perché farsi prendere tanto dalla disperazione?
Sappiamo che siete andati alla conquista del vello d'oro;
sappiamo tutte le pene immense che avete
sofferto, vagabondando per terra e per mare.
Noi siamo le dee solitarie, parlanti, le eroine,
figlie e protettrici della terra di Libia.
Non restare più a lungo a gemere: sveglia
i tuoi compagni: quando Anfitrite avrà sciolto
il rapido carro di Poseidone, allora pagate
il vostro debito verso la madre per le pene sofferte
portandovi tanto tempo nel ventre, e in questo modo
potrete ancora tornare alla sacra Grecia".
Così dissero e là dov'erano, scomparvero subito
assieme alla voce. Il figlio di Esone si guardò intorno,
si alzò a sedere per terra e parlò a questo modo:
"Siate propizie, gloriose dee del deserto. Ma sul ritorno
non capisco la vostra parola; pure, radunerò i miei compagni,
e gliela riferirò, se mai trovassimo un segno
che ci guidi nel viaggio: è migliore il pensiero di molti".
Disse, e balzato in piedi, chiamò a gran voce i compagni;
nero di polvere, come il leone che per la foresta
ruggisce cercando la sua compagna, ed alla voce possente
risuonano in lontananza le valli dei monti;
rabbrividiscono per la paura i buoi al lavoro nei campi
e anche i mandriani. Ma ad essi non fece paura
la voce del loro compagno, che cercava gli amici:
si radunarono attorno a lui, a testa bassa.
E lui così tristi li fece sedere, assieme alle donne,
vicino all'approdo di Argo e disse loro ogni cosa:
"Ascoltatemi, amici: nella mia angoscia
mi sono apparse tre dee, vicino, sulla mia testa,
come fanciulle coperte da pelli di capra,
che dall'alto del collo scendevano alla schiena e alle anche;
con mano leggera mi hanno scostato il mantello
e mi hanno ordinato di alzarmi e di venire a chiamarvi:
dobbiamo rendere alla madre il giusto compenso
per le pene sofferte portandoci tanto tempo nel ventre,
quando Anfitrite abbia sciolto il rapido carro
di Poseidone. lo non riesco a comprendere il vaticinio.
Di sé hanno detto di essere le eroine,
figlie e protettrici della terra di Libia,
e quanto abbiamo sofferto in passato per mare e per terra
dicevano di conoscerlo punto per punto.
Poi d'improvviso non le ho più viste, in quel luogo,
una nebbia o una nube deve averle velate".
Così disse, e tutti quanti stupirono nell'ascoltarlo.
E qui avvenne agli occhi dei Minii il prodigio più grande:
dal mare a terra balzò un gigantesco cavallo, mostruoso,
e levando in alto il collo con la criniera dorata,
scosse dalle sue membra i rivoli d'acqua salmastra
e si lanciò nella corsa, simile al soffio del vento.
Subito Peleo disse, lietamente, ai compagni adunati:
"Vi dico che è questo il carro di Poseidone,
che è stato ormai sciolto dalle mani della sua sposa;
e penso che nostra madre altri non sia che la nave;
essa ci ha tenuto sempre dentro il suo ventre
e dunque geme per i dolorosi travagli.
Solleviamola allora con forza tenace,
con spalle instancabili, e trasportiamola
nella terra sabbiosa dove il cavallo ha diretto i suoi passi.
Non si immergerà nel deserto, e le sue tracce
ci guideranno nell'entroterra verso un golfo marino".
Così disse, e a tutti piacque il suo savio consiglio.
Questo è il racconto delle Muse, ed io lo canto
servendo le Muse: ho udito una storia sicura,
che voi, nobilissimi figli di re, levaste in alto
sulle vostre spalle con vigore e coraggio la nave
e tutto ciò che era dentro, e la portaste per dodici giorni
e per dodici notti attraverso le dune deserte di Libia.
Ma le pene e le angosce che patirono fino al colmo,
nella loro fatica, chi mai potrà raccontarle?
Veramente erano di sangue immortale, tanto grande fu il compito
che la violenta necessità li costrinse ad assumersi.
Lontano lontano, sempre portando la nave, entrarono
lietamente nelle acque del lago Tritonide, e la deposero
dalle solide spalle. Si lanciarono come cani rabbiosi
a cercare una fonte; perché s'era aggiunta l'arida sete
alla fatica e al dolore; ma non cercarono invano.
Arrivarono alla sacra pianura dove, ancora il giorno prima,
il drago nato dalla terra, Ladone, vegliava le mele d'oro,
nel regno di Atlante, e intorno le Ninfe Esperidi
svolgevano il loro ufficio, intonando un amabile canto.
Ma il drago, appena colpito da Eracle, era disteso
presso il tronco di un melo, e muoveva soltanto la punta
della coda - dalla testa alla nera spina dorsale giaceva
senza respiro, e dove le frecce avevano contaminato il suo sangue
con la bile amara dell'idra di Lerna, le mosche
si disseccavano sopra le piaghe putride.
Là accanto le Esperidi gemevano forte, celando
la testa bionda dentro le candide mani. S'avvicinarono
inaspettati: al loro arrivo impetuoso, le Ninfe
divennero polvere e terra: Orfeo comprese il prodigio divino,
e a nome di tutti le pregò in questo modo:
"Siate propizie, signore, belle e benevole dee,
sia che voi siate nel numero delle dee celesti
o delle dee sotterranee, o Ninfe abitatrici
delle solitudini. Ninfe, figlie del sacro Oceano,
mostratevi a noi e indicate alla nostra speranza
un'acqua di roccia oppure una fonte divina
che sgorghi da terra e possa placare la sete
terribile, ardente. E se mai torneremo
navigando in terra di Grecia, a voi tra le prime
offriremo innumerevoli doni, e libagioni
e conviti in testimonianza del nostro affetto".
Così disse pregandole con voce chiara: subito quelle
ebbero compassione dei loro dolori. E per prima cosa
fecero crescere erbe dal suolo e, al disopra dell'erba,
fiorirono verso l'alto lunghi virgulti, ed infine
alberi fioriti si levarono ritti sopra la terra.
Espera divenne un pioppo, Eriteide un olmo,
Egle il sacro tronco di un salice, ma da quegli alberi
apparvero nuovamente com'erano
prima, immenso prodigio, ed Egle rispose
con dolci parole agli uomini ansiosi:
"Un grandissimo aiuto nelle vostre pene
vi ha dato quel cane che venne ad uccidere
il serpente custode, e portò via le mele d'oro,
lasciandoci acerbo dolore. Si, è venuto da noi
un uomo d'orrendo aspetto e violenza; brillavano
gli occhi sotto la fronte spietata, terribile:
era vestito della pelle di un enorme leone, selvaggia,
neppure conciata: portava un robusto tronco d'ulivo
ed un arco, e con le frecce uccise la belva.
Anche lui, che aveva percorso la strada a piedi,
era arso dalla sete e batteva quei luoghi
cercando l'acqua. Mai l'avrebbe trovata;
ma c'è una roccia presso il lago Tritonide;
per suo pensiero o per consiglio divino
colpì in basso col piede; l'acqua sgorgò in abbondanza.
Allora, poggiate per terra ambo le mani ed il petto,
bevve senza fermarsi dalla roccia spaccata fin quando
saziò il ventre capace, disteso come una vacca, nel pascolo".
Così disse; corsero subito lieti là dove Egle
aveva indicato la fonte agognata, finché la trovarono.
Come quando le operose formiche s'aggirano in massa
attorno a un piccolo buco, o come quando le mosche
si precipitano insaziabili, a frotta,
sopra una goccia di miele, così tutti insieme
gli eroi s'aggiravano attorno alla fonte rocciosa,
e qualcuno diceva contento, con le labbra ancor umide:
"Ecco che anche lontano Eracle ha salvato i compagni,
arsi di sete. Oh se potessimo andare a cercarlo
e ritrovarlo nel suo cammino attraverso questo paese!".
Disse, e i compagni lo ascoltarono, e quelli di loro
[che erano adatti
si divisero andando chi qua, chi là alla ricerca;
ma il vento notturno aveva smosso la sabbia
e cancellato le tracce. Partirono i figli di Borea
fidando nelle ali, ed Eufemo nei rapidi
piedi, e Linceo che vedeva acuto e lontano,
e per quinto si mise in marcia con loro Canto.
Egli era spinto per questa strada dal destino divino
e dal proprio coraggio: voleva sapere da Eracle
dove aveva lasciato Polifemo figlio di Elato: gli stava a cuore
conoscere tutto sulla sorte del suo compagno.
Ma quello, dopo aver fondato un'illustre città della Misia,
ansioso di compiere il viaggio, andò alla ricerca di Argo,
lungamente, finché arrivò sul mare, al paese
dei Calibi: e qui il destino gli diede morte
e gli innalzarono un tumulo, sotto un grande pioppo,
poco lontano dal mare. Solo Linceo
credette di vedere Eracle in lontananza,
nella terra sterminata, come si scorge o pare, di scorgere
la luna annebbiata, nel primo giorno del mese.
Tornò dai compagni e disse loro che mai più nessuno
degli uomini che cercavano Eracle avrebbe potuto raggiungerlo.
Tornarono anche il rapido Eufemo e i due figli
del trace Borea, dopo le vane fatiche.
Ma te, Canto, te le terribili Chere si presero in terra di Libia.
Incontrasti un gregge al pascolo, e dietro al gregge
il pastore: e questi, per le pecore che tu volevi
portare ai compagni affamati, ti uccise
con un colpo di pietra: ché non era avversario
da poco Cafauro, nipote di Febo Licoreo
e di Acacallide, la pudica fanciulla
che il padre Minosse esiliò nella Libia,
incinta del dio, e al dio essa diede un figlio glorioso,
chiamato Amfitemide, o Garamante; ed a sua volta
Amfitemide si unì con una ninfa Tritonide,
che gli partorì Nasamone, e il forte Cafauro
che uccise Canto per difendere il gregge.
Ma non sfuggì al duro braccio degli eroi, quando seppero
ciò che era accaduto. Presero il corpo
che stava sfacendosi, lo piansero e seppellirono,
e portarono con sé le pecore. In quel giorno stesso
il destino spietato si prese anche Mopso,
figlio di Ampico; malgrado i suoi vaticini
non scampò alla sorte funesta. Non c'è modo di evitare la morte.
Sulla sabbia giaceva, sfuggendo al calore del mezzogiorno,
un tremendo serpente, ma pigro: non voleva fare del male
a chi non gliene faceva, e neppure voleva attaccare
chi fuggiva da lui; ma una volta che il suo veleno
toccasse una creatura vivente, di quelle che nutre la terra feconda,
la strada dell'Ade diveniva per essa più breve di un cubito,
neppure se Peone - se posso dirlo con tutta franchezza -
venisse a curarlo, appena il serpente l'avesse toccato
[coi denti.
Quando Perseo, simile a un dio, o Eurimedonte
(così lo chiamava la madre) volò sulla Libia
per portare al re il capo appena tagliato
della Gorgone, quante gocce del nero sangue raggiunsero il suolo,
tutte diedero vita alla stirpe di questi serpenti.
Mopso, mettendo avanti il piede sinistro,
gli urtò la coda della spina dorsale: quello,
torcendosi per il dolore, gli morse la carne
tra tibia e muscolo. Medea tremò e assieme a lei
le sue ancelle. Ma lui compresse arditamente
il sangue della ferita, che non gli dava un grande dolore.
Infelice: già sotto la pelle s'insinuava il letargo
mortale, e fitta calava sopra i suoi occhi la nebbia.
Subito, senza speranza, reclinò al suolo le membra pesanti,
e fu freddo. Attorno a lui si adunarono
i compagni e il figlio di Esone, stupiti alla grave sventura.
Morto, neppure un momento doveva restare
a giacere nel sole, perché dentro il veleno sfaceva le carni
e i peli marciti cadevano via dalla pelle.
Subito, con le vanghe di bronzo, scavarono
una fossa profonda: si tagliarono, essi e le donne,
i capelli, piangendo il triste destino del morto: e tre volte
girarono in armi attorno al cadavere
secondo il rito, e lo coprirono sotto la terra.
Poi salirono sulla nave, giacché Noto soffiava
sul mare, e cercavano di trovare una via
per uscire dal lago Tritonide, ma non la trovavano
e per tutto il giorno andavano avanti alla cieca.
Come un serpente attorto avanza per un cammino sinuoso,
quando più acuti bruciano i raggi del sole,
e con un sibilo volge il capo di qua e di là e i suoi occhi
lampeggiano furiosi come scintille di fuoco,
finché si infila in un buco per la fessura del suolo,
così la nave Argo cercando un valico
vagava per lungo tempo. Allora il figlio di Eagro
ordinò di portar fuori il grande tripode di Febo Apollo,
e offrirlo in dono agli dei del luogo per un felice ritorno.
E così scesero a terra e vi collocarono il dono di Apollo,
e venne loro incontro, simile a un uomo nel fiore degli anni,
il forte Tritone, e prendendo da terra una zolla
la offrì agli eroi come dono ospitale, e parlò in questo modo:
"Accettatela, amici: qui non ho dono migliore
da offrire ai miei ospiti. Se voi cercate
un passaggio per questo mare, così come spesso
gli uomini che navigano in una terra straniera,
ve lo dirò. Me ne ha fatto esperto mio padre,
il dio Poseidone. Io regno sul lido e forse avete
sentito parlare, pur vivendo lontano,
di Euripilo, nato in Libia, nutrice di fiere".
Disse, e prontamente Eufemo stese le mani
alla zolla e rispose a sua volta queste parole:
"Eroe, se tu conosci il Peloponneso ed il mare
di Creta, rispondi il vero alle nostre domande.
Non per nostro volere siamo venuti qui, ma sospinti
ai confini di questo paese dalle tempeste
di Borea, abbiamo portato sulle spalle la nave
attraverso il continente fino alle acque del lago; siamo sfiniti
e non sappiamo dov'è il passaggio alla terra di Pelope".
Così disse, e Tritone stese la mano e indicò loro
in lontananza il mare e la bocca profonda
del lago, e si rivolse agli eroi in questo modo:
"Il passaggio è laggiù, dove l'acqua è nera, profonda
[ed immobile;
da ambo le parti si levano candidi ed alti
marosi: in mezzo ad essi è uno stretto cammino
che porta di fuori. Là, oltre Creta, si stende
il mare nebbioso fino alla terra di Pelope.
Ma quando dal lago sarete usciti nel mare,
dirigetevi a destra, e tenetevi stretti alla terra
finché risale, poi quando piega dall'altra parte,
vi si apre un viaggio sicuro, dopo che avrete
passato il promontorio. Ma ora andate
e siate pure tranquilli: non c'è fatica
che possa fiaccare membra floride di giovinezza".
Così disse benigno, e gli eroi si imbarcarono subito,
desiderosi di uscire, a forza di remi, dal lago.
Già si muovevano con ogni slancio, quando Tritone
prese il grande tripode e parve immergersi
nel lago: più nessuno lo vide quando scomparve
rapidamente insieme col tripode. Il loro cuore
fu lieto d'avere incontrato un dio benevolo;
e invitarono Giasone a sacrificargli
la più bella pecora, pregando. E subito Giasone
la scelse, la sollevò stando a poppa e la sgozzò,
e al sacrificio aggiunse questa preghiera:
"Dio, chiunque tu sia, che ci sei apparso sulle rive del lago
- ti chiamino col nome di Tritone (prodigio marino) o di Forco
o di Nereo le figlie dell'acqua - sii propizio
e dacci il ritorno che il nostro cuore desidera".
Disse, e pregando gettò dalla poppa la bestia
sgozzata. Allora il dio uscì dal profondo
con la sua immagine vera. E come un uomo
guida un cavallo veloce nel vasto stadio,
tenendolo docile per la folta criniera
e corre, mentre il cavallo lo segue superbo,
sollevando la testa, e tintinna il ferro lucente
nella sua bocca, quando lo addenta agli estremi,
così il dio prese al fondo la concava nave,
e la spinse avanti nel mare. Il suo corpo,
dall'alto del capo lungo il dorso e sui fianchi,
e fino al ventre, era simile agli immortali,
nell'aspetto meraviglioso, ma al di sotto dei fianchi
si allungava una coda a due punte, di mostro marino,
e colpiva la cima dell'acqua con le spine dorsali,
che in punta si dividevano in curvi uncini, come le corna lunari.
Portò la nave, fino a spingerla sulla rotta del mare,
poi s'inabissò nel profondo: gli eroi gridarono
vedendo compiersi coi propri occhi lo strano prodigio.
Qui sta il porto di Argo, e della nave rimangono tracce;
qui sono gli altari di Poseidone e Tritone,
poiché in quel giorno si fermarono là. Ma verso l'aurora
corsero a vele spiegate al soffio di Zefiro,
tenendo sempre sulla loro destra il deserto.
Il mattino seguente giunsero a scorgere il capo
e al di là del capo i recessi del mare.
All'improvviso Zefiro cadde e sopravvenne
il soffio di Argeste: gli eroi ne furono lieti.
Ma al tramonto del sole, quando spuntò la stella
serale che porta il riposo ai contadini stanchi,
ed il vento cadde nell'oscurità della notte,
allora ammainarono le vele e reclinarono
l'albero e si piegarono con ogni forza sui remi
e remarono per tutta la notte ed il giorno,
e ancora la notte seguente. Lontano, li accolse
la rocciosa Carpato. Di là stavano per traversare
a Creta, l'isola che più di tutte si trova al largo nel mare.
Ma Talos, l'uomo di bronzo, scagliando pietre
da una solida roccia, impedì di gettare a terra
le gomene, quando furono giunti al porto Ditteo.
Era questi il solo rimasto dei semidei
della razza di bronzo, ch'era nata dai frassini,
e Zeus l'aveva dato ad Europa come guardiano dell'isola,
che percorreva tre volte coi piedi di bronzo.
Di bronzo infrangibile era tutto il suo corpo
e le membra, ma sulla caviglia, al di sotto del tendine,
aveva una vena di sangue, e la copriva
una sottile membrana che era per lui vita e morte.
Benché fossero sfiniti dalla fatica, gli eroi spaventati
allontanarono a forza di remi la nave
dalla spiaggia dell'isola. E certo miseramente
sarebbero fuggiti, soffrendo la sete e le pene,
ma, al momento della partenza, Medea disse loro:
"Datemi ascolto: io credo di potere da sola
uccidervi quell'uomo, chiunque sia, anche se ha il corpo di bronzo,
purché non abbia vita instancabile. Voi, fermate la nave,
qui, piano, in modo che resti fuori dal tiro delle sue pietre,
finché mi abbia ceduto e io l'avrò vinto".
Così disse, e gli eroi remando portarono fuori tiro
la nave, aspettando quale piano segreto
mettesse in opera. Ella tirò sulle gote,
da ambo le parti, lembi del peplo purpureo
e salì sul ponte: la teneva per mano,
passando attraverso i banchi, il figlio di Esone.
Qui invocò e si propiziò con gli incantesimi
le Chere mortali, le cagne veloci dell'Ade,
che s'aggirano per tutto l'etere, dando la caccia ai viventi.
Tre volte le supplicò, tre volte le evocò con gli incantesimi,
tre volte con le preghiere, e, creandosi un cuore malvagio,
ammaliò con occhi nemici gli occhi dell'uomo di bronzo;
e digrignando gli mandò contro bile malefica
e orribili immagini, nel suo tremendo furore.
Zeus padre, un grande stupore invade il mio animo,
se la morte non giunge soltanto con le malattie e le ferite,
e qualcuno anche lontano può farci del male,
così come Talos, pur essendo di bronzo, cedette al potere
di Medea, signora dei filtri. Mentre alzava rocce pesanti
per bloccare l'approdo, urtò la caviglia
su uno spunzone di pietra e colò l'icore
simile a piombo fuso. Non fu più capace
di reggersi in piedi sullo scoglio sporgente.
Come un grandissimo pino in alto sui monti,
che i taglialegna hanno lasciato reciso
a metà dalle scuri affilate, scendendo dalla foresta,
e nella notte dapprima i venti lo scuotono,
poi si stacca dal ceppo e precipita, così per poco
Talos restò barcollante sui piedi infaticabili,
poi crollò senza forze con un immenso frastuono.
Quella notte gli eroi dormirono a Creta;
ma quando sorsero le prime luci dell'alba,
costruirono un tempio in onore di Atena cretese,
fecero provvista d'acqua e si imbarcarono
per doppiare al più presto, a remi, il capo Salmonide.
Mentre correvano il vasto mare di Creta,
li spaventò la notte, che il poeta dice funesta:
la notte tremenda che non penetravano gli astri, né i raggi di luna,
un nero abisso caduto dal cielo o una tenebra
sorta dai recessi profondi. Neppure sapevano
se navigavano sopra le acque o nel regno dei morti,
ed affidavano al mare il loro ritorno,
disperati, senza capire dove li stava portando.
Ma Giasone alzò le mani e invocò Febo a gran voce,
chiedendogli di salvarli, e piangeva angosciato.
Promise che avrebbe portato innumerevoli
doni ai santuari di Pito, di Amicle, di Ortigia.
Tu l'ascoltasti, figlio di Leto, e scendesti dal cielo
agli scogli Melanzi, che sorgono in questo mare,
e, balzato alla cima di una delle due rupi,
con la destra levasti in alto l'arco dorato,
che diffuse dovunque un chiarore fulgente.
Apparve ai loro occhi una piccola isola
delle Sporadi, poco distante dall'isoletta d'Ippuride:
gettarono qui le ancore e si fermarono. Presto
l'aurora tornò a risplendere: gli eroi consacrarono
un bel santuario ad Apollo nel bosco ombroso e un
[altare † ombreggiato †
dando al dio il nome di Eglete, e cioè luminoso,
in ricordo della luce che li aveva guidati; l'isola impervia
la chiamarono Anafe, o luogo dell'apparizione,
perché Apollo l'aveva mostrata a loro in mezzo all'angoscia.
Fecero i sacrifici che si possono fare su una costa deserta,
ma le ancelle feacie della figlia di Eete, quando li videro
libare acqua sopra i tizzoni ardenti, non trattennero
il riso, loro che spesso avevano visto,
nella reggia di Alcinoo, sacrificare dei bovi.
Gli eroi, allegri per quello scherzo, le rimbeccarono
a male parole: s'accese tra loro un blando
motteggio, uno scherzoso litigio. In memoria del gioco
degli eroi, ancor oggi le donne dell'isola scherzano
allo stesso modo con gli uomini, quando si compiono i sacrifici
in onore di Apollo Eglete, il protettore di Anafe.
Quando sciolsero di là le cime, con un tempo tranquillo,
Eufemo si ricordò di un sogno avuto di notte,
per rispetto del figlio illustre di Maia. Gli era sembrato
che la zolla divina, che teneva sul seno,
si bagnasse di candide gocce di latte, e dalla zolla,
pur così piccola, ecco nasceva una donna,
una fanciulla, ed egli si univa con lei, colpito
da desiderio grandissimo, poi si pentiva
come d'aver posseduto sua figlia, nutrita con il suo latte;
ma essa lo confortava con queste dolci parole:
"Mio caro, io sono nata da Tritone e sono nutrice
dei tuoi figli, e non già tua figlia. I miei genitori
sono Tritone e la Libia. Tu lasciami con le Nereidi
a vivere in mare presso Anafe. Verrò alla luce del sole più tardi,
e sarò pronta ad accogliere i tuoi discendenti".
Eufemo si ricordò di questo in cuor suo e lo disse a Giasone,
e lui richiamando alla mente i vaticini di Apollo,
il dio signore dei dardi, così gli rispose:
"Mio caro, certo una grande e splendida gloria ti tocca in sorte.
Se getti in mare la zolla, gli dei ne faranno
un'isola, dove vivranno i tuoi nipoti
più giovani, giacché Tritone ti ha dato in dono ospitale
questo pezzo di terra libica; lui te l'ha data,
e nessun altro dio, quando l'abbiamo incontrato".
Così disse ed Eufemo non trascurò la risposta
del figlio di Esone, ma lieto del vaticinio
scagliò nel profondo la zolla, e sorse da questa
l'isola detta Calliste, o Bellissima, sacra nutrice dei figli di Eufemo.
Essi prima abitarono Lemno, la terra dei Sinti,
poi, quando i Tirreni li ebbero espulsi da Lemno,
giunsero supplici a Sparta. Più tardi lasciarono Sparta
e il nobile figlio di Autesione, Terante,
li guidò verso Calliste, e l'isola prese un nuovo nome
da te, Terante. Ma questo avvenne ben dopo i tempi di Eufemo.
Partiti di là, attraversarono come volando
il mare immenso e approdarono alla spiaggia di Egina.
E qui nel fare provvista d'acqua s'impegnarono in una gara leale,
chi primo l'attingeva e la portava alla nave:
li incalzavano insieme il bisogno ed un vento
impetuoso. Là ancor oggi, caricandosi in spalla
le anfore colme, i figli dei Mirmidoni
si sfidano gli uni con gli altri nelle gare di corsa.
Siate propizi, eroi, figli degli immortali, e questo mio canto
possa di anno in anno essere sempre più dolce
agli uomini. Eccomi giunto al termine illustre
delle vostre fatiche, giacché nessun'altra
vi toccò dopo che foste partiti da Egina;
non sorse nessuna tempesta di vento; tranquilli e sicuri
costeggiaste la terra Cecropia e quella di Aulide
di qua dell'Eubea, e le terre dei Locresi Opunzi,
e lietamente sbarcaste alla riva di Pagase
[[Biblioteca:Argonautiche, Libro III|Vai al Libro III]] - [[Argonautiche|Torna all'Indice]]