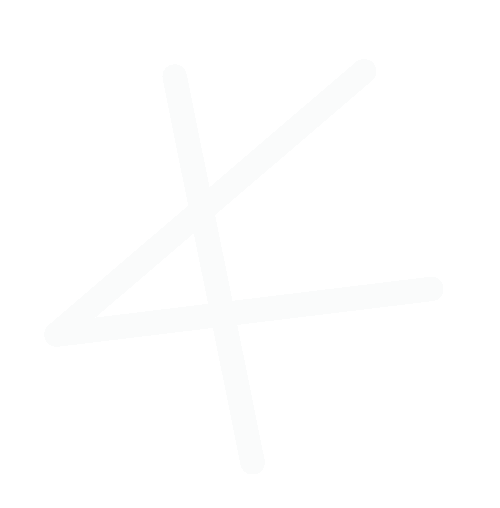Biblioteca:Ovidio, Metamorfosi, Libro XII
Non sapendo che Esaco, preso il volo, era ancora vivo, suo padre
Priamo lo piangeva per morto. Ettore e gli altri fratelli poi
avevano reso le esequie a un tumulo con il suo nome.
Alla mesta cerimonia mancava Paride, che in séguito,
tornando in patria con la sposa rapita, portò
una guerra sterminata: lo inseguivano migliaia di navi
con le forze coalizzate di tutte le genti greche.
E se immediata non fu la vendetta, causa ne fu la bufera
che aveva reso impervio il mare, bloccando in terra beota,
nel pescoso porto di Aulide, la flotta in procinto di salpare.
Qui si accingevano i Danai, secondo l'uso loro, a un sacrificio
in onore di Zeus e incandescente, avvolto ormai di fiamme,
era l'antico altare, quando videro strisciare sopra un platano,
che si ergeva accanto al luogo del rito, un drago iridescente.
In cima all'albero c'era un nido di otto uccellini:
il serpente li ghermì insieme alla madre, che disperata
svolazzava intorno, e li inghiottì nell'avida bocca.
Tutti allibirono, ma il figlio di Testore, veritiero
come indovino, gridò: "Evviva, Pelasgi, vinceremo!
Troia cadrà, ma la nostra sarà un'impresa lunga e faticosa".
E interpretò i nove uccelli come altrettanti anni di guerra.
Il serpente, attorcigliato com'era ai fiorenti rami dell'albero,
diventò di pietra. E la pietra a forma di serpente esiste ancora.
Nereo però continua a sconvolgere le acque dell'Aonia,
impedendo all'armata di salpare; e alcuni cominciano a credere
che Poseidone, avendone eretto le mura, voglia salvare Troia.
Ma non il figlio di Testore: lui non ignora e non tace
che bisogna placare l'ira della vergine Artemide col sangue
di una vergine. Ma quando il comune interesse prevalse
sugli affetti e il re sul padre, quando tra gli officianti in lacrime
Ifigenia si accostò all'altare per offrire il suo casto sangue,
la dea si placò, stese una nube davanti agli occhi loro,
e al culmine del rito, tra la folla e le voci di chi pregava,
sostituì, si dice, la fanciulla micenea con una cerva.
Placata Artemide con una vittima più consona a lei,
con l'ira della dea si spense anche quella del mare,
e col vento in poppa salparono le mille navi,
per approdare, dopo molti travagli, in terra di Frigia.
Al centro del mondo c'è un luogo che sta fra la terra, il mare
e le regioni del cielo, al confine di questi tre regni.
Da lì si scorge tutto ciò che accade in qualsiasi luogo del mondo,
anche nel più remoto, e lì giunge, a chi ascolta, qualsiasi voce.
Vi abita la Fama: ha eretto la casa nel punto più alto,
una casa nella quale ha posto infinite entrate e mille fori,
senza che una porta ne impedisca l'accesso.
È aperta notte e giorno; tutta di bronzo sonante,
vibra tutta, riporta le voci e ripete ciò che sente.
Non vi è pace all'interno e in nessun angolo silenzio,
ma pure non vi è frastuono, solo un brusio sommesso,
come quello che fanno le onde del mare se le si ascolta
di lontano o come l'ultimo brontolio dei tuoni,
quando Zeus fa rimbombare lugubri le nubi.
L'atrio è sempre affollato: gente d'ogni risma che va e viene.
Mescolate a voci vere ne vagano qua e là migliaia
di false, che spargono intorno chiacchiere e parole equivoche.
Di queste alcune riempiono le orecchie sfaccendate di calunnie,
altre riportano il sentito dire, e la dose delle invenzioni
cresce a dismisura, perché ognuno vi aggiunge qualcosa di suo.
Lì trovi la Credulità, l'incauto Errore,
la Gioia immotivata e i Timori sfibranti,
la Sedizione improvvisa e i Sussurri d'origine incerta.
Così la Fama vede tutto ciò che accade in cielo,
in mare e in terra, indagando sull'universo intero.
Fu lei a render noto che le navi greche, cariche di truppe,
stavano arrivando. Perciò, quando il nemico in armi sbarca,
non sbarca inatteso. I Troiani gli sbarrano il passo difendendo
il lido, e tu per primo, Protesilao, cadi per fatalità
sotto la lancia di Ettore. I primi scontri costano cari
ai Danai ed Ettore con le sue stragi si rivela un prode.
Ma anche i Frigi con molto sangue sperimentano quanto potente
si mostri il braccio degli Achei: già rosseggiavano di sangue
le spiagge del Sigeo; già Cigno, figlio di Poseidone, mille uomini
aveva ucciso; già Achille, imperversando sul suo carro,
stendeva a colpi di lancia (la lancia del Pelio) intere milizie,
e mentre cercava fra le schiere nemiche Cigno od Ettore,
in Cigno s'imbatté (per Ettore doveva attendere
ben dieci anni). Allora, incitando i cavalli, che su candidi
colli reggono il freno, diresse il carro contro il nemico
e, brandendo col braccio muscoloso una lancia tutta vibrante,
gridò: "Chiunque tu sia, o giovane, consòlati:
tu muori, ma chi ti uccide è Achille d'Emonia!".
Così il nipote di Eaco, e alle parole seguì il tonfo della lancia.
Ma benché scagliata con precisione e senza alcun errore,
l'asta non produsse danno con la sua punta acuminata:
contuse appena il petto di Cigno come fosse spuntata.
Allora Cigno: "Figlio di una dea (ti conosco di fama),
perché ti meravigli ch'io non sia ferito?"
(e meravigliato lo era). "Non quest'elmo che vedi, col suo fulvo
pennacchio equino, né il concavo scudo appeso al braccio
mi servono a qualcosa: li porto solo per farne sfoggio.
Anche Ares non porta armi per altro. Toglimi queste armature
di difesa: ne uscirei ugualmente illeso.
Conta pur qualcosa l'essere nato non da una Nereidi,
ma da chi domina su Nereo, le sue figlie e il mare intero".
E qui scagliò contro il nipote di Eaco una lancia, che andò
a conficcarsi al centro dello scudo, trapassando il bronzo
e nove pelli di bue, ma fu fermata dall'ultima.
L'eroe l'estrasse e a sua volta scagliò con tutta la sua forza
una lancia fremente: di nuovo il corpo rimase illeso,
senza una ferita. E neppure una terza lancia valse a scalfire
Cigno, che nulla faceva per ripararsi ed anzi si esponeva.
S'infuriò Achille, come un toro che in piena arena
con le sue corna terrificanti si avventa contro il drappo rosso
sventolato per irritarlo e si accorge di dar cornate a vuoto.
Controllò tuttavia se dalla lancia fosse caduta la punta:
no, era ben salda sul legno. "È la mia mano che è debole allora"
si disse, "e ha perso in una volta tutta la forza che aveva?
Perché prima era salda, certo, sia quando davanti a tutti
abbattei le mura di Lirnesso o quando sommersi
nel sangue loro Tenedo e Tebe, la città di Eezione,
sia quando purpureo fluì il Caico per la strage del suo popolo
e Telefo due volte sperimentò l'effetto della mia lancia.
E anche qui, con tutta questa caterva di morti che ho fatto
e vedo sulla spiaggia, la mia destra è stata ed è, certo, possente."
Detto questo, quasi non volendo credere a ciò che era accaduto,
scagliò una lancia contro Menete, un semplice soldato di Licia,
e gli squarciò la corazza trapassandogli il petto. Mentre quello,
stramazzando, batteva il capo al suolo in fin di vita,
Achille gli estrasse l'arma dalla calda ferita, urlando:
"Con questa mano, con questa lancia ho vinto; me ne varrò
contro costui, pregando che abbiano lo stesso effetto".
Così esclama e assale Cigno: l'asta di frassino corre dritta
e, non schivata, rimbomba contro la sua spalla sinistra,
ma poi viene respinta come da un muro o da una roccia compatta.
Achille vede che Cigno ha una chiazza di sangue nel punto
in cui è stato colpito, e gioisce. Vana gioia:
di ferita nemmeno l'ombra; il sangue è quello di Menete.
E allora fremente di rabbia con un balzo salta giù dal carro
e aggredisce corpo a corpo con la fulgida spada quel nemico
imperturbabile: vede, sì, che la lancia sfonda scudo
ed elmo, ma poi si ottunde contro il suo corpo duro.
Più non resiste: stringendo al petto lo scudo, sferra a Cigno
con l'elsa tre quattro colpi sul viso e sull'incavo delle tempie
e, mentre si ritira, l'incalza, lo sconcerta, gli balza addosso,
e lo intontisce senza dargli tregua. Cigno è invaso dal terrore,
la vista gli si appanna e, mentre arretra con le spalle,
inciampa contro una pietra che sporge in mezzo al campo.
Su quella Achille lo costringe, con violenza lo rovescia
lungo disteso sul dorso e l'inchioda a terra.
Poi, premendogli il petto con lo scudo e le dure ginocchia,
tira i lacci dell'elmo, che passano sotto il mento,
li stringe sino a strangolarlo e col respiro
gli porta via la vita. Si accinge allora a spogliare lo sconfitto:
scopre un'armatura vuota. Poseidone ha trasformato il corpo
in un uccello bianco: quello stesso di cui Cigno aveva il nome.
Questa impresa, questa battaglia comportò una tregua
di parecchi giorni; entrambe le parti, deposte le armi, sospesero
gli attacchi. E mentre all'erta una scolta vegliava sulle mura
dei Frigi, e all'erta un'altra vegliava nelle trincee argive,
venne il giorno solenne in cui Achille, dopo aver sconfitto Cigno,
cercò, immolando una giovenca, di placare Pallade
con quel sangue. Posta la carne a pezzi sull'altare ardente,
quando il profumo fu salito al cielo deliziando i numi,
una parte fu usata per il rito, il resto per la mensa.
Sdraiati sui divani i condottieri saziarono il corpo
di carne arrosto e col vino scacciarono pensieri e sete.
Non si dilettano al suono di cetre, canti
o di lunghi flauti di bosso con i loro numerosi fori,
ma passano la notte a conversare e tema dei discorsi sono
gli atti di valore. Raccontano le proprie gesta, quelle
del nemico e con passione ricordano a turno i pericoli
corsi e superati. Di cosa infatti potrebbe parlare Achille,
di che altro si potrebbe parlare in presenza del grande Achille?
Si discute soprattutto dell'ultima impresa, la sua vittoria
su Cigno: a tutti sembra prodigioso il fatto che da un'arma
il corpo del giovane non potesse essere trafitto, che uscisse
indenne da qualsiasi scontro e ottundesse persino il ferro.
Stupefacente lo trovava Achille, stupefacente gli Achei.
E allora Nestore: "In questa vostra epoca, Cigno
è stato l'unico a non temere un'arma, ad essere invulnerabile
a qualsiasi colpo. Ma un tempo io stesso vidi Ceneo di Perrebia
subire mille colpi senza riportare sul corpo ferita,
Ceneo di Perrebia, che, famoso per le sue gesta,
viveva sull'Otri. E la cosa era tanto più prodigiosa,
perché era nato femmina". A sentire di quel portento, i presenti,
incuriositi, lo pregano di raccontare. E fra questi Achille:
"Avanti, narra, siamo tutti ansiosi di ascoltarti,
vecchio eloquente, saggezza del nostro tempo:
chi era questo Ceneo, perché cambiò natura,
in quale spedizione, in quale battaglia lo conoscesti,
e da chi fu vinto, se vi fu mai qualcuno che lo vinse?".
E allora il vecchio: "Benché la vecchiaia inoltrata mi faccia velo
e parecchi avvenimenti a cui ho assistito in gioventù mi sfuggano,
tuttavia ne ricordo ancora molti; e nessun fatto più di questo,
fra i tanti che ho vissuto in pace e in guerra, mi si è impresso
nella mente. E se una lunga vecchiaia poté rendere qualcuno
testimone di così numerosi eventi, ebbene, son vissuto
duecento anni ed ora io sto vivendo la mia terza età.
Figlia di Elato, Ceni, la più bella fanciulla della Tessaglia,
era così nota per il suo fascino, che molti pretendenti
delle città vicine e delle tue (era infatti della tua terra,
Achille) la desideravano e la sognavano invano.
Anche Peleo avrebbe forse cercato di averla in moglie,
se non gli fosse già toccata in sorte, o almeno già promessa,
la mano di tua madre. Ceni non volle sposare
nessuno, è vero, ma mentre vagava lungo una spiaggia deserta
fu violentata dal dio del mare: così si raccontava.
Poseidone, colte le gioie di quell'avventura amorosa,
le disse: "Qualunque tuo desiderio, stai tranquilla,
sarà esaudito: scegli cosa vuoi". Anche questo si raccontava.
E Ceni: "L'oltraggio che ho patito mi fa scegliere il massimo:
che mai più debba subire tale affronto. Fa' che non sia più femmina
e mi avrai dato tutto". Le ultime parole lei le pronunciò
con un tono grave, con voce che poteva sembrare d'uomo,
come ormai era. Il dio degli abissi marini aveva acconsentito
al suo desiderio, e in più le aveva concesso d'esser uomo immune
da ferita e che mai potesse soccombere a un'arma.
Lieto del dono l'Atracide se ne va e trascorre l'esistenza
in attività virili, aggirandosi dove scorre il Peneo.
Piritoo, figlio del temerario Issione, aveva sposato Ippodame
e, dopo aver ben disposto le mense, aveva invitato i feroci
figli della Nuvola a banchetto in un antro nascosto nel bosco.
Erano presenti i notabili dell'Emonia e fra loro anch'io:
la reggia in festa risonava di folla eccitata.
Ecco: si canta l'inno nuziale, fuochi e fumi invadono l'atrio,
e appare, splendida in volto, la sposa circondata da uno stuolo
di madri e giovani donne. Ci rallegrammo con Piritoo
per la sposa, ma per poco non dovemmo pentirci dell'augurio.
E infatti tu, Eurito, il più feroce di quei feroci Centauri,
già infiammato dal vino, più t'infiammi vedendo la vergine,
e l'ebbrezza aggiunta alla libidine ha il sopravvento.
Rovesciate le tavole, in un attimo il banchetto va in rovina,
e la giovane, afferrata per i capelli, è trascinata via.
Eurito rapisce Ippodame; gli altri ognuno la donna che più
gli piace o quella che può: una scena da città conquistata.
In tutta la casa echeggiano grida di donne. Tutti balziamo
in piedi e Teseo per primo urla: "Quale pazzia
ti travolge, Eurito, che con me presente osi sfidare
Piritoo e offendere, senza saperlo, due uomini in uno?".
E per mostrare che non parla a vuoto, il magnanimo eroe
si fa largo tra la calca e strappa la donna a quegli scalmanati.
Eurito non risponde: non potrebbe in nessun modo
giustificare il suo gesto; così con protervia si avventa
contro il viso del valoroso e gli tempesta il generoso petto.
V'era lì accanto per caso un antico cratere istoriato
di figure in rilievo: Teseo, ergendosi enorme sopra questo,
lo solleva e lo scaglia in faccia all'avversario.
Quello, vomitando dalla bocca e dalle ferite grumi
di sangue, di cervello e vino, stramazza al suolo scalciando
la rena madida. Allo scempio del fratello, gli esseri biformi
si scatenano e come un sol uomo gridano "All'armi, all'armi!".
Il vino accresce l'impeto e la mischia inizia con un fitto lancio
di bicchieri, di fragili orci e di grossi recipienti,
oggetti per la mensa, ma ora usati per far guerra e strage.
Per primo Amico, figlio di Ofione, non si sgomenta a spogliare
la cella sacra dei doni votivi, per primo ne strappa via
un candelabro carico di torce sfavillanti,
e sollevandolo in alto, come chi si accinge a spezzare
con la scure sacrificale il collo candido di un toro,
lo scaglia sulla fronte del lapita Celadonte,
frantumandogli il cranio e rendendogli irriconoscibile il viso:
fuori ne schizzano gli occhi e, a causa delle ossa fratturate,
il naso è respinto indietro piantandosi in mezzo al palato.
Strappato un piede a un tavolo di acero, Pelate di Pella
atterra Amico, incastrandogli il mento nel petto,
e mentre quello sputa denti e sangue nero,
con un'altra mazzata lo spedisce tra le ombre del Tartaro.
Grineo, che era lì vicino, guardando con occhio feroce
l'altare fumante: "Perché non ci serviamo anche di questo?",
strepita e sollevato l'immenso blocco avvolto di fiamme,
lo scaglia in mezzo alla schiera dei Lapiti
schiacciandone due, Brotea ed Orio. Orio era figlio
di Micale, che, a quanto si diceva, aveva con formule magiche
trascinato al suolo la falce riluttante della luna.
"Aspetta ch'io trovi un'arma e la pagherai!"
urla Essadio e impugna come arma un corno di cervo,
appeso per voto sulla cima di un pino.
La punta forcuta del corno trafigge le orbite di Grineo,
gli cava gli occhi e di questi una parte resta infilzata nell'arma,
l'altra gli cola sulla barba e pende in un coagulo di sangue.
Ed ecco che Reto afferra dal centro dell'altare
un tizzone ardente e fracassa con un colpo dritto
la tempia coperta di biondi capelli a Carasso.
Avvolti dalle fiamme, in un baleno, come stoppie secche,
s'incendiano i capelli e il sangue bruciato nella ferita
sfrigola con tremendo crepitio; così fa il ferro
arroventato dal fuoco, quando il fabbro con le ganasce
della tenaglia l'estrae e l'immerge nel tino: affondato
nell'acqua che si intiepidisce, stride e sibila.
Scaccia il ferito le fiamme che gli divorano i capelli
arruffati e, divelta dal suolo una trave, onerosa persino
per un carro, l'alza sulle spalle. La pesantezza gli impedisce
di scagliarla contro l'avversario, ma l'enorme pietra travolge
un suo compagno, Comete, che gli stava troppo vicino.
Reto non trattiene la gioia: "Spero che anche il resto
di tutta la tua masnada sia forte così!" gli urla
e ricaccia a Carasso nella piaga il tizzone semibruciato;
poi con tre o quattro colpi gli fa saltare le suture
del cranio e le ossa s'infossano nel cervello spappolato.
Trionfante si volge ad assalire Evagro, Corito e Driante.
Quando Corito, che ha le guance appena velate di barba,
crolla a terra, Evagro grida: "Che gloria credi d'avere ottenuto
atterrando un ragazzo?". Ma Reto non gli permette
di dire altro: spietato gli caccia nella bocca aperta
per parlare il bagliore delle fiamme e dalla bocca dentro il petto.
Poi insegue anche te, fiero Driante, roteandoti il tizzone
intorno al capo, ma l'esito questa volta non trova successo:
mentre esulta per la strage che va seminando, tu lo trafiggi
con un palo temprato al fuoco, dove il collo si congiunge
all'omero. Reto manda un gemito, a stento svelle il palo infisso
nell'osso, ed ora è lui a fuggire immerso nel proprio sangue.
Fuggono con lui Orneo, Licabante e Medonte, ferito
alla spalla destra, e ancora Pisenore, Taumante,
e Mermero, che aveva appena vinto una gara di corsa,
ma che ora, riportata una ferita, correva più piano;
e Folo, Melaneo e Abante, gran sterminatore di cinghiali;
ed Astilo, l'indovino, che aveva invano sconsigliato ai suoi
la battaglia. A Nesso, che temeva di rimaner ferito, aveva
anche detto: "Non fuggire: all'arco di Eracle sei tu destinato!".
Ma alla morte non si sottrassero né Eurinomo né Licida,
Areo e Imbreo: tutti li colpì di fronte la destra
di Driante; ma anche tu, Creneo, di fronte fosti colpito,
benché per fuggire avessi voltato le spalle: mentre guardavi
indietro, ricevesti infatti un ferro immane
fra gli occhi, dove il naso si unisce alla fronte.
In mezzo a tutto quel frastuono, Afida giaceva assopito
in un sonno senza fine, senza che nulla lo svegliasse;
lungo disteso sulla pelle irsuta di un'orsa dell'Ossa,
teneva nella languida mano una coppa di vino allungato.
Malgrado non brandisse armi, Forbas, appena lo vide,
impugnò un giavellotto, dicendo: "Vatti a bere vino
allungato con acqua dello Stige!", e senza porre indugi
lo scagliò contro il giovane e, poiché per caso giaceva supino,
l'asta con la sua punta di ferro si conficcò nel collo.
Non si accorse di morire: dalla sua gola a fiotti
il sangue nero colò sul giaciglio e fin dentro la coppa.
E con i miei occhi vidi Petreo che cercava di sradicare
una quercia carica di ghiande: mentre la stringe fra le braccia
e la scuote da ogni parte squassandone il tronco ormai vacillante,
la lancia di Piritoo gli si pianta tra le costole
inchiodandogli al duro legno il petto impegnato in quella fatica.
Per mano di Piritoo si dice che sia caduto Lico,
per mano di Piritoo Cromi; ma nessun dei due
gli procurò tanta gloria quanta vincere Dicti ed Elope.
Elope fu trafitto da una lancia che, aprendosi un varco
nella tempia, da destra penetrò sino all'orecchio di sinistra.
Dicti, mentre si gettava giù dallo sperone opposto del monte
per sfuggire affannosamente al figlio d'Issione che l'incalzava,
precipitò in un dirupo e col peso del corpo spezzò
un orno immenso, ricoprendone di viscere i frammenti.
Per vendicarlo accorre Afareo che, divelto dal monte un macigno,
tenta di scagliarlo; ma mentre tenta, Teseo, il figlio di Egeo,
l'investe con una mazza di quercia e gli fracassa l'osso grosso
del gomito; poi, senza aver voglia e tempo di finire quel corpo
ormai ridotto all'impotenza, salta in groppa al gigantesco
Biènore, che in groppa solo sé stesso era avvezzo a portare;
con le ginocchia gli stringe i fianchi, gli afferra in una morsa
i capelli con la sinistra e col nodoso randello gli spacca
la faccia, la bocca che impreca e le tempie durissime.
E con quel randello abbatte Nedimno, l'arciere Licope,
Ippaso che aveva il petto protetto da una barba
fluente, Rifeo che sovrastava la cima delle selve,
e infine Tereo che si portava nella tana, vivi e righianti,
gli orsi catturati sui monti dell'Emonia.
Demoleonte non tollerò più che Teseo di vittoria
passasse in vittoria: già da un pezzo tentava con gran sforzo
di sradicare dal suolo compatto un vecchio pino;
non riuscendovi, lo spezzò scagliandolo contro il nemico.
Ma Teseo, messo in guardia da Pallade, schivò l'arma
in arrivo scostandosi: così lui voleva che si credesse.
Tuttavia il tronco non cadde a vuoto: dal collo staccò
lo sterno e la spalla sinistra dello smisurato Crantore.
Costui era stato scudiero di tuo padre, Achille:
il re dei Dolopi, Amintore, sconfitto in guerra, l'aveva dato
al figlio di Eaco come pegno di pace e prova di lealtà.
Come Peleo lo vide devastato da quell'orrenda ferita:
"Crantore, fra tutti diletto, accetta almeno queste esequie!"
gridò e con tutta la forza del braccio, e in più con quella
della rabbia, scagliò contro Demoleonte una lancia di frassino,
che gli sfondò torace, costole e s'infisse tra le ossa vibrando.
Lui con la mano riesce ad estrarne il legno, ma non la punta,
e anche quello a fatica: la punta resta bloccata nel polmone.
Ma è proprio il dolore ad accrescergli il coraggio:
soffrendo s'impenna sul nemico e lo calpesta con i suoi zoccoli.
Peleo sostiene quella scarica di colpi con l'elmo e lo scudo,
si protegge le spalle, tende le armi verso l'alto
e con un sol colpo trafigge l'uno e l'altro petto del centauro.
Ma prima da lontano aveva già ucciso Flegreo
ed Ile, e in scontri corpo a corpo Ifinoo e Clani.
A questi va aggiunto Dorila, che portava a scudo delle tempie
una pelle di lupo e, spaventose come armi d'offesa,
corna ricurve di toro, tutte rosse di sangue.
A costui io gridai (il furore mi accresceva le forze):
"Vedrai quanto inferiori siano le tue corna al ferro mio!",
e scagliai il giavellotto. Lui, non potendolo evitare,
si parò con la destra la fronte in procinto d'essere colpita:
inchiodata alla fronte gli restò la mano. Si levò un clamore
e, mentre quello, stravolto dal dolore, era impietrito, Peleo,
che gli era più vicino, con la spada lo trafisse in mezzo al ventre.
Dorila fece un balzo e nell'impeto trascinò a terra le viscere,
e nel trascinarle le calpestò, nel calpestarle le squarciò,
v'impigliò le zampe e crollò sul ventre ormai svuotato.
Né in battaglia ti salvò, Cillaro, la tua bellezza,
se bellezza si può riconoscere in esseri siffatti.
Barba incipiente, barba color d'oro, e d'oro
la chioma che dalle spalle gli spioveva giù sino ai fianchi;
volto forte e attraente; collo, spalle, mani
e torace come quelli delle statue più celebrate,
e così ogni parte umana; ma, sotto queste, anche le forme equine
sono perfette e per nulla inferiori: dagli collo e testa equina,
sarebbe degno di Castore, tanto il suo dorso è adatto alla sella
e turgido di muscoli il petto. È tutto nero, più della pece,
ma candida è la coda e bianco anche il colore degli stinchi.
Molte della sua razza lo desiderarono, ma solo Ilonome,
la femmina più graziosa che nel folto dei boschi tra quegli esseri
per metà animali sia mai vissuta, se lo prese.
Solo lei a sé tien legato Cillaro con le carezze, amandolo,
giurandogli amore, e anche, sì, curando la propria persona,
nei limiti concessi a quelle membra: rende soffici i capelli,
ora li inghirlanda di rosmarino, ora di viole,
ora di rose; ogni tanto porta con sé candidi gigli;
due volte al giorno si lava il viso ai ruscelli che nella foresta
di Pagase scendono dal monte, due volte s'immerge nel fiume,
e dalla spalla o sul fianco sinistro lascia pendere
solo pelli eleganti di bestie pregiate. Uguale amore
li lega; vagano per i monti insieme, insieme s'annidano
negli antri; ed anche allora entrati fianco a fianco
nella reggia dei Lapiti, fianco a fianco guerreggiavano a morte.
Chi l'avesse scagliato non si sa, ma un giavellotto, Cillaro,
arrivò da sinistra e ti trafisse un po' più in basso
di dove il petto si congiunge al collo. Estratta l'arma, il cuore,
pur appena sfiorato, si gelò con tutto il corpo.
Ilonome si precipita a sostenere quel corpo morente,
applicando la mano lenisce la ferita, e accosta la bocca
alla bocca tentando di fermare l'anima che fugge.
Come lo vede spento, con parole che il frastuono m'impedì
di udire, si getta su quell'arma che l'ha trafitto
e, spirando, stringe in un abbraccio il marito suo.
E ho ancora davanti agli occhi Feocome, che aveva avvinto
con un intrico di nodi sei pelli di leone per proteggere
la parte umana e quella equina allo stesso tempo. Scagliando
un tronco, che a stento avrebbero smosso due coppie di buoi,
costui fracassò da capo a piedi Tectafo, figlio di Oleno.
[Frantumata l'enorme scatola del cranio, dalla bocca,
dalla cavità delle narici, degli occhi e delle orecchie
gli colò a rivoli il cervello, come fa il latte rappreso
da graticci di quercia o come stilla un liquido sotto pressione
dalle maglie di un setaccio, gocciolando denso dai fitti fori.]
Ma io, mentre quel predatore si accingeva a spogliare
delle armi il caduto (tuo padre lo sa), gli affondai la spada
nel basso ventre. Anche Ctonio e Telebas caddero
sotto la mia spada: il primo brandiva un ramo a corna,
l'altro un giavellotto con cui m'inferse una ferita.
Puoi vederne il segno: la vecchia cicatrice si distingue ancora.
Allora avrebbero dovuto mandarmi alla conquista di Troia;
allora avrei potuto, se non vincere, almeno arginare le armi
del grande Ettore con le mie. Ma a quel tempo Ettore
non esisteva oppure era bambino; ora l'età mi ha indebolito.
Perché narrarti di Perifante che vinse il duplice Pireto?
o di Ampico che piantò un'asta di corniolo
senza punta in pieno volto allo scalpitante Echeclo?
Con una spranga scagliata nel petto Macareo di Peletronio
atterrò Erigdupo; e anche ricordo che una picca
fu piantata dalla mano di Nesso nell'inguine di Cimelo.
E non credere che Mopso, il figlio di Ampico, rivelasse
soltanto il futuro: per un suo giavellotto stramazzò
il biforme Odite, mentre tentava invano di parlare
con la lingua inchiodata al mento e il mento inchiodato alla gola.
Ceneo aveva ucciso cinque nemici: Stifelo, Bromo,
Antìmaco, Elimo e Piracte che brandiva una scure;
non ricordo come li ferì: ho in mente solo il numero e i nomi.
Contro gli si lancia, armato delle armi di Aleso d'Emazia
che aveva ucciso, Latreo, di statura e membra smisurate:
era di un'età di mezzo, tra gioventù e vecchiaia;
di un giovane aveva il vigore, ma le tempie brizzolate.
Imponente, con scudo, spada e picca
macedone, col viso rivolto alle opposte schiere,
squassò le armi e al galoppo descrisse giri su giri,
riversando tutt'intorno nell'aria queste focose parole:
"Anche te, Ceni, dovrò sopportare? Donna per me sarai sempre,
sarai sempre Ceni. Ti sei scordata la natura
in cui sei nata, non ti torna a mente perché sei stata premiata,
a quale prezzo ti sei acquistata questo falso aspetto d'uomo?
Ripensa come sei nata o cosa hai dovuto subire, e vai, prendi
conocchia e cestino, fila col pollice la lana,
e lascia la guerra agli uomini!". Mentre così si vantava,
Ceneo scaglia una lancia e gli trapassa il fianco teso nella corsa,
dove l'uomo si congiunge al cavallo. Folle di dolore,
Latreo colpisce con la picca il viso indifeso del giovane.
La picca rimbalza, come la grandine sulla cima di un tetto
o come un sassolino lanciato contro la pelle di un tamburo.
Allora ingaggia un corpo a corpo, cercando d'affondargli la spada
nel fianco acerbo; ma per quella non esiste un varco.
"Eppure non mi sfuggirai, no!" grida. "Ti sgozzerò a fil di spada,
visto che la punta si smussa." E, volta la spada di taglio,
gli allunga da destra un gran fendente attraverso il ventre.
L'impatto sul corpo sprigiona un gemito, come colpo sul marmo,
e battendo sul callo della pelle, la lama va in mille pezzi.
Stanco infine di offrire il fianco illeso all'avversario attonito,
Ceneo: "Avanti," disse, "mettiamo ora alla prova il tuo corpo
col ferro mio!", e immerse sino all'elsa la spada omicida
nel petto di Latreo, gliela girò e rigirò alla cieca
nelle viscere, producendogli squarci su squarci.
Allora con immenso strepito i Centauri furibondi
si scatenano e solo contro lui rivolgono e scagliano le armi.
Ma queste cadono spuntate e Ceneo, figlio di Elato,
sotto tutti quei colpi resta indenne, senza una macchia di sangue.
Quel prodigio lascia tutti interdetti. "Oh, vergogna infinita!"
esclama Monico. "Da un uomo solo, un uomo?, noi, un popolo,
siam vinti. Ma lui, sì, che è un uomo; noi, per viltà nostra
siamo come era lui un tempo! A che servono queste membra
immani e la forza di due creature, il fatto che la natura
abbia in noi combinato due tra gli esseri più forti?
Non sembra davvero che nostra madre sia una dea e Issione,
ch'era tanto grande da concepire speranze sulla divina
Era, nostro padre: ci lasciamo battere da un mezzo uomo.
Rovesciategli addosso rocce, tronchi e monti interi,
soffocategli quell'anima tenace sotto un cumulo di alberi.
Che una foresta gli schiacci la gola: a ucciderlo penserà il peso!"
E urlando, trovato un tronco abbattuto dalle raffiche furiose
dell'Austro, lo scagliò contro quel nemico invincibile.
Fu come un segnale: in pochi istanti l'Otri si ritrovò
privo di piante e il Pelio non ebbe più un filo d'ombra.
Sepolto sotto quel cumulo immane, Ceneo, oppresso dal peso,
smania e, facendo forza con le sue spalle, sostiene i tronchi
che si ammucchiano. Ma poi quando sul capo e il viso gli cresce
la mole e il suo respiro non trova più aria per nutrirsi,
comincia un poco a cedere e invano ora cerca di drizzarsi
per raggiungere l'aria e scrollarsi di dosso la foresta;
e un poco la smuove, ecco, come se l'alto Ida,
che da qui vediamo, fosse scosso da un terremoto.
L'esito è incerto: alcuni dicevano che il peso dei tronchi avesse
schiacciato il corpo spingendolo fin dentro al Tartaro senza vita.
Per il figlio di Ampico no: da sotto la catasta aveva visto
uscire nel cielo limpido un uccello dalle ali fulve,
un uccello che anch'io vidi allora per la prima e l'ultima volta.
Come lo scorse che con lento volo volteggiava
sulle sue schiere, diffondendo intorno grandi strida, Mopso,
seguendolo insieme con lo sguardo e col cuore, disse:
"Salute a te, gloria del popolo dei Lapiti,
eroe grandissimo, Ceneo, finora ed ora uccello unico!".
Per la sua autorità fu creduto. E il dolore accrebbe la furia,
sdegnati che i nemici avessero in tanti annientato un uomo solo.
E non cessammo di sfogare in armi il nostro dolore, fin quando
parte di loro non fu uccisa e l'altra posta in fuga nella notte".
Mentre l'eroe di Pilo raccontava la lotta tra i Lapiti
e i Centauri per metà uomini, Tlepolemo non tollerò
che avesse taciuto del nipote di Alceo e addolorato
disse: "Mi stupisce, vegliardo, il tuo silenzio sulle gesta
gloriose di Eracle. In verità mio padre era solito
raccontarmi d'aver domato i figli della Nuvola".
Gli rispose afflitto Nestore: "Perché mi costringi a ricordare
le mie sofferenze, a riaprire piaghe rimarginate dagli anni,
a confessare che nutro odio e risentimento verso tuo padre?
Egli ha compiuto imprese, mio dio, incredibili, ha riempito
dei suoi meriti il mondo, cosa che vorrei poter negare.
Ma noi non tessiamo l'elogio di Deifobo o Polidamante,
nemmeno di Ettore: chi infatti farebbe le lodi di un nemico?
Proprio tuo padre distrusse un giorno le mura dei Messeni,
diroccò Elide e Pilo, città innocenti,
irrompendo col ferro e col fuoco nella mia casa.
Per non parlare di tutti gli altri che uccise;
noi figli di Neleo eravamo dodici, dodici bei giovani:
tutti quanti caddero, tranne me solo, abbattuti dalla mano
di Eracle. E che gli altri potessero soccombere si può capire;
ma la morte di Periclìmene, al quale Poseidone, capostipite
della stirpe di Neleo, aveva concesso di assumere tutte
le forme che voleva e di deporle una volta assunte, è incredibile.
Dopo avere inutilmente assunto i più vari aspetti, Periclìmene
si era mutato nell'uccello che, carissimo al re degli dei,
suole portare i fulmini serrati tra gli artigli.
Usando la forza di quest'uccello, aveva con le ali, col becco
adunco e con le grinfie dilaniato il volto all'eroe di Tirinto:
Eracle allora tese l'arco, sin troppo preciso, contro l'aquila
e, mentre questa si librava a grande altezza fra le nubi,
la colpì dove l'ala s'innesta nel fianco.
Ferita non grave, ma i tendini lacerati dal colpo cedono
e non offrono più l'energia necessaria per volare.
Così cadde al suolo, perché le ali fiaccate non prendevano
più l'aria, e la freccia sottile conficcata nell'ala affondava,
spinta dalla pressione, nel corpo trafitto,
uscendo attraverso la cima del fianco a sinistra della gola.
Ti sembra dunque ch'io debba decantare il tuo Eracle,
o glorioso capo della flotta di Rodi?
Mi limito solo, per vendicare i miei fratelli, a non parlare
delle sue grandi gesta; ma la mia amicizia per te resta salda".
Dopo che il vecchio figlio di Neleo ebbe narrato questi eventi,
al termine del suo racconto, si tornò a gustare il vino
e ci si alzò dai divani. Il resto della notte fu dato al sonno.
Ma il dio, che col tridente governa le onde del mare, piange
nella sua mente di padre la metamorfosi del figlio Cigno
nell'uccello caro a Fetonte e, detestando lo spietato Achille,
cova un'ira implacabile, più di quanto sia lecito e civile.
La guerra ormai si trascinava da quasi un decennio;
si rivolge ad Apollo, il dio di Sminta dai lunghi capelli:
"O tu che tra tutti i figli di mio fratello mi sei il più caro,
tu che con me hai costruito inutilmente le mura di Troia,
non ti affliggi guardando questa rocca ormai sul punto di crollare?
non ti addolorano le migliaia di guerrieri caduti
per difenderne i bastioni? o, per non ricordarteli tutti,
hai davanti solo l'ombra di Ettore, trascinato intorno a Pergamo?
E intanto il terribile Achille, più cruento della guerra stessa,
devastatore dell'opera nostra, Achille vive ancora!
Datelo a me: gli farò sentire cosa è in grado di fare
il mio tridente. Ma poiché non posso scontrarmi con lui
faccia a faccia, annientalo tu di sorpresa con una freccia occulta!".
Il nume di Delo acconsentì e, indulgendo al proprio impulso
e a quello dello zio, si recò avvolto di nebbia
tra le schiere troiane e, in mezzo alla carneficina,
scorse Paride che ogni tanto tirava una freccia contro Achei
senza nome. Fattosi riconoscere: "Perché", gli disse, "sprechi
i tuoi dardi con gente plebea? Se ti stanno a cuore i tuoi,
rivolgiti contro il nipote di Eaco e vendica i fratelli uccisi".
Così disse e, indicandogli il figlio di Peleo che faceva strage
di Troiani con la spada, gli girò l'arco contro e con la destra
micidiale gli fece scoccare un dardo che fu infallibile.
Se mai dopo la morte di Ettore il vecchio Priamo poté gioire,
quello fu il momento. E così tu, vincitore di tanti guerrieri,
sei vinto, Achille, dal pavido rapitore di una sposa greca!
Ma se era destino che dovessi cadere per mano femminea,
sotto la scure del Termodonte avresti preferito morire.
Ormai il terrore dei Frigi, vanto e difesa del nome greco,
il discendente di Eaco, capo invincibile in guerra, dalle fiamme
è stato arso: il nume che l'ha armato, quello ha acceso il fuoco.
Ormai è cenere; e di quell'Achille che fu tanto grande
resta un'inezia, che nemmeno basta a riempire un'urna minuscola.
Ma la gloria, quella è ben viva e tale da riempire il mondo intero.
Una dimensione degna dell'uomo; in lei il figlio di Peleo
è pari a sé stesso e non avverte il vuoto del Tartaro. Persino
il suo scudo, perché tu possa comprendere a chi appartenne,
scatena battaglie e per le sue armi si prendono le armi.
Non osano reclamarle né il figlio di Tideo o Aiace,
figlio di Oileo, il minore degli Atridi o il maggiore per età
e imprese, e nessun altro: soltanto il figlio di Telamone
e quello di Laerte hanno l'ardire di aspirare a tanto onore.
Ma il discendente di Tantalo rifiuta l'onere odioso
di dirimere la contesa e, radunati i capi argivi al centro
dell'accampamento, rimette la sentenza al giudizio di tutti.