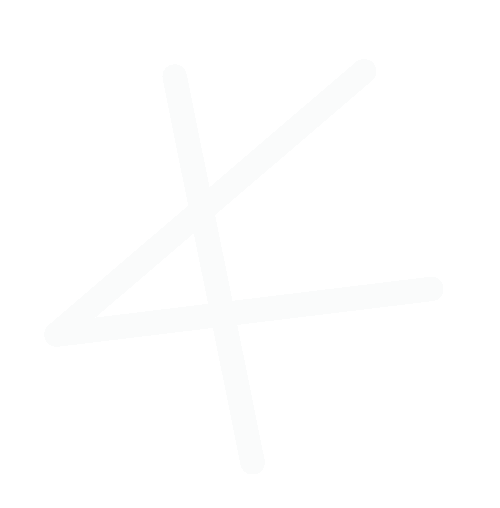Biblioteca:Lo Scudo di Eracle
O come, abbandonate le case e la terra paterna,
seguendo Anfitrione possente guerriero, la figlia
d'Elettrione venne, pastore di popoli, a Tebe.
Essa brillava su tutta la molle feminea stirpe,
di forma, di statura: fra quante mortali ai Celesti
diedero figlie, nessuna con lei contendeva di senno:
a lei dal capo giú, dalla chioma cerulëa bruna,
spirava un'aura, come da Cipride, l'aurëa Diva.
E tanto ella in cuor suo venerava lo sposo diletto,
quanto nessuna mai l'onorò delle tenere donne,
sebbene ucciso il padre le aveva, ché in pugna lo vinse,
ch'era adirato pei bovi. Fuggiasco dal suolo paterno,
a Tebe venne, e volse la prece ai Cadmei valorosi.
E con la casta sposa quivi egli abitava, ma privo
del genïale amore: ché ascendere il letto d'Alcmena
dai bei malleoli, gli era conteso, se pria non avesse
tratta vendetta dello sterminio dei prodi fratelli
della sua sposa, ed arse, col fuoco che tutto distrugge,
dei Teleboi, dei Tasi, prodissimi eroi, le borgate.
Tale il destino suo: ne furon gli Dei testimoni.
Ed ei, l'ira dei Numi temendo, a compir s'affrettava,
quanto poteva piú, la gran gesta prescritta da Zeus.
Ed i Beoti con lui, bramosi di pugne e di zuffe,
usi a sferzare cavalli, terribili sotto i palvesi,
e i Locri, usi a combatter da presso, ed i prodi Focesi,
seguiano: era signore di questi il figliuolo d'Alceo,
fiero dei popoli suoi. Ma degli uomini il padre e dei Numi
altro consiglio volgeva: volea generar contro il male,
pei Numi e pei mortali che cibano pane, uno schermo.
E dall'Olimpo balzò, macchinando nel cuore un inganno,
di notte, ché bramava l'amor della donna elegante.
A Tifaone presto pervenne, ed ancora movendo,
giunse alla vetta piú alta del Ficio il saggissimo Zeus.
E quivi stette, e volse la mente a un'impresa divina:
ché, nella stessa notte, d'Alcmena dall'agil caviglia
il letto ascese Zeus, l'amò, sazïò la sua brama.
Ed anche Anfitrione, l'eroe condottiero di turbe,
compiuta la gran gesta, tornò quella sera al suo tetto.
Né tra i famigli andò, non andò fra i pastori nei campi,
ma pria della sua sposa nel talamo venne l'eroe:
tal desiderio ardeva nel cuore al pastore di genti.
Come allorquando un uomo sfuggito a un malanno s'allegra,
quando abbia un grave morbo fuggito, o una dura prigione,
Anfitrione cosí, compiuta la dura sua gesta,
alla sua casa giunse con cuore giocondo e felice.
E giacque con la casta consorte per tutta la notte,
le gioie d'Afrodite godendo, dell'aurëa Diva.
E da un Celeste amata la donna, e da un uomo perfetto,
nella settemplice Tebe die' a luce due gemini figli.
Ma l'uno uguale all'altro non eran, sebbene fratelli:
ché l'uno era da meno, di molto migliore era l'altro
figliuolo: Eracle esso era, gagliardo, terribile, invitto.
Questo la donna al figlio di Crono dai nuvoli negri
concetto aveva; ad Anfitrione signore di genti
Ificle: ben diversi rampolli: ché l'uno a un mortale,
e l'altro avea la donna concetto al Signor dei Celesti.
E questi Cigno uccise, di Ares il magnanimo figlio,
ché lo trovò nel bosco d'Apollo che lungi saetta,
lui con suo padre Ares, che mai non è sazio di guerre,
chiusi nell'armi, come barbagli di fiamma che arda,
ritti sul carro ambedue: scalpitavano i ratti corsieri,
l'unghie battevano, e intorno bruciava la polvere ad essi,
percossa sotto il carro massiccio ed il pie' dei cavalli.
Il ben costrutto cocchio squillava, squillavan le ruote,
correndo i due corsieri. Lieto era il fortissimo Cigno,
perché sperava il figlio possente di Zeus e l'auriga
uccidere col bronzo, vestirsi dell'armi sue belle.
Ma non l'udí Febo Apollo, mentr'egli pregava: ché invece
accrebbe contro lui la forza del figlio di Zeus.
E tutto quanto il bosco d'Apollo Pegàso e l'altare
riscintillava per l'armi del Nume tremendo e di Cigno,
dagli occhi loro un fuoco fulgeva. Qual mai dei mortali
l'ardire avrebbe avuto di farsi a lui contro, se togli
Eracle, e il fido suo scudiero Iolao? Ma ben grande
era di quell'eroe la forza, ma invitte le braccia
sopra le membra massicce sporgevan dagli òmeri fuori.
Al suo possente auriga, cosí disse allora, a Iolao:
«Iolao, campione a me diletto fra gli uomini tutti,
molto di certo peccò contro i Numi signori d'Olimpo,
Anfitrione, quel dí che a Tebe dal fulgido serto
venne, che avea Tirinto lasciata, la solida rocca,
poscia ch'Elettrione, pei bovi cornigeri, uccise.
Lieti lo accolsero quelli, gli diedero quanto era d'uopo,
quanto a un fuggiasco offrire si deve, e gli resero onore.
E lieto egli vivea con Alcmena sua sposa, dal vago
malleolo. E a luce noi, dopo un breve trascorrere d'anni,
tuo padre ed io venimmo, che d'indole pari e di senno
non eravamo punto: ché il senno a lui tolse il Cronide,
sicché, la casa sua lasciata ed i suoi genitori,
partí, ché volle un uomo ribaldo onorare, Euristeo.
Lo sciagurato poi dové farne gran pianto, e pentirsi
del fallo suo; ma piú revocarlo, possibil non era.
Gravi travagli a me un Demone invece prescrisse.
O mio caro, su via, stringi or tu le purpuree briglie
dei rapidi corsieri, moltiplica in seno l'ardire,
il carro e dei veloci corsieri la forza diritto
avventa, e non temere di Ares omicida il frastuono,
che con acute grida va or furïando pel bosco
sacro d'Apollo Febo, del Dio che lontano saetta.
Sazio dovrà dichiararsi, per quanto sia forte, di guerra».
E questo a lui Iolao, rispose, l'eroe senza pecca:
«O caro, assai, di certo degli uomini il padre e dei Numi,
assai l'Enosigeo t'onora, che vago è di tori,
che l'alte mura e la rocca di Tebe possiede e protegge:
tale un mortale, cosí gigante, cosí valoroso,
sotto le mani tue conducon, ché gloria tu n'abbia.
Su' dunque, indossa l'armi di guerra, ché, senza indugiare,
l'uno su l'altro i carri lanciando, di Ares ed il nostro,
si pugni; ei non potrà spaventare il figliuolo di Zeus
senza paura, né d'Ificle il figlio; ma penso che invece
egli fuggire dovrà dai figli del figlio d'Alceo
che sono presso a lui, che cupidi sono di guerra,
cupidi della zuffa, che a lor grata è piú del banchetto».
Disse cosí. Sorrise, ché in cuore godeva, la forza
d'Eracle: tanto a lui tornarono grati quei detti.
E gli rispose, e a lui parlò queste alate parole:
«Iolao, saldo campione nutrito da Zeus, non lungi
è l'aspra pugna, e tu, come fosti sin qui valoroso,
Aríone, il gran cavallo dai ceruli crini, anche adesso
in giro spingi, e piú che puoi, dammi aiuto alla pugna».
E, cosí detto, alle gambe d'attorno legò gli schinieri
di lucido oricalco, d'Efesto bellissimo dono,
i fianchi cinse poi tutto in giro col bel corsaletto
istorïato, foggiato nell'oro: l'aveva donato
a lui Pallade Atena, la figlia di Zeus, quand'egli
dovea la prima volta provarsi nei duri cimenti.
Poi quel tremendo, il ferro che tiene lontana la morte,
sugli omeri adattò: fissandolo al petto, il turcasso
concavo, dietro le spalle gittò: dentro v'erano molte
frecce, di muta morte ministre, di brividi orrendi.
In punta avevano esse la morte, stillavano pianto,
erano levigate nel mezzo, lunghissime, e dietro
velate con le piume dell'aquila fulvida negra.
La lancia indi impugnò, con la punta di lucido bronzo,
orrida, sopra il capo gagliardo una gàlea pose,
istorïata di fregi, infrangibile, adatta alle tempie:
d'Eracle il capo questa schermiva, del fig lio di Zeus.
Poscia lo scudo, vario d'agèmine, prese; né alcuno
franto lo avrebbe, ammaccato di colpi: stupore a vederlo.
Ché tutto quanto in giro, di smalto e di candido avorio
riscintillava, e d'oro fulgea tutto quanto e d'elettro.
Un drago, poi dal centro spirava indicibile orrore,
che con pupille oblique fissava, e brillava di fuoco;
e nella bocca una fila correva di candide zanne,
terribili, funeste. Sovr'essa l'orribil sua fronte,
Eris svolazzava, che gli uomini a guerra schierava,
funerëa, che il cuore, che il senno rapiva ai mortali
che faccia a faccia, contro pugnassero al figlio di Zeus.
Erano ancora qui figurati l'Attacco e la Fuga,
la Strage quivi ardea, lo Strepito ardea, l'Omicidio,
vi furïava il Tumulto, la Rissa, la Parca funesta,
che un uomo or or ferito stringeva, uno illeso, ed un altro
morto, e lo trascinava, ghermitolo al piè, tra la zuffa.
L'anime loro, poi, s'immergono sotto la terra,
entro nell'Ade, l'ossa d'intorno alla madida pelle
si putrefanno sul negro terreno alla vampa di Sirio.
Bruna di sangue umano sugli òmeri aveva una veste,
terribilmente guatava, gridava, strillava a gran voce.
E, piú che non si dica, terribili, teste di serpi
v'erano, dodici; e in seno spiravan terrore ai mortali
che a faccia a faccia contro movessero al figlio di Zeus.
Alto suonava dei denti lo strepito, quando pugnava
d'Anfitrione il figlio, mandavano fiamme le insegne.
Eran varïegati di punti gli orribili draghi:
azzurri sopra il dorso, ma negre parean le mascelle.
E branchi c'eran poi di cinghiali selvaggi e leoni,
che gli uni sopra gli altri gittavano gli occhi furenti,
cupidi, e andavan fitte le loro falangi; né questi
tremavano, né quelli: sul collo, irti i crini ad entrambi.
Ché già spento un immane leone giaceva, ed intorno,
privi di vita due cinghiali, e di sotto stillava
a terra il negro sangue. Cosí, le cervici stroncate,
giacevan dove uccisi li avevan gli orrendi leoni.
E piú crescea di zuffe la furia e l'émpito, in questi
e in quelli, apri selvaggi, leoni dagli occhi di fuoco.
C'era la zuffa poi dei Lapiti maestri di lancia,
col re Ceneo, Drianta, Piritoo, Proloco, Opleo,
Falero, Esodio, Mopso d'Ampico figliuol, Titaresio
prole di Ares, Teseo figliuolo d'Egeo, pari ai Numi:
essi d'argento, l'armi che ai fianchi cingevano, d'oro.
Eran dall'a ltra parte raccolti i Centauri, alla pugna,
intorno al gran Petraio, ad +sbolo vate d'augelli,
ad Arto, a Ureo dai negri capelli, a Mimante, a Drialo,
ai due Peucidi, a Perimedeo: tutti quanti foggiati
eran d'argento, e abeti stringevano d'oro fulgente.
E, fatto impeto insieme, cosí come fossero vivi,
con l'aste e con gli abeti da presso veniano alla pugna.
Ed eran qui di Ares terribile i ratti corsieri,
d'oro; e lo stesso Ares funesto s'ergea tutto in arme,
che un giavellotto in pugno stringeva, eccitava le turbe,
di sangue tutto brutto, che agli uomini, ritto sul carro,
togliea la vita; e presso gli stavan Terrore e Sgomento,
ch'erano tutti brama d'irrompere in mezzo alla pugna.
La Tritogenia figlia di Zeus, la vaga di prede,
v'era, e sembrava come volesse apprestare la pugna:
ché l'asta e l'elmo d'oro dal triplice ciuffo reggendo,
l'Egida su le spalle, moveva alla cruda battaglia.
Ed una danza v'era di Superi, sacra: nel mezzo,
soavemente il figlio di Leto e di Zeus cantava
sopra la cetera d'oro. Dei Numi la sede, l'Olimpo
v'era, e una piazza, e attorno, corona di Numi infinita
a contemplare una gara. Le Muse Pieridi, al canto
davan principio, e voci di femmina avevano, acute.
Di buon ormeggio un porto, nel pelago senza riparo
effigïato v'era, di stagno purissimo, tondo,
e che ondeggiasse pareva. Nel mezzo, parecchi delfini
guizzavano qua e là correndo, alla caccia dei pesci.
E nuotatori v'eran: due d'essi sbuffavano l'acqua;
e innanzi a loro, i pesci fuggivan, foggiati nel bronzo.
Un pescatore sedea su la spiaggia, e spiava, e una rete
da pesci aveva in mano, parea che volesse gittarla.
Di Danae chioma bella poi v'era, scolpito nell'oro,
il figlio Perseo, e ai piedi cingeva gli alati calzari.
E non toccava coi pie' lo scudo, né pur n'era lungi:
gran meraviglia a vederlo, ché punto non v'era poggiato:
con le sue mani cosí lo costrusse l'insigne Ambidestro.
Dal bàlteo, su le spalle pendeva una spada di bronzo
dai negri fregi: a volo movea, come vanno i pensieri,
l'eroe. Tutta la schiena copria della Gorgone il capo,
del mostro orrido; e tutta, stupore a veder, la cingeva
una bisaccia d'argento, svolavano lucide frange
d'oro; e, tremendo, il casco d'Averno stringeva al signore
la fronte; e lo cingeva notturna caligine fosca.
Ed il figliuol di Danae, com'uomo che abbrivida e fugge,
si distendeva al corso. Si precipitavan su lui,
insazïabili quanto nessuno può dir, le Gorgoni,
bramose di ghermirlo. Squillava dal pallido ferro,
sottessi i passi loro, lo scudo con alto fracasso,
tinnulo acuto; e sopra la cintola a ognuna di loro
si svincolavano due dragoni, inarcando le teste.
E lingueggiavano entrambi, nell'ira aguzzavano i denti,
terribilmente guatando. Sovresse le orrende cervici
delle Gorgoni, orrore torcevasi immane. - Al disopra,
uomini, d'armi guerriere coperti, pugnavano: questi
che dalla strage schermo facevano ai proprî parenti,
alla città: quegli altri tentavan di metterla a sacco.
Molti giacevano: i piú, capaci tuttor di pugnare,
pugnavano; e sovresse le torri di bronzo, le donne
si laceravan le gote, levavano acute le grida,
simili a donne vive: ch'Efesto le aveva scolpite.
E gli uomini d'età, che avea già ghermiti vecchiaia,
stavano fuor dalla porta raccolti, ed alzavan le mani
verso i Beati Celesti, temendo pei loro figliuoli.
Ed alla pugna questi badavano intanto. E le Parche
livide, dietro ad essi, dai candidi denti stridendo,
torve, terribili, tutte coperte di sangue, implacate,
rissa d'intorno ai caduti facevano, cupide tutte
di bere il negro sangue. E quei che ghermissero prima
già spento, oppur caduto ferito di fresco, su quello
l'immani unghie una d'esse gittava, e lo spirito all'Ade,
al Tartaro cruento scendeva. E quand'eran poi sazie
di sangue umano, dietro di sé lo gittavano, e ancora,
novellamente, correndo, moveano alla strage, al tumulto.
Cloto e Lachesi innanzi movevano a tutte. Piú fiacca
Atropo, e di statura piú bassa, ma d'anni piú grave
era di tutte l'altre, ché prima venuta era al giorno.
Tutte pugnavano a un uomo d'intorno una zuffa crudele,
e l'una contro l'altra volgevano gli occhi furenti,
l'unghie provavano l'una su l'altra, e le mani rapaci.
E presso a loro stava la querula Ambascia odïosa,
pallida, magra, cascante di fame, le gambe stecchite,
e l'unghie lunghe lunghe sporgean dalle dita: colava
dalle narici moccio, cadevano giú dalle guance
stille di sangue; ed essa, con grande stridore di denti,
stava, e sugli òmeri suoi si addensava la polvere fitta,
molle di pianto. - E presso, sorgeva una rocca turrita,
da sette porte d'oro difesa, connesse ben salde
dagli architravi. E dentro, le genti, in carole e in festini,
si sollazzavano. Alcuni, in un carro di rapide ruote,
guidavano allo sposo la sposa. Il sonoro imeneo
volava: in man le ancelle reggevan le fiaccole accese,
ed il fulgore lontano volava. Movevano innanzi
esse, di gioventú fiorenti: seguivano a schiere
i danzatori. Quelle, dai teneri labbri, al concento
delle sampogne acute levavano il canto, ed intorno
si rifrangeva l'eco. Guidavano al suon delle cetre
quelli l'amabile danza. - Poi giovani, altrove, in tripudio
al suon del flauto, questi godevan di balli e di canti,
quelli ridevano; e avanti movevano, ognuno seguendo
un suonator di flauto; e danze, piaceri, festini
empievan la città tutta quanta. - Dinanzi alla rocca,
genti ai cavalli in groppa correvano. - Intenti all'aratro
scalzavano i bifolchi, succinte le vesti, la terra
divina. E c'era un campo di biade, profondo; ed alcuni
con gli affilati falcetti mietevano i calami lunghi
gravi di spighe, onde poi si frange di Demetra il dono;
altri in covoni poi le stringevan, battevano l'aia.
E chi pei gran vigneti, dei vendemmiatori, alle ceste
grappoli bianchi e neri portava, di pampani gravi
tutti, e d'argentei viticci, chi colmi portava i canestri.
Ed una vigna d'oro quivi era, d'Efesto lo scaltro
opera egregia; e scoteva le foglie sui pali d'argento,
carica tutta quanta di grappoli; e i grappoli, neri.
E chi pigiava, e chi beveva. - Coi pugni, alla lotta,
si misuravano altri. - Correvano dietro alla lepre
i cacciatori, e i cani dai denti crudeli dinanzi:
questi ghermirle, quelle fuggire anelavano. - E presso
avean cavalïeri contesa fatica e travaglio
per una gara: stavan sui solidi carri, gli aurighi,
lente lasciando le briglie, sferzando i veloci cavalli;
e con gran romba i carri massicci volavano, i mozzi
stridevano alto; e mai non cessava la loro fatica:
ché la vittoria a nessuno rideva, era incerta la gara.
E nella lizza era esposto il premio d'un tripode grande,
opra d'Efesto, l'artefice scaltro, foggiato nell'oro. -
Correva presso all'orlo l'Oceano, pareva rigonfio,
e tutto quanto cingeva lo scudo scolpito. E su quello,
cigni per l'aria, con alto clamore volavano, a sommo
altri nuotavan dell'acque, d'intorno scherzavano pesci.
Era una meraviglia vederlo, sia pure per Zeus
sire del tuono, pel cui comando lo scudo massiccio
grande, manevole, Efesto costrusse. Il figliuolo di Zeus
lo palleggiava con mano gagliarda.
Balzò sopra il carro,
che folgore sembrò lanciata dal padre tonante,
con salto agile; e accanto l'auriga gagliardo Iolao
a lui balzò, reggendo le briglie del carro ricurvo.
E venne presso a loro la Diva occhicerula Atena,
infuse in essi fede, con queste veloci parole:
«O di Linceo, l'eroe glorïoso progenie, salute.
Zeus che impera sui Numi beati, gran gloria v'accorda,
che morte a Cigno diate, che l'armi sue belle indossiate.
E un'altra cosa, o prode fra tutti i mortali, ti dico:
allor che della vita sua dolce avrai Cigno privato,
lascialo, lascia l'armi sue belle ove cadde; e tu fissa
Ares omicida, mentre s'avanza, ove ignudo lo vegga,
sotto lo scudo ornato: qui vibra l'aguzzo tuo bronzo,
e indietro fatti, poi, ché fato non è che tu possa
predare né i cavalli del Nume, né l'armi sue belle.
Poi ch'ebbe detto cosí, sul cocchio la Dea fra le Dive,
che la vittoria e la gloria reggea nelle mani immortali,
balzò con un gran lancio. Iolao generato da Zeus
die', con un grido orrendo, l'aíre ai corsieri; e a quell'urlo,
trassero, empiendo il piano di polvere, il cocchio veloce:
ché furia in essi infuse la Diva occhicerula Atena,
che l'Egida scoteva: rombava dintorno la terra.
E a un tempo anche moveano, parevano fuoco o procella,
Cigno, l'equestre signore, con Ares mai sazio di pugne.
E, a fronte a fronte gli uni degli altri, d'entrambi i cavalli
nitriti alti levarono, e l'eco s'effuse d'intorno.
Eracle invitto disse fra loro le prime parole:
«Perché, stolido Cigno, spingete i veloci cavalli
contro di noi, cosí sperti di pene e travagli? Su via,
fatti in disparte col carro tuo ben levigato, il cammino
lasciami libero, cedi. Io sono diretto a Trachine,
presso Ceice sovrano. Ché questi, col senno e la forza,
regna in Trachine, bene lo sai da te stesso: ché sposa
hai la sua figlia, tu, Temistonoe dai ceruli cigli.
O stolido, se mai dovessimo a pugna venire,
neppur Ares da te potrà tener lungi la morte.
Un'altra volta già, ti dico, dové fare prova
della mia lancia, quando, nei pressi di Pilo sabbiosa,
a fronte egli mi stette, per brama implacata di pugna.
Tre volte egli toccò la terra, tre volte colpito
dalla mia lancia, e forato lo scudo: la quarta, spingendo
di tutta forza, immersi nel femore il cuspide, ruppi
di gran squarcio le carni. Piombò nella palvere prono.
E stette quivi, e segno d'obbrobrio restò pei Celesti,
ché sotto le mie mani lasciò le sue spoglie cruente».
Disse cosí. Ma Cigno dall'asta di frassino, ligio
ai detti suoi non fu, rattenere non volle i corsieri;
e rimbombò, mentr'essi movevano, l'ampia terra.
Come allorché d'un monte gigante dal vertice estremo
balzano rupi giú, strapiombano l'una su l'altra,
e assai querce d'eccelso fogliame si spezzano, e pini,
e pioppi dall'eccelse radici, quando esse dall'alto
rotano impetuose, sinché non pervengono al piano:
cosí, con alte grida, piombarono l'uno su l'altro.
E tutta la città di Mirmidone, e l'inclita Jolco,
ed Arne, con Antea l'erbosa, o con Elica, un'eco
lunga a quel grido mandò. Piombarono l'uno su l'altro
con ululo infinito. Tuonò fieramente il sagace
figlio di Crono, e versò dal cielo sanguigna rugiada,
per inviare un segno di guerra al magnanimo figlio.
Come per valli alpestri selvose, terribile un apro,
con le sporgenti zanne compare, anelando la pugna,
piantato obliquamente: la bocca digrigna, la spuma
gocciola giú, le pupille somigliano a fuoco che arda,
irti sul dorso e su la criniera si drizzano i peli:
simile a questo, il figlio di Zeus discese dal carro.
Erano i dí che la bruna canora cicala, sul ramo
tenero verde, a cantare comincia l'Estate ai mortali,
che solo ha per bevanda, per cibo, la molle rugiada,
e la sua voce effonde dall'alba, sinché dura il giorno,
nell'afa esosa, quando piú Sirio prosciuga la pelle:
i dí quando le reste compaion sui chicchi del miglio,
ch'è seminato l'està, quando invàiano i grappoli acerbi,
doni di Bromio che gioie comparte ai mortali e tormenti.
Pugnarono in quei dí, della pugna fu grande il fracasso.
E come due leoni, d'intorno ad un cervo abbattuto,
l'un contro l'altro, furore spirando, si avventano, e orrendo
suona il ruggito loro, lo strepito suona dei denti:
come avvoltoi dall'unghie rapaci, dal becco ricurvo
che sopra un'alta rupe si batton con fiero clangore,
per una capra alpestre, per una selvatica pingue
cervia, che un giovinetto, vibrando una freccia dall'arco,
trafisse; ed egli poi, dei luoghi inesperto, lontano
andò vagando: quelli la videro súbito, e intorno
impetuosamente le corsero, ad aspro conflitto:
cosí quelli, gridando, balzarono l'uno su l'altro.
E qui, Cigno, bramoso d'uccidere il figlio di Zeus
onnipossente, vibrò sul suo scudo la lancia di bronzo;
né il bronzo si spezzò: ché schermo fe' l'opra del Nume.
Eracle, invece, il figlio possente d'Anfitrione,
gagliardamente immerse fra l'elmo e lo scudo la lancia,
nel collo, ov'esso ignudo pareva, al disotto del mento.
Il frassino omicida recise l'un tèndine e l'altro,
ché grande era la forza del colpo. E piombò come quercia
piomba, o scoscesa rupe, colpita dal folgor di Zeus.
Cosí piombò: su lui suonarono l'armi di bronzo.
E allora lo lasciò di Zeus l'impavido figlio,
ed aspettò guardingo l'arrivo di Ares omicida,
fissandolo con occhi terribili, al par d'un leone
che in una preda s'imbatte, la pelle con l'unghie possenti
cupidamente gli fende, ne sazia l'ingorda sua brama,
e, sfavillando tremendo negli occhi, le spalle ed i fianchi
coi pié gli scava, e sferza la coda, e nessuno che veda
farglisi contro ardisce, combatter con lui faccia a faccia.
D'Anfitrione il figlio mai sazio di zuffe, di fronte
stette a Ares cosí, crescendogli in cuore il coraggio,
impetuoso; e quegli, crucciato, si fece a lui presso;
e con orrende grida, piombarono l'uno su l'altro.
Come allorquando una rupe si stacca da un vertice eccelso,
e con immensi balzi giú rotola, e irrompe furente
con gran fragore; ed ecco, si oppone al suo corso un gran poggio:
quivi essa cozza; e il poggio l'arresta: con simile romba
balzò, gridando, Ares, flagello dei carri. Ma quello
súbito contro gli stette. E Atena, figliuola di Zeus,
contro si fece a Ares, schermita dall'égida fosca,
e bieco lo guardò, gli volse cosí la parola:
«Ares, trattieni il cuore furente e l'invitto tuo braccio:
perché fato non è che tu Eracle stermini, il figlio
dal temerario cuore di Zeus, e che l'armi ne indossi.
Via, dalla zuffa desisti, né starmi di contro a battaglia».
Cosí disse; né il cuore superbo di Ares convinse;
ma con grandi urli, l'armi, che fuoco pareano, vibrando,
rapidamente balzò sopra Eracle forte, anelando
di dargli morte. E a furia - tant'ira l'ardeva pel figlio
spento - dal grande scudo vibrò la sua lancia di bronzo.
Ma si protese dal carro la Diva dagli occhi azzurrini,
e volse altrove il colpo dell'asta. Ed acuto cordoglio
invase Ares. E fuori traendo l'aguzza sua spada,
contro Eracle balzò, dal cuore magnanimo. E il figlio
d'Anfitrione, che mai non fu sazio dell'orrida pugna,
sotto lo scudo bello, la coscia, ove ignuda appariva,
gagliardamente trafisse, le carni di squarcio profondo
aprí, colpendo, il Nume rovescio mandò per le terre.
Spinsero súbito presso Sgomento e Terrore il veloce
carro e i cavalli, il Dio sollevaron da terra, sul carro
lo posero, di fregi molteplici ornato, le sferze
vibraron sui cavalli, tornarono ai picchi d'Olimpo.
Ed il figliuolo d'Alcmena, con Iolao coperto di gloria,
poscia che l'armi belle dagli omeri tolser di Cigno,
partirono; e sul carro veloce pervennero presto
alla città di Trachine. E Atena dagli occhi azzurrini
novellamente tornò del padre alla casa, in Olimpo.
E Cice a Cigno diede sepolcro, col popolo immenso
che, intorno alla città dell'illustre sovrano, abitava
Ante, con la città dei Mirmidoni insigne, e Jolco
Elide ed Arne. A onorare Ceice diletto ai Celesti,
popolo molto s'accolse. Ma poscia invisibili rese
tumulo e tomba, gonfio di piogge invernali, l'Anauro.
Febo volle cosí, perché Cigno, chiunque recasse
sacre ecatombi a Pito, tendeva l'insidia a predarle.