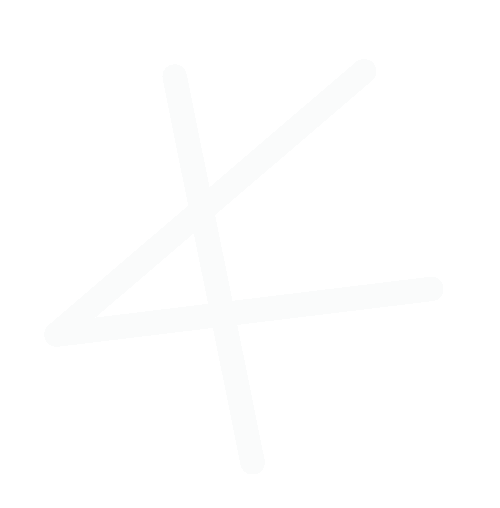Biblioteca:Ovidio, Metamorfosi, Libro IX
Teseo, l'eroe caro a Poseidone, chiese ad Acheloo di Calidone
perché gemesse e avesse un corno rotto. E il dio, con i capelli,
semplicemente incoronati d'erbe, così prese a dire:
"Triste grazia mi chiedi. Chi racconta volentieri
le battaglie perdute? Ma te le narrerò punto per punto,
e del resto, più che un'onta la sconfitta, fu un onore combattere
e di grande conforto mi è l'autorità di chi mi vinse.
Forse per sentito dire è giunto alle tue orecchie il nome
di Deianira: era una fanciulla di bellezza senza pari,
desiderata e contesa da molti pretendenti.
Entrato insieme a loro nella dimora del vagheggiato suocero,
così gli dissi: "Scegli me come genero, o figlio di Partaone".
E così disse Alcide. Di fronte a noi gli altri cedettero il campo.
Per sé lui vantava di offrire Zeus come suocero e la gloria
delle fatiche che, impostegli da Era, aveva superato.
Io ribattei: "Mai sia detto che un dio ceda a un mortale."
(Eracle nume non era ancora.) "In me tu vedi il sovrano
del fiume che, serpeggiando, scorre lungo il tuo regno.
E con me non avrai uno straniero venuto d'oltre confine
come tuo genero, ma uno della tua terra, uno dei tuoi.
Unica cosa, e spero non mi nuoccia: la regina degli dei
non mi odia e nessuno per castigo mi ha imposto fatiche.
In più, figlio di Alcmena, tu che vanti la tua discendenza,
Zeus non è tuo padre o lo è per via di una colpa:
per averlo come tale accusi tua madre d'adulterio. Scegli:
preferisci che non lo sia o l'esser nato con vergogna?".
Mentre parlavo, già da un pezzo lui mi fissava con occhi torvi
e acceso d'ira si dominava a stento, finché di botto
mi rispose: "Ho il braccio migliore della lingua:
vincimi pure a chiacchiere, a me basta superarti nella lotta!".
E mi si avventò contro inferocito. Dopo l'arroganza mia,
non potevo più ritirarmi: strappai dal corpo la veste verde,
mettendomi in guardia, le braccia tese, i pugni stretti
davanti al petto, e mi preparai al combattimento.
Lui, raccolta una manciata di polvere, me la getta negli occhi,
e a sua volta, coperto di sabbia d'oro, diviene tutto biondo.
Ora cerca d'afferrarmi il collo, ora le gambe che via gli sfuggono,
o finge d'afferrarmi, e dove gli è possibile m'attacca.
La mia solidità mi protegge e vani riescono i suoi assalti;
come accade a una roccia, che con gran fragore i flutti
investono: immobile resta lì, difesa dal suo stesso peso.
Ci stacchiamo per un attimo, poi di nuovo ci scontriamo in lotta,
saldi nella nostra posizione, decisi a non cedere, piede
puntato contro piede, ed io, curvato in avanti con tutto il petto,
incalzo, dita contro dita, fronte contro fronte.
Allo stesso modo ho visto scontrarsi tori immani,
quando la posta del combattimento è la più bella femmina
di tutto il pascolo: l'armento intorno guarda spaurito,
chiedendosi a chi andrà la vittoria di così vasto dominio.
Tre volte, senza esito, Eracle tentò di respingere
da sé il mio petto che gli resisteva, ma alla quarta
si svincolò, sciolse l'intrico delle braccia intorno a sé
e, dandomi uno strappo con le mani (ho promesso di dire il vero),
d'un tratto mi girò, avvinghiandomi le spalle con tutto il suo peso.
Dovete credermi (sì, non cerco gloria esagerando le cose),
mi sentivo oppresso come se addosso avessi avuto una montagna.
Con gran fatica riuscii infine a insinuare le braccia, grondanti
di sudore, e a sciogliermi dal corpo quella morsa d'acciaio;
ansimavo, ma lui non cedeva, impedendomi di prender fiato;
e mi agguantò alla nuca, costringendomi a toccare il suolo
con le ginocchia, finché, faccia a terra, non morsi la rena.
Battuto sul piano della forza bruta, ricorsi alle mie arti
e gli sgusciai via mutandomi in un lungo serpente.
L'eroe di Tirinto, vedendomi flettere il corpo in spire
sinuose e vibrare con sibili selvaggi la lingua a due punte,
scoppiò in una risata e, beffandosi dei miei trucchi:
"Vincere i serpenti è un gioco che facevo già nella culla,"
disse; "e se anche tu, Acheloo, superassi qualsiasi drago,
cosa potresti essere, da solo, in confronto al mostro di Lerna?
Dalle sue stesse ferite si riformava e, delle cento teste
che aveva, non ce n'era una che si potesse mozzare
senza che sul collo, più sano di prima, due gliene rispuntassero.
E quel mostro, che mutilato si ramificava in nuove serpi
e dalle piaghe ricresceva, io lo domai e, vinto, lo bruciai.
Cosa credi di fare, tu che mutato in finto serpente
sfoggi armi non tue, tu che ti celi sotto una forma illusoria?".
Così disse, e le sue dita si chiusero in alto intorno al mio collo,
come un cappio: soffocavo, come se mi stringesse una tenaglia,
e a viva forza cercavo di sottrarre la gola a quelle mani.
Sconfitto anche così, non mi restava che la foggia minacciosa
di un toro: mutatomi in quello, riprendo la lotta.
Lui dal fianco sinistro mi circonda con le braccia la giogaia
e seguendo il mio slancio mi trascina, m'inginocchia conficcando
le corna nella dura terra e m'abbatte in mezzo alla polvere.
E non basta: mentre m'afferra inferocito un corno, rigido
com'era, lui me lo spezza e lo strappa, mutilandomi la fronte.
Le Naiadi colmano il mio corno di frutti e fiori profumati,
rendendolo sacro, corno prodigioso dell'Abbondanza".
Qui tacque. Una ninfa, che fungeva da ancella, nella veste
succinta di Artemide, con i capelli sciolti sulle spalle,
fece il suo ingresso, recando al termine del pranzo il corno
traboccante di tutti i frutti deliziosi dell'autunno.
E spunta l'aurora: appena il primo sole lambisce i monti,
i giovani si congedano. Non attendono che il fiume
ritrovi pace, il suo placido fluire, e che le acque
calino del tutto. L'Acheloo immerge nei flutti
il suo rustico volto e il capo dal corno divelto.
Anche se avvilito per il guasto che gli ha sciupato il volto, lui,
però, è incolume; e lo sfregio sul capo si può sempre celare
con fronde di salice o corone di canne.
Ma a te, feroce Nesso, la passione per quella fanciulla
è costata la vita, trafitto alla schiena da una freccia in volo.
Il figlio di Zeus stava tornando alle mura della sua patria
con la giovane sposa, quando giunse alle rapide dell'Eveno.
Il fiume, cresciuto per le bufere invernali, era più del solito
gonfio, pieno di vortici e quasi impossibile da attraversare.
Ad Eracle, che per sé non temeva, ma era in ansia per la moglie,
si accosta Nesso, muscoloso e pratico di guadi:
"Provvedo io, Alcide, a deporre costei sull'altra sponda,"
gli dice. "Tu, con la tua forza, puoi passare a nuoto".
E l'eroe dell'Aonia gli affida la fanciulla sgomenta,
che, pallida in volto, guarda con lo stesso timore il fiume e Nesso.
Poi, così com'era, con addosso faretra e pelle di leone
(clava ed arco allentato li aveva scagliati sulla riva opposta),
dice: "Giunto sin qui, si superi anche questo fiume".
E senza esitazione alcuna, senza cercare il punto più calmo,
rifiutando d'abbandonarsi al flusso della corrente, si tuffa.
Già sull'altra sponda, mentre raccoglie l'arco che aveva scagliato,
sente la moglie che l'invoca e vede Nesso che s'appresta
a sottrargli chi gli aveva affidato: "Dove t'illudi", gli grida,
"di poter fuggire, insolente? Dico a te, mostro biforme!
Ascoltami, non osare strapparmi ciò che m'appartiene!
Se non ti frena il minimo riguardo nei miei confronti, da un coito
illecito dovrebbe almeno distoglierti il supplizio paterno.
Anche se confidi nelle risorse equine, non mi sfuggirai:
non con i piedi, ma con un colpo ti raggiungerò!". Detto questo,
lo prova: scaglia una freccia che trafigge la schiena
al fuggiasco. Con la punta gli esce il ferro dal petto
e quando se lo strappa, da entrambi gli squarci, col pus velenoso
del mostro di Lerna, sgorga a fiotti il suo sangue.
Nesso ne afferra il valore, mormorando fra sé: "Non morirò
senza vendicarmi!", e a colei che voleva rapire, come sprone
all'amore, dona la propria veste intrisa di sangue bollente.
Passò molto tempo, durante il quale il grande Eracle
riempì il mondo delle sue gesta, saziando l'odio della matrigna.
Tornato vittorioso da Ecalia, lui stava per rendere grazie
a Zeus Ceneo: la Fama, che gode con le sue calunnie
a confondere vero e falso, e che dal nulla si dilata
per forza di menzogna, lo precorse, recando alle tue orecchie,
Deianira, una voce: Eracle si è invaghito di Iole.
L'innamorata ci crede e, atterrita da questa rivelazione,
all'inizio si abbandona al pianto e sfoga avvilita il suo dolore
in un mare di lacrime; ma poi: "Perché mai piango?" si domanda.
"Queste lacrime faranno soltanto piacere alla mia rivale.
E poiché si farà viva, devo sbrigarmi a inventare qualcosa,
finché sono in tempo e l'intrusa ancora non dispone del mio letto.
Dolermi o tacere? Tornare a Calidone o restarmene qui?
Andarmene di casa o, se non c'è di meglio, accettare la sfida?
E se invece, ricordando d'essere tua sorella, Meleagro,
preparassi una vendetta esemplare e, sgozzando la mia rivale,
dimostrassi cosa può il rancore di una donna oltraggiata?".
Fra un pensiero e l'altro vacilla la sua mente, ma fra tutti
sceglie di mandare ad Eracle la veste intrisa del sangue
di Nesso, perché ridia forza all'amore che langue,
e all'oscuro della propria rovina, l'affida a Lica, che ignora
cosa reca, incaricandolo con le sue blandizie, sventurata,
di consegnare quel dono al marito. Eracle prende la veste
e senza saperlo indossa il veleno dell'idra di Lerna.
Mentre pregando spargeva incenso sul fuoco appena acceso
e dal calice versava vino sugli altari di marmo,
il veleno, sciolto al calore delle fiamme, prese forza
e colandogli sul corpo si disperse per tutte le sue membra.
Finché poté, col suo solito coraggio represse i gemiti;
ma quando intollerabili divennero le sofferenze,
rovesciò gli altari e con le sue urla riempì le selve dell'Eta.
Senza indugio tenta di strapparsi di dosso la veste mortale:
dove la tira, tira anche la pelle e, orribile a dirsi, la veste
resta incollata al corpo malgrado gli sforzi per staccarla,
o gli lacera le carni mettendo a nudo le sue ossa enormi.
E il sangue stride, come lama incandescente immersa
in acqua gelida, e si secca al fuoco del veleno.
Non c'è rimedio: avide le fiamme divorano il petto,
un sudore livido scorre su tutto il suo corpo,
combusti stridono i tendini, e lui, con le midolla sfatte
da quella peste occulta, levando le mani al cielo:
"Nùtriti della mia sventura, figlia di Crono!" grida;
"nùtriti e, contemplando dall'alto, malvagia, questo strazio,
sazia il tuo cuore feroce! Ma se anche a un nemico strappo pietà
(e dico a te!), troncami questa vita in preda ai tormenti più atroci,
una vita odiosa, nata solo per i travagli.
Un dono mi sarà la morte, un dono che s'addice a una matrigna!
Non fui io a domare Busìride che lordava i templi
col sangue degli stranieri? a privare il malvagio Anteo delle forze
che gli infondeva sua madre? a fronteggiare i tre corpi
del pastore d'Iberia o i tuoi tre corpi, Cerbero?
Non ho con voi, mani mie, piegato le corna di quel toro immane?
con voi compiuto le imprese dell'Elide, della gora di Stinfalo,
dei boschi del Partenio? in virtù vostra non fu conquistata
la cintura scolpita nell'oro del Termodonte,
non furono conquistati i pomi custoditi dal drago insonne?
Non è a me che non poterono resistere i Centauri
o il cinghiale che devastava l'Arcadia? Non è per me che all'idra
non servì ricrescere dalle ferite, raddoppiando le forze?
E che dire di quando vidi i cavalli del re di Tracia
gonfi di sangue umano e le greppie colme di corpi fatti a pezzi?
a quella vista le distrussi e uccisi padrone e cavalli.
Da queste braccia giace soffocata la belva immane di Nemea,
su queste spalle ho sostenuto il cielo. Stancata si è d'intimare
l'implacabile Era: mai io mi son stancato d'eseguire.
Ma una peste inaudita ora m'assale, a cui non si resiste
con valore o armi: nel profondo del mio petto serpeggia un fuoco
che tutto divora e di tutte le membra si nutre.
Eppure Euristeo è vivo e vegeto! E c'è chi crede all'esistenza
degli dei!". Così dice, e piagato si trascina sui gioghi
dell'Eta, come un toro che porti confitta in corpo
una picca, mentre chi l'ha colpito è corso a rifugiarsi.
Gemere l'avresti visto, gridare il proprio sdegno,
tentare di strapparsi ancora una volta la veste,
sradicare tronchi, sfogare la sua rabbia
contro le rocce o tendere le braccia verso il cielo di suo padre.
Ed ecco che scorge Lica nascondersi sconvolto nell'anfratto
d'una rupe; con tutta la collera accumulata dal dolore:
"Lica," gli grida, "a te dunque devo questo dono mortale?
A te dovrò imputare la mia morte?". Quello, pallido, atterrito,
trema, balbettando attenuanti in sua difesa.
Mentre balbetta e cerca di abbracciargli le ginocchia,
Eracle l'afferra, lo fa roteare tre, quattro volte
e, con più violenza di una fionda, lo scaglia nel mare d'Eubea.
Sospeso nello spazio Lica si congela: come ai venti gelidi
vedi rapprendersi la pioggia, trasformarsi in neve,
e poi in un turbinio condensare i suoi morbidi fiocchi,
che ispessendosi si addensano in grandine, così,
scagliato nel vuoto dalle braccia possenti di Eracle,
esangue per il terrore, senza più una goccia di umore,
Lica, come racconta la leggenda, si trasforma in dura roccia.
Ancor oggi sopra i gorghi profondi del mare d'Eubea affiora
un piccolo scoglio che serba il profilo di forma umana:
i marinai, quasi fosse sensibile, esitano a porvi piede
e lo chiamano Lica. Intanto tu, illustre virgulto di Zeus,
tagliati gli alberi, dei quali s'ammantava in vetta l'Eta,
per costruire il rogo, disponi che il figlio di Peante
si prenda l'arco, la capace faretra e le frecce, destinate
a rivedere ancora una volta il regno di Troia, e gli ordini
d'appiccare il fuoco. E mentre le fiamme inghiottono la pira,
sulla sua cima tu stendi la pelle del leone di Nemea
e, appoggiato il capo sulla clava, ti sdrai supino,
con lo stesso volto che avresti se ti adagiassi a banchetto
tra coppe colme di vino e inghirlandato di fiori.
E già impetuosa, divampando tutt'intorno e lambendo il suo corpo,
crepitava la fiamma tra la quieta indifferenza dell'eroe:
sgomento provarono gli dei per il difensore della terra.
E allora, rendendosene conto, Zeus Saturnio, lieto in volto,
così a loro si rivolse: "Questo vostro timore mi rallegra,
celesti, e dal profondo del cuore mi congratulo con me stesso
d'esser chiamato signore e padre di una stirpe riconoscente
e perché la mia progenie può contare sul vostro affetto.
E anche se lui se l'è guadagnato con le sue gesta immani,
ve ne sono grato ugualmente. Ma il vostro cuore fedele
non si sgomenti inutilmente, non temete queste fiamme!
Colui che tutto vinse, vincerà anche il fuoco che vedete,
e non subirà il potere di Efesto, se non per ciò che è nato
da sua madre; ciò che da me gli viene è eterno, invulnerabile,
non conosce la morte e non c'è fiamma che possa distruggerlo.
Questa essenza, al termine della vita, io l'accoglierò in cielo
e confido che questa mia decisione a tutti gli dei
tornerà gradita. Se tuttavia qualcuno dovesse dolersi
che Eracle divenga un nume, per quanto il premio gli dispiaccia,
dovrà riconoscere che è meritato e suo malgrado approvarlo".
Gli dei assentirono; e anche la regale consorte di Zeus
parve non contrariata a quel discorso, salvo alle ultime parole,
che accolse, sentendosi colpita, con volto duro.
Intanto, tutto ciò che era devastabile dalle fiamme,
Efesto l'aveva distrutto: impossibile riconoscerlo;
di ciò che aveva preso dalla madre il suo aspetto
non conservava più nulla; solo l'impronta di Zeus serbava.
Come il serpente, abbandonata con la pelle la vecchiaia,
prende nuovo vigore nello sfavillio delle sue fresche squame,
così l'eroe di Tirinto, lasciate le spoglie mortali,
rinasce con la parte migliore di sé, sembra farsi più grande,
assumendo un'aria sacra e solenne, degna di venerazione.
Il padre, che tutto può, lo nasconde nelle spire di una nube
e con un cocchio a quattro cavalli lo porta fra gli astri radiosi.
Ne avvertì il peso Atlante. Ma il figlio di Stenelo, Euristeo,
ancora in preda all'ira, l'odio che portava ad Eracle, implacabile
lo rivolse contro i suoi figli. E Alcmena d'Argo, tormentata
da tutti quegli assilli, non aveva che Iole per lamentarsi
come fan le vecchie, per raccontare (testimone il mondo)
le imprese del figlio e le proprie croci. Per volontà di Eracle
Illo aveva accolto nel proprio cuore Iole come sposa
e l'aveva fecondata col suo nobile seme.
Alcmena così le parla: "Che almeno a te gli dei siano propizi
e ti abbrevino le doglie, quando al parto invocherai Ilitìa,
la dea delle trepide partorienti, che con me
fu così disumana per far piacere a Era.
Nell'imminenza del parto, quando il sole incombeva
sul decimo segno, un gran peso tendeva il mio ventre
e il fardello che dentro vi portavo era tale, da non potersi
dubitare che il padre di Eracle, destinato a tante fatiche,
fosse Zeus. Ormai più non resistevo alle doglie del parto
e, anche ora che te ne parlo, un brivido di gelo
percorre il mio corpo, e averne memoria è un po' come soffrire.
Straziata per sette notti e altrettanti giorni,
sfinita dal male, tendendo al cielo le braccia, non feci
che invocare a gran voce Lucina e le dee che agevolano i parti.
Lucina venne, sì, ma, istigata in precedenza contro di me,
con la mira d'immolare la mia vita alla crudele Era.
E come udì i miei gemiti, si sistemò su quell'altare,
lì davanti alla porta e, accavallando le gambe, la destra
sulla sinistra, intrecciando le dita a mo' di pettine,
differì il mio parto; poi, pronunciando a mezza voce
formule magiche, con quelle ne bloccò del tutto il corso.
Io mi sforzo e fuor di senno accuso senza ragione Zeus
d'essere un ingrato, supplico di morire e mi lamento
con accenti da far piangere i sassi. Le donne di Cadmo
m'assistono, fanno voti e mi rincuorano nella sofferenza.
Mi assisteva anche un'ancella, una ragazza del popolo, Galanti,
bionda di capelli, infaticabile ad eseguire gli ordini,
e che per il suo zelo mi era cara. Lei intuì che per colpa
di Era qualcosa stava accadendo, e nel suo andirivieni,
dentro e fuori della porta, vide la dea appostata sull'ara,
che con le dita intrecciate teneva le braccia intorno ai ginocchi,
e le disse: "Chiunque tu sia, rallegrati con la mia padrona;
Alcmena d'Argo ha partorito: esaudito ha la puerpera i suoi voti".
Balzò in piedi la dea dei parti sbigottita
e disgiunse le mani: sciolto il nodo, io partorisco.
Pare che Galanti scoppiasse a ridere per questa beffa,
ma la dea incattivita al suo riso l'afferrò per i capelli
gettandola a terra, e mentre lei cercava di alzarsi,
le inarcò il corpo e le mutò le braccia in zampe.
La sveltezza originaria le rimase qual era e il dorso
non perse il suo colore: è l'aspetto che non è più lo stesso.
Per aver con bocca mendace recato aiuto a una partoriente,
si sgrava dalla bocca e, come prima, frequenta le nostre case".
Tacque e, commossa al ricordo di quell'ancella,
sospirò. A lei, vedendola in pena, così si rivolse la nuora:
"A turbarti è la metamorfosi, madre mia, di una donna
estranea alla nostra famiglia. Ma se ti narrassi l'incredibile
storia di mia sorella, che diresti? Anche se lacrime e dolore
m'intrigano impedendomi di parlare. Driope era figlia unica
(nostro padre mi ebbe da un'altra donna) ed era per bellezza
la donna più famosa d'Ecalia. Perduta la verginità
per la violenza subita dal dio che regna su Delfi e su Delo,
fu presa in moglie da Andremone, che, dicono, ne fosse felice.
C'è un lago la cui sponda in pendio forma una specie di spiaggia
in leggera salita; un mirteto, in cima, gli fa corona.
Qui era venuta Driope, ignara della sua sorte, per offrire,
cosa più commovente ancora, ghirlande alle ninfe.
In braccio, dolce fardello, portava un bimbo, che nemmeno
aveva compiuto un anno, e lo nutriva col suo tiepido latte.
Non lontano dallo stagno fioriva, promettendo bacche,
con gli stessi colori della porpora di Tiro, un loto d'acqua.
Driope ne aveva colto i fiori, per donarli al figlio
come trastullo; ed io pensavo di fare lo stesso
(c'ero infatti anch'io): vidi gocce di sangue cadere
dai fiori e i rami palpitare percorsi da un brivido.
Così, ti dico: come apprendemmo troppo tardi dai contadini,
in quella pianta si era nascosta, per sfuggire alle voglie oscene
di Priapo, la ninfa Loti, mutando aspetto ma non il nome.
Mia sorella l'ignorava e, mentre atterrita voleva tornarsene
indietro e allontanarsi dalle ninfe che adorava,
i piedi misero radici. Cerca, sì, di svellerli,
ma ne muove solo la parte in alto. Dal suolo, poi, cresce
una corteccia tenera, che a poco a poco avvolge tutto il ventre.
Come se ne accorge, tenta di strapparsi con le mani i capelli,
ma se le ritrova piene di foglie: tutto il capo ne era invaso.
E Anfisso, il bambino (questo era il nome che gli aveva dato
il nonno Eurito), sente il seno della madre indurirsi
e il flusso del latte esaurirsi, malgrado si sforzi di succhiare.
Io assistevo alla tua fine atroce, senza nulla poter fare
per recarti aiuto, sorella mia; cercavo con tutte le forze
di ritardare, abbracciandoti, la crescita del tronco e dei rami:
lo confesso, avrei voluto sparire sotto la stessa corteccia.
Ed ecco qui giungere il marito Andremone e il padre in lacrime:
cercano Driope, Driope cercano ed io a loro non posso
che mostrare quel loto. Prostrati baciano il legno ancora tiepido,
si aggrappano alle radici di quella pianta che è parte di loro.
E tu, sorella cara, nulla avevi che non fosse albero,
se non il viso: lacrime rigano le foglie spuntate
da quel corpo sventurato; e finché è possibile, finché la bocca
permette un varco alla voce, Driope sparge nell'aria i suoi lamenti:
"Se anche gli sventurati son degni di fede, giuro sugli dei
di non aver meritato questa infamia: senza colpa ne soffro.
Nell'innocenza sono vissuta; se mento, ch'io mi secchi e perda
tutte le foglie che ho e, tagliata con la scure, mi si bruci.
Ma almeno strappate questo bambino ai rami di sua madre,
affidatelo a una nutrice e fate in modo che sotto il mio albero
beva il suo latte tutti i giorni e sotto il mio albero giochi.
E quando saprà parlare, fate che venga a salutarmi,
mormorando accorato: 'In questo tronco si cela mia madre'.
Ma si guardi dagli stagni e non colga fiori dalle piante:
ricordi che in ogni arbusto può nascondersi il corpo di una dea.
Addio marito mio, addio sorella, padre addio.
Se avete un po' d'affetto, difendete le mie fronde
dai colpi taglienti della falce, dai morsi delle mandrie.
E poiché sino a voi non mi è consentito chinarmi,
tendetevi sino a me per ricevere i miei baci,
finché è possibile baciarci, e sollevate il mio bambino.
Non posso più parlare: una membrana sottile serpeggia
lungo il mio candido collo, serrandomi fin sopra il capo.
Toglietemi dagli occhi le mani: lasciate che sia la corteccia,
non la vostra pietà, a velarmi in punto di morte la luce".
Le labbra smisero di parlare e di esistere: per lungo tempo,
dopo la metamorfosi, i germogli ne serbarono il tepore".
Mentre Iole narrava il prodigioso evento e mentre Alcmena,
accostando le dita, asciugava le lacrime alla figlia di Eurito
(ma anche lei piangeva), un avvenimento inatteso fugò
la loro tristezza. Nell'ampio vano della porta apparve,
quasi fanciullo, con le guance coperte da un'ombra di peluria,
Iolao, restituito alle fattezze dei suoi anni giovanili.
Questo dono glielo aveva concesso Ebe, figlia di Era,
vinta dalle preghiere del marito. E stava per giurare
che a nessun altro avrebbe accordato favore uguale,
quando Temi, protestando, le disse: "A Tebe si prepara
una guerra intestina, e Capaneo non potrà esser vinto
che da Zeus; pari saranno due fratelli nel darsi la morte;
un indovino, inghiottito dal suolo, vedrà ancora vivo
le ombre dei morti; un figlio con atto insieme virtuoso e criminale,
punirà la madre per vendicare il padre
e, oppresso dal rimorso, fuori di senno, esiliato dalla patria,
sarà braccato dal volto delle Erinni e dall'ombra della madre,
finché la moglie non gli chiederà la collana fatale
e la spada di Fegeo non s'immergerà nel corpo del congiunto.
E allora Calliroe, figlia di Acheloo, pregherà l'eccelso Zeus
di concedere ai propri figli ancora imberbi un'età più matura,
perché la morte del vendicatore non restasse invendicata.
Commosso, Zeus accorderà per primo i doni tuoi, Ebe, figliola
e nuora sua, rendendoli adulti nell'età dell'infanzia".
Quando Temi, che conosce il futuro, giunse al termine
del suo presagio, gli dei in subbuglio si misero a disputare,
chiedendosi irritati perché mai non fosse lecito concedere
ad altri lo stesso dono. La figlia di Pallante si lamenta
che troppo vecchio è suo marito, la mite Cerere che Iasione
incanutisce; Efesto pretende che Erictonio
torni a vivere da capo; e anche Afrodite, angustiata dal futuro,
si mette a patteggiare perché ad Anchise si calassero gli anni.
Ogni nume ha qualcuno da proteggere, così il tumulto cresce
in disputa di favori, finché Zeus non apre bocca e dice:
"Abbiate un po' di rispetto per me! Siete impazziti?
Qualcuno di voi crede forse di essere così potente
da poter vincere il destino? Per volere del fato è tornato
Iolao a rivivere i suoi anni; per volere del fato i figli
di Calliroe diventeranno adulti, non con intrighi o conflitti.
Anche voi dipendete dal destino, e anch'io, se ciò
può consolarvi. Se avessi il potere di mutarlo,
il mio Eaco non sarebbe ingobbito dal progredire degli anni
e Radamanto avrebbe il dono dell'eterna giovinezza,
come il mio Minosse, che per l'amaro peso della sua vecchiaia
ora è disprezzato e non governa più come un tempo".
Le parole di Zeus convinsero gli dei e nessuno
osò lamentarsi, vedendo Radamanto, Eaco e Minosse
stremati dagli anni. E Minosse, finché era stato in pieno vigore,
aveva fatto tremare interi popoli col solo suo nome;
ora, infiacchito, tremava davanti al figlio di Deione,
Mileto, che vantava prestanza giovanile e sangue di Febo;
e pur essendo convinto che costui tramasse un colpo di stato
contro la sua corona, non osava intimargli l'esilio.
Ma fosti tu, Mileto, a decidere la fuga, solcando
il mare dell'Egeo a forza di remi, e a fondare in terra d'Asia
una città che da te, costruttore delle mura, prende il nome.
E qui incontrasti, mentre seguiva le anse della riva paterna,
la figlia del Meandro, che continuamente torna su sé stesso:
Cianea, una fanciulla dalle forme stupende,
che ti partorì due gemelli, Biblide e Cauno.
Monito è Biblide a voi, fanciulle: amate solo chi è lecito amare.
Biblide, travolta da passione per l'apollineo fratello,
l'amò non come una sorella, ma come non avrebbe dovuto.
In verità, all'inizio lei non comprende il senso di quella fiamma,
non pensa di peccare quando troppo spesso bacia suo fratello,
quando gli getta le braccia intorno al collo, e per lungo tempo
inganna sé stessa col velo artificioso di un semplice affetto.
Ma a poco a poco l'amore si fa strada: per vedere il fratello
si agghinda tutta, troppo brama d'apparirgli bella,
e se al suo fianco ve n'è un'altra più bella, la guarda di mal occhio.
Non ne è consapevole ancora e, oppressa da quel fuoco,
ancora non formula voti, anche se dentro arde tutta.
Comincia, sì, a chiamarlo signore, a odiare i nomi che ne svelano
il sangue, a preferire che lui la chiami Biblide anziché sorella;
però, quando è sveglia, non lascia che il cuore si abbassi
a speranze lascive; quando invece cade in braccio al sonno,
sogna l'oggetto del suo amore, immagina d'unire il suo corpo
a quello del fratello e si fa rossa, benché giaccia addormentata.
Svanito il sonno, a lungo tace, rivive il suo sogno
e col cuore tormentato dai dubbi, mormora fra sé:
"Ahimè, che vuol dire questa visione nel silenzio della notte,
e che vorrei non si avverasse? Perché mai ho fatto questo sogno?
Certo lui, anche ad occhi malevoli, sì, i più malevoli, è bello
e mi piace; se non fosse mio fratello, potrei amarlo,
e di me sarebbe degno; ma il guaio è che sono sua sorella.
Purché io non tenti di commettere simili cose da sveglia,
torni, torni pure la stessa immagine a visitarmi nei sogni!
Non ha testimoni il sonno e il piacere non è lontano dal vero.
O Afrodite, o Eros, che voli intorno alla tua tenera madre,
che godimento ho provato, che voluttà autentica m'ha pervaso,
abbandonata al languore, sfibrata sino all'anima.
Che ricordo delizioso, anche se il piacere è stato breve
e fugace la notte per invidia dei nostri disegni.
Oh, se fosse possibile unirsi cambiando nome,
che nuora ideale potrei essere, Cauno, per tuo padre!
e che genero ideale potresti essere tu per il mio!
Volessero gli dei che tutto avessimo in comune,
tranne i nostri vecchi! Io vorrei che tu fossi più nobile di me.
Così invece, splendore mio, renderai madre non so chi,
e per me che, maledetta, ho avuto in sorte i tuoi stessi genitori,
tu non sarai che un fratello: in comune abbiamo soltanto divieti.
Che senso hanno allora le mie visioni? Che peso per me
possiedono i sogni? Ma possiedono un peso i sogni?
Fortunati gli dei! loro possono unirsi alle sorelle.
Crono sposò Opi, del suo stesso sangue;
Oceano Teti e il re dell'Olimpo Era.
Ma gli dei hanno leggi proprie: perché pretendo di uniformare
i costumi umani alle norme del cielo, che son diverse?
O questa passione illecita sarà sradicata dal mio cuore,
o, se non vi riesco, ch'io possa qui morire e, morta,
composta sul letto, lì distesa, venga a baciarmi mio fratello!
Ma è un'unione, questa, che richiede il consenso d'entrambi.
Metti che a me sia gradita: a lui potrà sembrare un'infamia.
Eppure i figli di Eolo non sdegnarono il letto delle sorelle.
Ma dove l'ho appreso? Perché sono ricorsa a questo esempio?
Dove son spinta? Via, lontano da me, fuoco immondo:
solo nel modo concesso a una sorella sia amato il fratello!
Ma se fosse stato lui a innamorarsi di me per primo,
chissà, forse avrei potuto abbandonarmi alla sua passione.
E poiché non l'avrei respinto, se fosse stato lui a cercarmi,
sarò io a cercarlo? Potrai parlargli? potrai aprirti a lui?
Per amore, sì che potrò! o, se il pudore mi chiuderà la bocca,
sarà in segreto una lettera a rivelare il fuoco che nascondo!".
Questa idea le piace e prevale sui dubbi della sua mente.
Si solleva sul fianco e, appoggiata sul gomito sinistro:
"Giudichi lui," si dice; "confessiamo questo folle amore.
Ahimè, dove rovino? Quali deliri genera la mia mente?".
E, studiando le parole, con mano tremante si mette a scrivere;
la destra stringe lo stilo, l'altra regge la tavoletta vergine.
Comincia ed esita; scrive e si pente di quello che ha scritto;
segna e cancella; corregge, rifiuta e approva;
prende la tavoletta e la depone; la depone e la riprende.
Non sa ciò che vuole, e ciò che ha in mente di fare non le piace;
sul suo volto è dipinta un'audacia mista a vergogna.
Aveva scritto 'sorella'; decide di cancellare 'sorella'
e di incidere sulla cera spianata queste parole:
"Quel bene che, se non sarai tu a darglielo, lei non avrà mai,
a te l'augura chi t'ama. Arrossisco, arrossisco a dire il mio nome!
Se mi chiedi ciò che bramo, avrei voluto trattare la mia causa
senza rivelare il nome ed esser conosciuta come Biblide,
finché certa non fosse l'attuazione dei miei voti.
Ma che il mio cuore fosse ferito potevano indicarteli
il pallore, lo sfinimento, l'espressione e gli occhi, così spesso
velati di pianto, i sospiri emessi senza ragione apparente,
i continui abbracci e i baci che (forse l'hai notato)
non era possibile confondere con quelli d'una sorella.
Io però, pur avendo in cuore una ferita insopportabile,
pur avendo dentro una passione di fuoco, tutto ho fatto
(gli dei mi son testimoni) per giungere a guarire;
a lungo, disperata, ho lottato per sottrarmi alle armi tremende
di Eros; e ho sofferto pene maggiori di quelle che, a tua mente,
potrebbe sopportare una fanciulla. Ma vinta devo purtroppo
confessarmi e chiedere il tuo aiuto, osando appena confidarvi:
tu sei l'unico che possa salvare o perdere colei che t'ama.
Scegli tu cosa vuoi fare. Non è certo una nemica a pregarti,
ma una donna che, pur legatissima a te, spasima d'esserlo
ancor di più e d'unirsi a te con vincolo ancora più stretto.
Lasciamo agli anziani il verdetto su ciò che è permesso,
su ciò che è lecito o no, indagando e pesando a fondo la legge:
in amore alla nostra età convien essere temerari.
Del resto cosa è lecito? non lo sappiamo: crediamo che tutto
sia permesso, seguendo l'esempio che ci danno gli dei dal cielo.
Non ci fermeranno severità paterna, scrupoli
di buon nome o paura. Ma poi paura di che?
Ai dolci convegni farà da schermo il nome che ci lega:
io sono pur libera di appartarmi con te per parlarti,
stringendoti fra le braccia e baciandoti di fronte a tutti.
E poi che manca? Abbi pietà di chi confessa il suo amore:
non lo confesserebbe se non l'obbligasse una passione estrema.
Non far sì che per la mia morte ti si accusi d'esserne la causa".
Mentre vergava questo vaniloquio, vennero a mancare
le tavolette ormai colme e l'ultima riga fu tracciata in margine.
Subito firma la sua condanna imprimendovi il sigillo
inumidito con le lacrime (la lingua le si era seccata);
e tutta vergognosa chiama uno dei suoi servi; rincuorando
quel tremebondo, gli dice: "Per la fede che mi porti, consegna
questa lettera a mio..." e solo dopo una vita aggiunge: "fratello".
Ma nel dargliele, le tavolette le sfuggono, cadendo a terra.
Pur turbata dal presagio, le manda ugualmente; e l'araldo, colta
l'occasione, avvicina Cauno, porgendogli il messaggio segreto.
Sconvolto, il giovane nipote di Meandro s'infiamma di collera,
getta le tavolette appena ricevute, senza quasi leggerle,
e trattenendosi a stento dallo schiaffeggiare il servo atterrito:
"Finché puoi, sciagurato mezzano d'una lussuria spudorata,
sparisci!" gli grida. "Se la tua fine non trascinasse nel fango
il mio buon nome, me la pagheresti con la vita".
Quello fugge sgomento e riferisce alla padrona la rabbiosa
risposta. Sentendo che Cauno ti respinge, tu, Biblide, allibisci
e il tuo corpo s'impietrisce, invaso da un brivido glaciale.
Ma quando torna la ragione, tornano anche le smanie
e con voce che appena risuona nell'aria, mormora:
"È giusto! perché son stata tanto temeraria da rivelargli
le mie piaghe? perché con tanta fretta ho affidato a una lettera
avventata parole che dovevano restar segrete?
Prima dovevo sondare il suo animo, parlandogli
con frasi ambigue. Per evitare che non mi secondasse,
dovevo controllare che vento spirava, almeno
con qualche vela, e mettermi a navigare solo con mare buono,
mentre ho spiegato tutte le vele al vento, senza averlo saggiato.
Così son sbattuta contro gli scogli e il mare intero mi travolge
rovinandomi addosso, senza aver modo d'invertire la rotta.
Del resto un presagio inequivocabile non mi vietava
d'indulgere al mio amore, quando le tavolette, all'ordine
di portarle, mi caddero, annunciando il crollo delle mie speranze?
Non avrei dovuto mutare giorno o addirittura tutto il piano?
No, no, meglio il giorno: proprio una divinità m'ammoniva,
mi dava segni certi, se cieca non fosse stata la mia mente.
E comunque non dovevo affidarmi a una lettera, ma parlargli
io stessa e di persona rivelargli i miei deliri.
Avrebbe visto le mie lacrime, il volto di chi l'adora;
avrei potuto dirgli più cose di quelle entrate nella lettera.
Potevo gettargli le braccia al collo, anche se non voleva,
e, se m'avesse respinto, far finta d'essere in punto di morte,
abbracciargli le ginocchia e, stesa ai suoi piedi, implorargli la vita.
Tutti i mezzi avrei usato e, se ognuno in sé non avesse potuto
vincere il suo puntiglio, tutti insieme vi sarebbero riusciti.
E forse un po' di colpa ce l'ha pure il servitore che ho mandato:
non deve averlo avvicinato bene, aver scelto il momento
adatto, suppongo, o atteso un'ora in cui avesse la mente sgombra.
Ecco cosa mi ha nuociuto: lui non è nato da una tigre,
il suo cuore non ha l'asprezza d'una pietra, la tempra del ferro
o dell'acciaio, lui non ha succhiato il latte d'una leonessa.
Lo vincerò; tornerò all'attacco e mai avrò posa
di provare e riprovare, finché mi rimarrà un soffio di vita.
Per primo, se mai potessi annullare ciò che ho fatto, non avrei
dovuto cominciare; ma a questo punto devo portarlo a termine.
Del resto neppure lui, anche se rinunciassi alle mie speranze,
potrà mai dimenticare ciò che ho avuto l'impudenza di fare;
e se desisterò, sembrerà che abbia agito da sventata
o che abbia voluto metterlo alla prova tendendogli un'insidia;
comunque penserà ch'io non sia stata vinta dalla tirannia
del nume, che strazia e brucia il mio cuore, ma dalla lussuria.
Infine non posso negare d'aver commesso un'infamia:
gli ho scritto e l'ho supplicato, mostrando intenzioni perverse;
anche se ora mi fermassi, non potrei più dirmi innocente.
Lunga la strada che si frappone ai miei voti, ma breve alla colpa".
Così dice, e tanta confusione e incertezza v'è nella sua mente,
che, pur pentita d'aver tentato, vuol tentare di nuovo, e perde
il senso della misura, esponendosi, ahimè, a continui rifiuti.
Infine Cauno, poiché lei non gli dà tregua, fugge dalla patria
e da quell'abominio e fonda una nuova città in terra straniera.
Allora, sì, la figlia di Mileto perde per l'angoscia
del tutto la ragione, allora, sì, come una furia
si strappa dal petto la veste e si percuote, si dice, le braccia.
Ormai è pazza, non c'è dubbio; parla a tutti della sua speranza
d'amore ed essendole vietata, lascia la patria e i suoi penati
fattisi odiosi, e parte alla ricerca del fratello fuggitivo.
La vedono correre urlando per la distesa dei campi
le donne di Bubaso, come quando, ossessionate dal tuo tirso,
figlio di Semele, le baccanti di Tracia celebrano
ogni tre anni i tuoi riti. Lasciata Bubaso,
vaga tra i Cari, tra i Lelegi e per la Licia.
Già s'è lasciata il Crago e il Limire alle spalle, i flutti dello Xanto
e l'altura sulla quale abitò Chimera, che dal ventre spira
fiamme e ha petto e muso di leonessa, coda di serpente.
Si diradano i boschi, quando tu, sfinita a forza d'inseguirlo,
cadi e rimani distesa con i capelli sparsi, Biblide,
sulla dura terra e col viso che preme le foglie morte.
Più volte, è vero, con dolcezza le ninfe della terra dei Lelegi
tentano di sollevarla; più volte, per guarirla dall'amore,
l'incoraggiano, ma a una mente spenta non serve il loro conforto.
Muta giace Biblide, tra le unghie stringe l'erba verde
e inonda tutto il prato d'un mare di lacrime.
Da quelle, si racconta, le Naiadi fecero sgorgare
una polla, che mai si potesse seccare: c'è dono migliore?
Subito, come la resina gocciola dalla corteccia incisa,
o come vischioso trasuda il bitume dal grembo della terra,
o come ai primi lievi soffi del Favonio, l'acqua,
cristallizzata dal gelo, si scioglie al sole,
così struggendosi in lacrime, Biblide, nipote di Febo,
si trasforma in fonte, che ancor oggi in quelle vallate
porta il nome della sua signora e sgorga ai piedi di un leccio scuro.
La notizia di quel prodigio avrebbe forse sconcertato
tutte e cento le città di Creta, se proprio a Creta poco prima
non ne fosse accaduto un altro: la metamorfosi d'Ifi.
Nella regione di Festo, che è vicina al regno di Cnosso,
viveva un certo Ligdo, un plebeo d'oscura famiglia,
ma libero. Non era più ricco di quanto fosse nobile,
ma era sempre vissuto onestamente e senza macchia.
Alla moglie, incinta e ormai vicina al giorno del parto,
costui rivolse questo ammonimento: "M'auguro
due cose sole: che tu partorisca soffrendo il meno possibile
e metta al mondo un maschio. In caso contrario sarebbe un guaio,
perché purtroppo abbiamo pochi mezzi. Perciò, se per malasorte
(e spero non avvenga) tu partorissi una femmina, benché
mi ripugni, ingiungo (il cielo mi perdoni) che venga uccisa".
Questo disse, e fiumi di lacrime rigarono il volto di chi
proferiva l'ordine, come di lei che lo riceveva.
Invano Teletusa pregò e ripregò il marito
di non porre limitazioni al sospirato evento.
Ligdo fu irremovibile. E ormai lei a stento
reggeva il peso del ventre maturo, quando
nel cuore della notte, mentre dormiva, le apparve
davanti al letto, o sognò che le apparisse, la figlia di Inaco,
accompagnata da tutto il suo séguito. Sulla fronte portava
le corna lunari, con spighe sfavillanti d'oro puro,
e le insegne regali. Al suo fianco latrava Anubi
e c'erano la santa Bubasti, Api dal manto a chiazze,
e il nume che spegne la voce e invita col dito al silenzio.
E poi i sistri, Osiride così a lungo cercato,
e il serpente esotico gonfio di veleno che procura il sonno.
E a Teletusa, che netto tutto vedeva, quasi fosse sveglia,
la dea così parlò: "O tu, che mi sei devota,
smetti di preoccuparti ed eludi l'ordine di tuo marito.
Quando Lucina t'avrà sgravato, non esitare: accogli
come tuo chi nascerà. Io sono una dea pietosa e a chi m'invoca
vengo in aiuto: non potrai dire d'aver pregato
una divinità ingrata". Dato questo consiglio, uscì di camera.
Felice la donna cretese si alzò dal letto e, levando agli astri
le mani senza macchia, pregò che la sua visione s'avverasse.
Poi le doglie crebbero e il feto venne alla luce senza fatica:
era una femmina, ma il padre non lo seppe, e la madre ordinò
che fosse allevata dicendo che era un maschio. Fu creduta
e nessuno fu edotto dell'inganno, se non la nutrice.
Il padre ringraziò gli dei e le impose il nome del nonno:
Ifi, come il nonno appunto. La madre si rallegrò di quel nome
che s'adattava a maschio e femmina, senza creare inganni.
Grazie a questo dolce artificio, la menzogna rimase nascosta:
l'abbigliamento era di un fanciullo; i lineamenti, che li assegnassi
a una femmina oppure a un ragazzo, erano belli in entrambi i casi.
Passarono così tredici anni, quando tuo padre
ti promise in moglie, Ifi, la bionda Iante, figlia
di Teleste del Dicte, ch'era fra quelle di Festo
la vergine più ammirata in virtù della bellezza sua.
Pari d'età e di bellezza, dagli stessi maestri
apprendevano i primi rudimenti della loro educazione.
Fu così che un reciproco amore sbocciò nei loro cuori ingenui
ferendoli entrambi; ma gli auspici erano diversi:
Iante non vede l'ora che venga il tempo delle nozze promesse,
convinta che colei che crede un uomo sarà suo marito;
Ifi spasima per una che sa di non poter mai possedere e
questo aggrava la passione, ardendo lei, vergine, per una vergine.
E trattenendo a stento le lacrime: "Che fine mai farò," dice,
"presa come sono da una passione, così mostruosa e inaudita,
che mai nessuno ha provato? Se gli dei volevano risparmiarmi,
risparmiarmi dovevano; altrimenti se volevano distruggermi,
m'avessero almeno dato una pena giusta secondo natura!
Non spasima giovenca per giovenca, né cavalla per cavalla;
ma pecora per l'ariete, cerva per il suo cervo.
Così s'accoppiano anche gli uccelli, e fra tutti gli animali
non v'è femmina che sia travolta da delirio per altra femmina.
Vorrei non esistere! È vero che le mostruosità più incredibili
accadono a Creta: la figlia del Sole s'innamorò di un toro,
ma erano pur sempre femmina e maschio. Il mio amore, a dire
il vero, è assai più insensato. E tuttavia lei poté appagare
la sua smania amorosa: con l'inganno, dentro una forma di vacca,
in sé accolse il toro, ed era un amante che veniva ingannato.
Ma anche ammesso che qui si riunissero gli ingegni del mondo intero,
che qui, volando con le sue ali di cera, Dedalo tornasse,
che potrebbe fare? Trasformarmi forse da vergine in ragazzo
con arti occulte? o forse mutare te, Iante?
Perché allora non ti fai coraggio, Ifi, e non torni in te,
liberandoti di questa fiamma sconsiderata e stolta?
Donna sei nata: convinciti, se non vuoi ingannare te stessa,
e aspira a ciò che è lecito, ama quel che deve amare una donna.
È la speranza che affascina, è la speranza a nutrire l'amore.
Ma a te la realtà la nega. Non è un guardiano a impedirti
l'amplesso che brami, non è il controllo di un marito sospettoso
o la severità di un padre; né al tuo desiderio lei si nega,
ma tu non puoi possederla, e anche se tutto andasse come deve,
tu non puoi essere felice, per quanto uomini e dei s'ingegnino.
Fino ad ora non c'è mio desiderio che sia caduto nel vuoto,
e gli dei, benevoli, m'hanno dato tutto quello che han potuto,
e ciò ch'io voglio, lo vuole mio padre, lei stessa e il futuro suocero.
Ma non lo vuole la natura: più potente di tutti costoro,
è la mia sola nemica! Il momento sospirato si avvicina,
arriva il giorno delle nozze, e Iante finalmente sarà mia,
ma averla non potrò: moriremo di sete in mezzo all'acqua.
Perché, Era, dea delle nozze, perché, Imeneo, venite
a questa festa? Qui non c'è lo sposo, ma solo due spose".
E spense la sua voce. Ma l'altra vergine non è meno
smaniosa e supplica che tu venga presto, Imeneo.
E Teletusa, temendo ciò che Iante agogna, rinvia la data,
prende tempo fingendo un malore, adducendo presagi e visioni
a pretesto. Ma alla fine non rimangono scuse
da inventare: la data delle nozze, rinviata,
è di nuovo imminente, non resta che un giorno. E allora
a sé e alla figliola lei toglie dal capo la benda che annoda
i capelli, e con le chiome sparse, abbracciata all'ara:
"Iside, che vivi a Paretonio, nei campi di Marea, di Faro
e in quelli del Nilo, che si dirama in sette foci,
aiutaci, ti prego," dice, "liberaci dai nostri timori!
Io ti ho vista, o dea, ti ho vista e riconosciuta con le tue insegne
e tutto il resto, il tuo séguito, le fiaccole e il suono
dei sistri, e porto impressi nella mente i tuoi precetti.
Se mia figlia è in vita ed io non sono punita,
è per consiglio e dono tuo. Abbi pietà di entrambe
e portaci soccorso!". Poi in pianto si sciolsero le parole.
Parve che la dea scuotesse il proprio altare (e l'aveva scosso);
tremarono le porte del tempio, sfavillarono corna
simili a falce di luna e risuonò il crepitio dei sistri.
Non ancora tranquilla, ma allietata da quel fausto auspicio,
la madre uscì dal tempio. Al suo fianco Ifi la segue,
ma con passo più lungo di prima; il suo viso non ha più il colore
candido d'un tempo, il corpo si è irrobustito, ed ora i lineamenti
sono più duri e più corta è la chioma sparsa al vento.
C'è più vigore nella sua persona, di quand'era femmina:
tu ch'eri tale, sei ora un maschio. Recate doni ai templi,
esultate con tutta la vostra fede! Portano doni ai templi
e aggiungono un'epigrafe: contiene un solo verso:
'Scioglie un uomo con questi doni il voto, che fece Ifi da femmina'.
Il giorno dopo, quando i raggi del sole illuminarono il mondo,
Afrodite, Era e Imeneo si unirono alla cerimonia
nuziale ed Ifi, il giovane Ifi, conquistò la sua Iante.