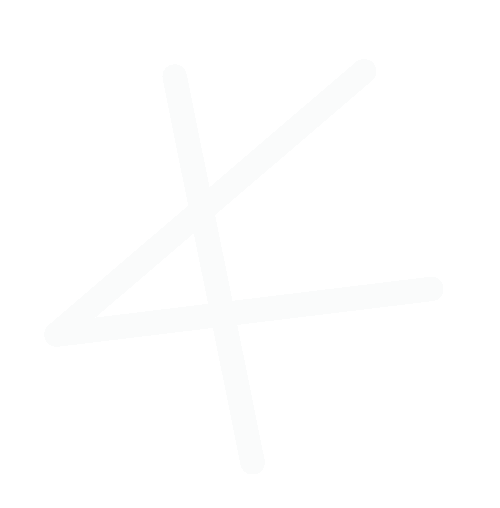Biblioteca:Ovidio, Metamorfosi, Libro V
Mentre attorniato dai Cefeni l'eroico figlio di Danae
racconta queste storie, l'atrio della reggia si riempì
d'una folla in tumulto: e non è clamore che celebri
riti nuziali, ma che prelude alla brutalità di uno scontro.
Trasformato all'improvviso in una rissa, si sarebbe potuto
paragonare quel convito al mare, quando la furia rabbiosa
dei venti ne sconvolge l'acque tranquille in un vortice di flutti.
Davanti a tutti Fineo, temerario fautore di guerra,
brandiva un'asta di frassino dalla punta di bronzo, gridando:
"Guardami in faccia, sono qui a vendicarmi della sposa rapita,
e neppure le tue ali o Zeus in parvenza d'oro
a me ti strapperanno!". Stava già per colpire, quando Cefeo:
"Che fai?" urlò. "Che pazzia ti spinge, fratello,
a commettere un delitto? È così che a tanti meriti
rendi grazie? Con questo dono lo ricambi d'averla salvata?
Se cerchi la verità, non fu Perseo a strappartela,
ma l'ostilità delle Nereidi, e Ammone armato di corna,
e il mostro che della carne della mia carne dal mare veniva
a saziarsi. Tu l'hai perduta nel momento in cui
fu condannata a morire; a meno che tu non voglia proprio questo,
che lei muoia e possa tu consolarti col mio lutto.
Allora non basta che sia stata incatenata sotto i tuoi occhi,
senza che tu, zio e fidanzato, le portassi il minimo aiuto;
ti duoli perfino che qualcuno l'abbia salvata
e vuoi strappargli la ricompensa? Se questa ti sembra eccessiva,
avresti dovuto sottrarla tu a quello scoglio dov'era affissa.
Lascia che chi l'ha salvata, impedendo che invecchiassi solo,
si prenda il premio pattuito a voce per i suoi meriti, e cerca
di capire che non a te è stato anteposto, ma a morte sicura".
Quello non rispose; ma volgendo lo sguardo ora al fratello
ora a Perseo, non ha ben chiaro chi dei due colpire;
poi, dopo un attimo di esitazione, con tutte le forze
che gli dà l'ira, a vuoto scaglia contro Perseo l'asta,
che si conficca nel letto. Solo allora in piedi balzò
Perseo, che inferocito avrebbe, riscagliando l'arma,
squarciato il petto al nemico, se questi non si fosse rifugiato
dietro l'altare, che con infamia salvò lo scellerato.
Ma non fu colpo a vuoto e la punta s'infisse in fronte a Reto,
che stramazzò e, come il ferro si divelse dal cranio,
con l'ultime convulsioni imbrattò di sangue la mensa imbandita.
È la scintilla: una rabbia indomabile infiamma la folla:
chi scaglia dardi e chi grida che con il genero
si debba uccidere Cefeo. Ma quest'ultimo era fuggito
ormai dal palazzo, dopo aver giurato su lealtà e giustizia,
sugli dei degli ospiti, che tutto accadeva contro il suo volere.
Presente era Pallade animosa a proteggere con l'egida
il fratello e a infondergli coraggio. E c'era Ati, un indiano
che si diceva nato in acque cristalline da Limnee, figlia
del fiume Gange. Di bellezza stupenda, esaltata dallo sfarzo
delle vesti, nel fiore dei suoi sedici anni, indossava
un mantello di Tiro tutto orlato di una banda d'oro;
monili dorati gli ornavano il collo e un diadema
gli incoronava i capelli intrisi di mirra.
Abile come pochi a centrare col giavellotto
i bersagli più lontani, lo era ancor di più a tendere l'arco.
E anche allora ne stava con la mano flettendo le corna,
quando Perseo lo colpì con un ceppo raccolto fumante
sull'ara, fracassandogli il cranio e sfigurandolo in volto.
Come lo vide sbarrare quegli occhi incantevoli in mezzo al sangue,
l'assiro Licabas, suo inseparabile e fedele compagno,
che mai aveva nascosto di nutrirgli sincero affetto,
pianse Ati che, soccombendo alla tremenda ferita, esalava
l'ultimo respiro; poi afferrato l'arco teso dall'amico:
"Con me dovrai ora misurarti" gridò, "e non potrai rallegrarti
a lungo della morte di questo ragazzo, che ti porta
più vergogna che gloria". Non si era ancora zittito,
che già la freccia acuminata era scoccata dalla corda,
ma, schivata da Perseo, s'impigliò nelle pieghe della sua veste.
Il nipote di Acrisio gli rivolse allora contro quella spada
che mise a morte Medusa e gliela ficcò nel petto:
ormai morente, con gli occhi smarriti nelle nebbie della notte,
Licabas si volse a cercare Ati e si abbandonò sul suo corpo,
portando tra le ombre il conforto d'essergli morto accanto.
Qui, smaniosi di combattere, caddero scivolando nel sangue,
che a fiumi impregnava la terra e la intiepidiva, Forbas di Siene,
figlio di Metione, e Anfimedonte di Libia; quando poi
cercarono di rialzarsi, a loro l'impedì
la spada, ficcata a Forbas nella gola e tra le costole all'altro.
Ma non con la falce della spada Perseo assalì Erito,
figlio di Actore, che brandiva una grande scure a doppia lama:
con entrambe le mani sollevò un cratere enorme
a figure sbalzate, pesantissimo e massiccio,
e glielo scagliò contro: vomitò quello un fiotto rosso di sangue
e cadendo supino batté a morte col capo la terra.
Abbatté quindi Polidegmone, della stirpe di Semiramide,
Abari del Caucaso e Liceto, figlio dello Sperchio,
Elice dai lunghi capelli intonsi, e Flegia e Clito,
calpestando cumuli sempre più alti di moribondi.
Fineo, non osando misurarsi corpo a corpo con l'avversario,
gli vibrò contro un giavellotto, che per errore piombò su Ida,
rimasto neutrale e invano estraneo allo scontro.
Fissando con occhi torvi il bieco Fineo, Ida gli urlò:
"Visto che sono costretto a prendere partito, tienti, Fineo,
il nemico che ti sei fatto e compensa colpo con colpo!".
E già stava per riscagliare l'arma estratta dal suo corpo,
quando crollò, afflosciandosi sulle membra ormai prive di sangue.
Lì cadde anche Odite, il più illustre dei Cefeni dopo il re,
sotto la spada di Clìmeno. Ipseo colpì Protoenore,
ma Perseo lo colpì a sua volta. Presente era pure Emazione,
un vegliardo amante della giustizia e timorato degli dei:
poiché l'età gli impediva di battersi, aggrediva e combatteva
con la parola, inveendo contro quella battaglia sciagurata.
Ma mentre cingeva con le braccia tremanti l'ara, Cromi
con la spada gli mozzò il capo, che rotolò sull'altare:
lì con la lingua ormai esanime lanciò parole
di esecrazione esalando l'anima in mezzo al fuoco.
E per mano di Fineo caddero i gemelli Brotea e Ammone
(quest'ultimo invincibile nel pugilato: ma che possono
i pugni contro le spade?), e cadde Ampico, sacerdote
di Cerere, con le tempie cinte di una candida benda;
e anche tu, figlio di Làmpeto, certo non adatto a queste cose,
ma ad accompagnare, in spirito di pace, la cetra con la voce:
ti avevano invitato ad allietare col canto convito e festa.
Mentre se ne stava in disparte, reggendo l'innocuo plettro,
Pedaso con scherno gli disse: "Canta il resto ai Mani
dello Stige!", e gli piantò un pugnale nella tempia sinistra.
Cadde, e con le dita ormai spente sfiorò ancora una volta le corde
della lira: fu sventura che ne uscisse un lamento funebre.
Furente, Licorma non tollerò che fosse ucciso impunemente:
divelta dallo stipite di destra una spranga di quercia,
in pieno l'abbatté sulla nuca di Pedaso,
che crollò bocconi a terra come un giovenco colpito dal maglio.
Pelate, nato in riva al Cinife, tentava a sua volta di svellere
lo stipite sinistro, e in quel tentativo Corito di Marmarica
gli trafisse la destra con la lancia, inchiodandola al legno.
Così immobilizzato, Abas lo colse al fianco: non cadde,
ma penzolò morente dal battente che tratteneva la mano.
E abbattuto è Melaneo, schieratosi al fianco di Perseo,
abbattuto è Dorila, latifondista di Nasamonia:
Dorila, così ricco di poderi, che di più vasti nessuno
ne possedeva o raccoglieva pari quantità d'incenso.
L'asta scagliatagli contro gli si piantò di traverso nell'inguine:
un punto mortale, quello. Quando il suo feritore,
Alcioneo di Battra, lo vide rantolare e rovesciare
gli occhi: "Di tanta terra che possiedi" gli urlò, "tienti
questo brandello su cui giaci!", e lo lasciò cadavere.
Per vendicarlo il pronipote di Abante strappò dalla ferita
ancora calda l'asta e gliela ritorse contro: trafitto il naso,
gli uscì dalla nuca, sporgendo avanti e dietro.
E finché la fortuna gli guidò la mano, fulminò
con ferite diverse Clizio e Clani, figli di una stessa madre:
vibrata da un braccio possente, un'asta trapassò
entrambe le cosce a Clizio; Clani morse coi denti un giavellotto.
E perì Celadone di Mendes; perì Astreo,
di madre palestinese e di padre incerto;
Etione, maestro nel prevedere il futuro,
ma questa volta ingannato da falsi presagi; Toacte,
scudiero del re, e Agirte, esecrato per aver ucciso il padre.
Il più però resta da fare: volontà di tutti è quella
d'annientare lui solo: unite in una causa che è un insulto
a merito e lealtà, da ogni parte l'incalzano intere schiere.
Dalla parte di Perseo sono il suocero, inutilmente leale,
e la sposa con sua madre, che riempiono l'atrio di pianti:
ma li sovrasta il fragore delle armi e il gemito dei caduti,
mentre nella casa profanata Bellona
riversa fiumi di sangue, alimentando di continuo la mischia.
Contro un uomo solo si stringono Fineo e i mille che lo seguono;
volano i dardi più fitti che d'inverno la grandine,
sfiorandogli entrambi i fianchi, sfiorandogli occhi e orecchie.
Perseo allora appoggia la schiena al marmo di una grande colonna,
e con le spalle al riparo, col viso rivolto contro gli armati,
sostiene l'attacco. Da sinistra l'assale
Molpeo di Caonia, da destra Echemmone di Nabatea.
Come una tigre che, rosa dai morsi della fame,
ode in valli diverse muggire due armenti e non sa
quale assalire per primo, smaniando d'assalirli entrambi,
così Perseo, incerto se gettarsi a dritta o a manca,
si sbarazza di Molpeo trafiggendogli una gamba
e si accontenta che fugga, perché non gli dà tregua Echemmone
e infuria, cerca di colpirlo in alto al collo,
ma, calcolato male lo slancio, spezza la spada
urtando con violenza la superficie della colonna:
la lama schizza via e si conficca nella gola del padrone.
Quella ferita tuttavia non basta a causarne la morte:
mentre barcolla e invano tende le braccia indifese,
Perseo gli affonda in corpo l'arma adunca donatagli da Ermes.
Quando però si accorse che al numero stava per soccombere
il valore: "Poiché voi stessi", disse, "a ciò mi costringete,
chiederò aiuto al nemico. Se un amico vi è tra voi,
volga altrove lo sguardo"; e in alto levò la testa di Gorgone.
"Cerca qualcun altro che si spaventi ai tuoi prodigi", gli rispose
Tescelo, e stava per scagliare un giavellotto micidiale,
ma restò immobilizzato in quell'atto, come una statua di marmo.
Accanto a lui, Ampico si avventava con la spada contro il petto
traboccante coraggio dell'erede di Linceo: nell'avventarsi
gli si irrigidì la destra e più non si mosse, né avanti né indietro.
Ed ecco Nileo, che si spacciava figlio del Nilo
diviso in sette foci, tanto da farsi cesellare lo scudo
con sette rami di fiume, parte in argento e parte in oro:
"Guarda, Perseo," disse, "chi è il capostipite della mia gente:
tra le ombre silenziose d'oltretomba gran conforto ti sarà
esser caduto per mano di tanto eroe!". Nel pronunciare
l'ultima frase, la voce si smorzò e avresti detto che, aperta,
la bocca volesse parlare, ma sfogo non dava alle parole.
Tuonando contro costoro: "Non per il potere di Gorgone",
gridò Erice, "v'intorpidite, ma per mancanza di coraggio!
Via, via, con me! abbattete quel giovane che brandisce magie!".
Pronto all'attacco era: il suolo trattenne i suoi passi
e come una pietra immobile rimase, una statua in armi.
Questi in verità meritata avevano la pena; ma ci fu
un soldato di Perseo, Aconteo, che mentre per lui si batteva,
faccia a faccia si trovò con Gorgone e si contrasse in pietra.
Astiage, credendolo ancora vivo, lo colpì di taglio
con la spada e questa risuonò con stridulo tintinnio.
Ancora sgomento, Astiage subì la medesima metamorfosi
e sul viso ormai di marmo si fissò un'espressione di stupore.
Troppo tempo ci vorrebbe per elencare i nomi dei guerrieri
meno in vista. Duecento ne restavano da battere:
duecento corpi alla vista di Gorgone impietrirono.
Solo allora Fineo si pentì di quell'iniqua battaglia.
Ma che poteva fare? Vedeva statue in pose diverse,
riconosceva i suoi e, chiamandoli ciascuno per nome,
chiedeva aiuto, non credendo ai propri occhi,
toccava i più vicini: marmo. Si volse e tendendo
di traverso mani e braccia, come chi supplica e ammette la colpa:
"Hai vinto, Perseo! Deponi il tuo mostro, occulta il volto
che pietrifica di questa tua Medusa, qualunque cosa sia;
occultalo, ti prego! Non mi ha spinto a guerra l'odio
o l'ambizione di regnare: per la mia sposa ho preso le armi.
A tuo favore stanno i meriti, al mio la precedenza.
Mi pento di non aver ceduto: nient'altro accordami
oltre la vita, insuperabile guerriero: il resto prendilo!".
E parlava senza avere il coraggio di guardare in volto
chi implorava. "Pavidissimo Fineo", gli rispose quello,
"ti concederò quanto posso concederti ed è un gran dono
per un vile, non temere: nessun'arma ti scalfirà.
Al contrario, ti donerò un monumento che rimanga nei secoli:
sempre ti si potrà ammirare nella casa di mio suocero,
perché mia moglie si consoli col ritratto del suo pretendente."
Così disse, e nella direzione in cui aveva Fineo sgomento
spinto il suo viso, spostò la testa della figlia di Forco.
Anche allora egli cercò di rivolgere altrove lo sguardo:
il collo s'irrigidì, le sue lacrime si fecero di pietra;
e nel marmo rimasero fissati un'espressione di terrore,
lo sguardo implorante, le mani tese in preghiera e un'aria umiliata.
Trionfante, Perseo rientrò con la sposa nelle mura paterne
e per rimettere sul trono e vendicare il nonno,
sia pure indegno, aggredì Preto, che aveva cacciato con le armi
il fratello Acrisio, impossessandosi della sua città.
E a vincere il torvo sguardo del mostro col capo cinto di serpi
non gli valse né l'aiuto delle armi né la rocca usurpata.
Malgrado ciò tu, Polidecte, re della minuscola Serifo,
non t'eri arreso al valore del giovane, mostrato in tante gesta,
né alle sue traversie: spietato, continuavi a nutrire per lui
un odio implacabile, perché la malvagità non ha confini.
Infamavi persino la sua gloria, sostenendo che la morte
di Medusa era un'invenzione. "Ti darò la prova!
Guardino altrove gli altri!", disse Perseo e col volto di Medusa
in pietra senza sangue tramutò il volto del re.
Sin qui al fianco del fratello, nato da una pioggia d'oro,
si era stretta Pallade; ma da Serifo, nascosta in una nube,
l'abbandonò, lasciando a destra Citno e Giaro,
e per la via che le parve più breve sul mare, raggiunse Tebe
e l'Elicona delle Muse. Arrivata sul monte,
si fermò, rivolgendo la parola a quelle sapienti sorelle:
"Alle mie orecchie è giunta notizia di una nuova fonte,
fatta scaturire dal duro zoccolo di Pegaso.
Per questo sono qui: volevo visitare questa meraviglia,
perché ho visto nascere il cavallo alato dal sangue di Medusa".
Le rispose Urania: "Qualunque sia il motivo per cui tu visiti
questa nostra dimora, o dea, lietissime ne siamo.
E la notizia è vera: sì, fu Pegaso a far scaturire
questa fonte". E condusse Pallade alla sacra polla.
A lungo lei ammirò le linfe sgorgate dai colpi di zoccolo,
contemplò tutt'intorno i recessi delle foreste secolari,
le grotte e i prati punteggiati d'innumerevoli fiori,
rallegrandosi con le figlie di Mnemosine per l'arte loro
e il luogo. E una delle sorelle così le si rivolse:
"O dea del Tritone, che avresti fatto parte della nostra schiera,
se il tuo valore non t'avesse assegnato a compiti più importanti,
dici il vero e a ragione lodi le arti nostre e i nostri luoghi.
Siamo fortunate, sì, purché noi si possa vivere tranquille.
Ma tutto turba la nostra mente di vergini (niente davvero
s'oppone all'empietà): nei miei occhi ancora aleggia l'immagine
del perfido Pireneo ed io del tutto non mi sono ripresa.
Con soldati di Tracia quel malvagio aveva conquistato DAulide
e le campagne della Focide e vi regnava senza diritto.
Noi eravamo dirette ai templi del Parnasso; ci vide
e simulando venerazione per la nostra divinità:
"Figlie di Mnemosine" disse (ci aveva infatti riconosciuto),
"fermatevi qui, non temete, vi prego, a evitare in casa mia
il maltempo e la pioggia" (diluviava): "gli dei non disdegnano
di rifugiarsi in umili capanne". Convinte dalle parole
e dal tempo, accettammo l'invito entrando nell'atrio.
La pioggia cessò e, vinto dall'Aquilone l'Austro,
le nuvole nere fuggivano per il cielo schiarito.
Smania ci prese di partire. Pireneo sbarrò le porte
e tentò di farci violenza: mettendo le ali gli sfuggimmo.
E lui con l'intenzione d'inseguirci, salito in cima alla rocca:
"Dov'è la vostra strada," gridò, "là sarà la mia!"
e come un pazzo si buttò dalla sommità della torre:
cadde a capofitto, frantumandosi il cranio contro il suolo;
morendo, lo imbrattò del proprio sangue scellerato".
La Musa stava parlando: nell'aria si udì un fruscio d'ali
e dalla cima dei rami vennero voci di saluto.
La figlia di Zeus sollevò gli occhi, chiedendosi chi emettesse
suoni tanto articolati e ritenne che fosse un uomo a parlare.
Erano uccelli: gazze, che rifanno a tutti il verso e che, posate,
nove in tutto, sui rami, si lamentavano del loro destino.
A Pallade stupita così disse l'altra dea: "Vedi, costoro,
vinte in gara, hanno or ora ingrossato lo stuolo degli uccelli.
Le generò il ricco Pìero nella terra di Pella; madre loro
fu Evippe di Peonia: nove volte invocò Lucina,
perché coi suoi poteri nove volte l'aiutasse a partorire.
Scioccamente orgogliose del loro numero, le sorelle,
passando per diverse città dell'Emonia e dell'Acaia,
vennero qui e ci sfidarono a tenzone con queste parole:
"Smettetela d'ingannare la gente ignorante con gli incantesimi
del vostro fascino: gareggiate con noi, se ne avete il coraggio,
o dee di Tespie. Né per virtù di voce o d'arte ci vincerete
e siamo nove come voi. Se vi batteremo, abbandonerete
nella terra degli Ianti la fonte Aganippe e quella di Pegaso;
nel caso contrario, abbandoneremo noi le terre dell'Emazia
sino a quelle innevate di Peonia. Arbitre siano le ninfe".
Un'onta era gareggiare, ma un'onta maggiore ci parve
non accettare. Le ninfe elette giurarono sui fiumi
e presero posto su sedili fatti di pietra viva.
Allora, senza sorteggio, la prima di loro disposta a battersi
cantò le guerre dei celesti, glorificando senza alcun merito
i Giganti e sminuendo le grandi imprese degli dei.
Diceva che Tifone, emerso dalle profondità della terra,
aveva terrorizzato i celesti al punto da volgerli in fuga,
finché, sfiniti, non li accolse la terra d'Egitto ,
dove il Nilo si ramifica in sette foci.
E che Tifone, figlio della Terra, giunse fin là,
costringendo gli dei a celarsi sotto mentite spoglie:
"Guida del branco", disse, "divenne Zeus, per cui in Libia
ancor oggi Ammone è raffigurato con corna ricurve;
il dio di Delo si mutò in corvo, il figlio di Semele in capro,
la sorella di Febo in gatta; in nivea vacca si celò la figlia
di Crono, Afrodite in pesce e nelle piume di un ibis Ermes".
Qui, accompagnandosi con la cetra, terminò il suo canto;
toccava a noi dell'Aonia. Ma tu forse hai da fare
e non hai tempo di ascoltare quello che cantammo".
"Non preoccuparti e riferiscimi per intero il vostro canto",
le rispose Pallade, sedendosi nella penombra del bosco.
Riprese la Musa: "Affidammo a una sola il compito della gara:
si alza Calliope e, raccolti con un tralcio d'edera i capelli,
dopo aver saggiato col pollice la sonorità delle corde,
con i loro accordi accompagna questo canto:
Per prima Cerere smosse col vomere dell'aratro le zolle,
per prima diede in coltura alla terra messi e frutti,
per prima diede leggi: a Cerere dobbiamo tutto.
Lei devo cantare; volesse almeno il cielo che potessi
dedicare versi degni a una dea così degna di un carme.
Immensa sulle membra di un gigante si distende l'isola
di Trinacria: sotto il suo enorme peso tiene schiacciato
Tifone, che aveva osato aspirare alle sedi dei celesti.
Lui, è vero, si agita dibattendosi per rialzarsi,
ma sopra la sua mano destra sta Peloro, vicino all'Ausonia,
sopra la sinistra tu, Pachino; Lilibeo gli preme le gambe,
sopra il capo gli grava l'Etna; e Tifone riverso sul fondo
dalla bocca inferocito erutta lava e vomita fiamme.
Spesso si sforza di rimuovere la crosta che l'opprime
e di scrollarsi di dosso città e montagne:
allora trema la terra e persino il re dei morti teme
che il suolo si squarci, che una voragine ne riveli i segreti
e che la luce irrompendo semini tra le ombre terrore e caos.
Proprio temendo queste calamità il sovrano era uscito
dal regno delle tenebre e su un cocchio aggiogato a neri cavalli
percorreva la Sicilia per saggiarne le fondamenta.
Convinto ormai che nessun luogo vacillava, si tranquillizzò,
quando in questo suo vagare dal monte Erice, dove viveva,
lo vide Afrodite che, stretto a sé il suo figliolo alato, disse:
"Armi e braccio mio, tu, figliolo, tu che incarni il mio potere,
prendi quell'arco con cui vinci tutti, mio Eros,
e scaglia le tue frecce folgoranti in petto al dio,
che l'ultimo dei tre regni ha avuto in sorte.
Alla tua mercé tu sai ridurre i celesti, Zeus stesso,
le divinità del mare e persino chi su loro regna:
perché l'Averno fa eccezione? Perché non estendi il tuo dominio
e quello di tua madre? In gioco è la terza parte del mondo.
E invece in cielo, ecco il frutto della mia pazienza,
sono derisa e a nulla col mio si riduce il potere di Amore.
Non vedi che Pallade e Artemide cacciatrice
mi scansano? Anche la figlia di Cerere, se non si interviene,
rimarrà vergine: non è questa la sua aspirazione?
E tu in nome del nostro regno, se un poco ti sta a cuore,
fai che la dea si congiunga allo zio". Così Afrodite; e quello,
sciolta la faretra, per ubbidire alla madre, fra mille
scelse una freccia, che più acuminata, più stabile
e più sensibile all'arco nessun'altra avrebbe potuto essere.
Puntando un ginocchio, tese le braccia elastiche dell'arco
e con la punta dell'asta colpì Ade dritto al cuore.
Non lontano dalle mura di Enna c'è un lago dalle acque profonde,
che ha nome Pergo: neppure il Caìstro nel fluire
della sua corrente sente cantare tanti cigni.
Un bosco fa corona alle sue acque, cingendole da ogni lato,
e con le fronde, come un velo, filtra le vampe del sole.
Frescura dona il fogliame, fiori accesi l'umidità del suolo:
una primavera eterna. In questo bosco Persefone
si divertiva a cogliere viole o candidi gigli,
ne riempiva con fanciullesco zelo dei cestelli e i lembi
della veste, gareggiando con le compagne a chi più ne coglieva,
quando in un lampo Ade la vide, se ne invaghì e la rapì:
tanto precipitosa fu quella passione. Atterrita la dea
invocava con voce accorata la madre e le compagne,
ma più la madre; e poiché aveva strappato il lembo inferiore
della veste, questa s'allentò e i fiori raccolti caddero a terra:
tanto era il candore di quella giovane, che nel suo cuore
di vergine anche la perdita dei fiori le causò dolore.
Il rapitore lanciò il cocchio, incitando i cavalli,
chiamandoli per nome, agitando sul loro collo
e sulle criniere le briglie dal fosco colore della ruggine;
passò veloce sul lago profondo, sugli stagni dei Palìci
che esalano zolfo e ribollono dalle fessure del fondale,
e là, dove i Bacchiadi, originari di Corinto che si specchia
in due mari, eressero le loro mura tra due insenature.
Tra le fonti Ciane e Aretusa Pisea c'è un tratto di mare,
che si restringe, racchiuso com'è tra due strette lingue di terra:
qui, notissima fra le ninfe di Sicilia,
viveva Ciane e da lei prese nome anche quella laguna.
Dai flutti emerse la ninfa sino alla vita,
riconobbe la dea: "Non andrete lontano," disse;
"genero di Cerere non puoi essere, se lei non acconsente:
chiederla tu dovevi, non rapirla. Se mi è lecito
paragonare grande e piccolo, anch'io fui da Anapi amata,
ma fui sua sposa dopo che ne fui pregata, non terrorizzata".
Così disse, e allargando le braccia cercò
di fermarli. Il figlio di Crono non trattenne più la sua rabbia:
aizzando i terribili cavalli, brandisce con tutto il vigore
del braccio lo scettro regale e l'immerge nelle profondità
dei gorghi: a quel colpo un varco sino al Tartaro si aprì nella terra
e il cocchio sprofondò nella voragine scomparendo alla vista.
Addolorata per il rapimento della dea e per l'oltraggio
inferto alla fonte, Ciane ammutolì serrando nel proprio cuore
l'inconsolabile ferita: tutta in lacrime si strusse
e si dissolse in quelle acque delle quali una divinità
insigne era stata innanzi. Avresti visto snervarsi le sue membra,
le ossa flettersi, le unghie perdere durezza;
e per prime si sciolsero le parti più sottili:
i capelli color del mare, le dita, i piedi e le gambe
(basta un attimo per mutare in acque gelide
l'esilità delle membra). Poi furono le spalle, il dorso, i fianchi,
il petto ad andarsene, svanendo in rivoli evanescenti;
infine in luogo del sangue vivo penetra l'acqua nelle vene
in dissoluzione e nulla più rimane che si possa afferrare.
Intanto Cerere, angosciata, in ogni terra,
in ogni mare cercava invano la figlia.
Mai Aurora, affacciandosi coi suoi capelli roridi,
la vide in pace, mai Vespero. Accese due torce di pino
alle fiamme dell'Etna, vagò senza requie,
tenendone una in ogni mano, nel gelo della notte;
e ancora, quando la luce del sole rese pallide le stelle,
cercava la figlia da ponente a levante.
Sfinita dalla fatica, era tormentata dalla sete
(a nessuna fonte aveva bagnato le labbra), quando per caso
vide una capanna di paglia: bussò alla piccola porta. Ed ecco:
ne esce una vecchia, che vedendola implorare un sorso d'acqua,
le porse una bevanda dolce insaporita con orzo tostato.
Mentre beveva quel dono, un ragazzo sfacciato e insolente
le si fermò davanti, scoppiò a ridere e la chiamò ingorda.
Si offese la dea e, senza terminare di bere,
gli getta in faccia, mentre parla, il liquido con l'orzo.
Al ragazzo il volto si coprì di macchie, e se prima aveva braccia,
ora gli sono zampe, e alle membra mutate si aggiunge una coda;
perché poi non potesse più nuocere, il corpo si contrasse
sino a ridursi in misura più piccolo di una lucertola.
Di fronte alla vecchia che, inebetita dal prodigio, piange e cerca
di toccarlo, egli fuggì in cerca di un rifugio, e si ebbe un nome
appropriato all'aspetto del corpo, che era costellato di chiazze.
Troppo lungo sarebbe indicare tutte le terre e i mari
che alla ricerca percorse la dea: le venne meno il mondo.
Ritornò in Sicilia e, mentre camminando scrutava in ogni luogo,
arrivò nei pressi di Ciane, che tutto le avrebbe raccontato,
se non si fosse trasformata e che, per quanto volesse parlare,
non aveva bocca e lingua, né altro per potersi esprimere.
Ciò malgrado le fornì un indizio inequivocabile, mostrandole
a pelo d'acqua una cintura a lei ben nota, che in quel punto
era per caso caduta a Persefone tra i flutti sacri.
Non appena la riconobbe, come se solo allora intuisse
ch'era stata rapita, la dea si strappò i capelli scarmigliati
e ripetutamente si percosse il petto con le mani.
Ancora non sa dove sia, e maledice tutte le contrade
della terra, chiamandole ingrate e indegne del dono delle messi,
e più di tutte la Trinacria, dove aveva scoperto le tracce
della disgrazia. E lì con mano spietata spezzò gli aratri
che rivoltano le zolle, furibonda condannò a morte
uomini e buoi insieme, e impose ai seminati di tradire
le speranze in essi riposte avvelenando le sementi.
La fertilità di quella regione, decantata in tutto il mondo,
è smentita e distrutta: le messi muoiono già in germoglio,
guastandosi per troppo sole o troppa pioggia;
stelle e venti le rovinano, con avidità gli uccelli
ne beccano nei solchi i semi; loglio, rovi
e inestirpabile gramigna soffocano il suo frumento.
Dalle acque dell'Elide la ninfa amata da Alfeo sollevò allora
il capo e, scostatesi le chiome stillanti indietro dalla fronte,
disse: "O madre della vergine che hai cercato in tutto l'universo,
o madre delle messi, interrompi la tua fatica senza fine
e per la collera non adirarti con la terra a te fedele.
Non ha colpe la terra: suo malgrado si è dischiusa al rapitore.
Non ti supplico per la mia patria: qui sono un'ospite;
la mia patria è Pisa, dall'Elide io vengo.
Straniera sono in Sicilia; ma questa regione mi è cara
più d'ogni altra: ora col nome di Aretusa ho qui la mia dimora,
questa è la mia terra, e tu, che sai essere così mite, risparmiala!
Perché mi sia trasferita lungo la vastità del mare
per giungere in Ortigia, verrà il momento opportuno
di narrarlo quando avrai superato questa angoscia
e più sereno sarà il tuo volto. Per farmi passare, la terra
mi schiude un cammino ed io scorrendo nei suoi profondi abissi,
qui riemergo a rivedere le stelle quasi dimenticate.
E passando sottoterra tra i gorghi dello Stige,
ho visto laggiù con i miei occhi la tua Persefone:
triste, sì, e con l'aria ancora un po' spaventata,
ma regina, suprema entità di quel mondo tenebroso,
consorte incontrastata del re dell'Averno".
A quella rivelazione la madre rimase di sasso
e a lungo come paralizzata, ma poi quando lo stordimento
fu sostituito da un dolore non meno profondo, col cocchio
si lanciò verso gli spazi del cielo. Lì, rannuvolata in volto,
piena d'odio, si parò coi capelli arruffati davanti a Zeus
e: "Per il sangue mio e tuo" disse, "vengo, Zeus,
a supplicarti. Se non v'è riguardo per la madre,
che il padre abbia almeno a cuore sua figlia; e spero che l'averla
partorita io non t'induca ad occupartene di meno.
Ecco che dopo tanto cercare l'ho alfine ritrovata,
se chiami ritrovare il perdere con più certezza o chiami
ritrovare il sapere dove sia finita. Rapita? pazienza,
purché lui me la renda: tua figlia non può avere un predone
per marito, anche se come mia figlia lo potesse!".
Rispose Zeus: "Da comune affetto e obblighi siamo legati
entrambi a questa figlia; ma se vuoi dare alle cose
il giusto nome, non è un affronto ciò che è accaduto,
è frutto dell'amore; ed io non mi vergognerò di un tale genero,
se anche tu, dea, lo vuoi. Pur se il resto gli mancasse, che titolo
essere fratello di Zeus! Ma il resto poi non gli manca,
e inferiore mi è solo per sorte. Però se desideri tanto
che si separino, Persefone rivedrà il cielo,
ma a una condizione precisa: che lei non abbia laggiù toccato
cibo alcuno con la sua bocca: questo hanno decretato le Parche".
Così disse; ma se Cerere era certa di riottenere la figlia,
non lo permetteva il destino, perché la vergine aveva rotto
il digiuno: mentre innocentemente si aggirava in un giardino,
da un ramo spiovente aveva colto una melagrana
e staccati sette granelli dal pallido involucro,
li aveva succhiati con le labbra. L'unico a vederla fu Ascalafo,
che, a quanto si dice, Orfne, non certo la più sconosciuta
tra le ninfe dell'Averno, aveva dal suo amato Acheronte
partorito nel folto di una selva oscura.
La vide e con la sua spietata delazione ne impedì il ritorno.
Mandò un gemito la regina dell'Erebo e mutò il testimone
in uccello di sventura: irrorato dall'acqua del Flegetonte,
il capo assunse becco, piume ed occhi enormi.
Sottratto a sé stesso, s'ammantò d'ali fulve,
gli crebbe il capo e le unghie allungandosi s'incurvarono in artigli:
a stento agitava le penne spuntategli sulle braccia inerti.
Diventò un uccello sinistro, messaggero di lutti imminenti,
un gufo indolente, presagio di calamità per i mortali.
Costui però s'era meritato, a quanto pare, la pena
parlando troppo e facendo la spia: ma perché voi, Sirene,
avete penne e zampe d'uccello, con volto di fanciulla?
Forse perché, quando Persefone coglieva fiori in primavera,
voi, sapienti figlie di Acheloo, foste fra le sue compagne?
Dopo averla cercata invano per tutta la terraferma,
perché anche il mare sapesse quanto eravate angosciate, ecco che
desideraste di potervi reggere sui flutti remigando
con le ali e, trovati gli dei ben disposti, d'un tratto
vi vedeste gli arti farsi biondi di penne.
Ma perché al vostro famoso canto, fatto per ammaliar l'udito,
perché al talento delle vostre labbra non mancasse l'espressione,
vi rimasero volto di fanciulla e voce umana.
Quanto a Zeus, arbitro tra il fratello e la sorella in lacrime,
divise il corso dell'anno in due parti uguali:
ora la dea, divinità comune ai regni di cielo ed Averno,
vive sei mesi con la madre e sei con il marito.
E subito lei cambia d'umore e d'aspetto:
se sino allora poteva apparire cupa persino a Ade,
ora ha la fronte lieta, come il sole che, prima coperto
da nubi di pioggia, fra squarci di nubi s'affaccia.
L'alma Cerere, rasserenata per aver riavuto la figlia,
ti chiede, Aretusa, perché fuggisti e consacrata sei sorgente.
Tacquero le acque; dal fondo dei gorghi la dea sollevò
il capo, si asciugò con la mano i verdi capelli
e incominciò a narrare gli antichi amori del fiume Alfeo.
"Una delle ninfe che vivono in Acaia io ero," disse,
"e nessun'altra con più passione andava di balza in balza,
nessun'altra con più passione tendeva le reti.
E sebbene non avessi mai preteso d'essere bella,
malgrado la mia prestanza, bella ero considerata.
Ma le lodi eccessive al mio aspetto non m'inorgoglivano,
e mentre ad altre capita di goderne, io, semplice e scontrosa,
delle mie doti arrossivo e se piacevo lo stimavo una colpa.
Tornavo affaticata, ricordo, dalla foresta di Stinfalo.
C'era un caldo afoso e la mia stanchezza ne aumentava il peso.
M'imbatto in un fiume che scorreva senza vortici e mormorii,
così limpido che dall'alto avresti potuto in fondo al suo letto
contare i sassolini, facendoti dubitare che fluisse.
Pallidi salici e pioppi nutriti dall'umidità stendevano
sulle rive in declivio il naturale espandersi dell'ombra.
Mi accostai e all'inizio bagnai la pianta dei piedi,
poi le gambe sino al ginocchio e non contenta mi spogliai,
appesi al ramo spiovente di un salice le vesti trasparenti
e nuda m'immersi nell'acqua. Mentre la fendevo e in mille modi
la schizzavo guizzando, levando e rituffando le braccia,
percepii uno strano bisbiglio salire da mezzo i gorghi
e atterrita mi rifugio sul bordo della riva più vicina.
'Dove corri, Aretusa?' diceva dalle sue onde Alfeo,
'Dove corri?' ripeteva con voce roca.
Ed io fuggii, così com'ero, senza vesti: sulla riva opposta
erano rimaste le mie. Ma lui sempre più m'incalzava
e s'infiammava, perché essendo nuda, mi credeva più accessibile.
Così io correvo e così lui implacabile m'inseguiva,
come fuggono in un battere d'ali le colombe
davanti allo sparviero e come questo le incalza tutte tremanti.
Fino alle porte di Orcomeno, fino a Psofide e al Cillene,
agli anfratti del Menalo, al gelido Erimanto e giù fino all'Elide
resse la mia corsa, senza che lui mi raggiungesse;
ma correre più a lungo con forze inferiori
io non potevo, mentre lui reggeva bene alla fatica.
Eppure corsi per pianure, per montagne fitte d'alberi
e per rocce, per rupi e dove non s'intravedeva alcun sentiero.
Avevo il sole alle spalle: davanti a me vedevo
allungarsi un'ombra, se non era il mio terrore a vederla,
ma certo è che il rumore dei suoi passi m'atterriva e sulla benda
dei miei capelli incombeva l'ansito affannoso del suo respiro.
Stremata dalla fatica: 'Aiuto', grido, 'mi prende!
Aiuta, Artemide, la tua scudiera, a cui hai concesso di portare
così spesso il tuo arco e le frecce chiuse nella faretra'.
Commossa, la dea m'avvolse in una nube strappata
a un cumulo. La foschia mi nasconde e Alfeo
scruta e mi cerca, senza riuscirvi, intorno al viluppo della nube:
due volte gira ignaro intorno al luogo dove la dea m'ha nascosto
e due volte: 'Aretusa! Aretusa!' m'invoca.
In che travaglio si trovò il mio cuore? Diverso forse da quello
di un'agnella che sente i lupi ringhiare intorno alle stalle,
o di una lepre che appiattata in un cespuglio scorge i musi ostili
dei cani e non osa fare il benché minimo movimento?
Ma lui non s'allontana: non scorge più in là
orme di piedi e sorveglia nuvola e luogo.
Un sudore freddo, stretta in quell'assedio, mi pervade le membra;
da tutto il mio corpo cadono gocce azzurre;
se sposto il piede, si forma una pozza; dai capelli
cola rugiada e, in men che non ti dica i fatti,
mi muto in sorgente. Ma il fiume nell'acqua riconosce l'amata
e, lasciato l'aspetto virile che aveva assunto, torna ad essere
quello che è, una corrente, per mescolarsi con me.
Artemide squarciò allora il suolo ed io, sommersa in ciechi baratri,
giungo qui ad Ortigia, che mi è cara perché deve il suo nome
alla mia dea e mi riporta alla luce del giorno."
Fin qui Aretusa. Cerere, dea della fertilità, aggiogò al carro
due serpenti, ne imbrigliò la bocca col morso,
e viaggiando per l'aria, tra cielo e terra, calò sulla città
della dea del Tritone. Qui consegnò il suo cocchio volante
a Triptòlemo e in più gli affidò dei semi ordinandogli di spargerli
parte in terra incolta e parte in quella dopo anni ricoltivata.
Ed ecco che il giovane, passato a volo sopra l'Europa
e le terre dell'Asia, atterra nel paese degli Sciti.
Qui regnava Linco e il giovane entrò nel suo palazzo.
Invitato a dire da dove veniva, la ragione del viaggio,
il nome e la patria: "La mia patria", rispose, "è la famosa Atene,
il mio nome Triptòlemo. Non sono venuto in nave per mare,
né a piedi per terra: aperta mi fu la via dell'etere.
Porto i doni di Cerere, che sparsi per la vastità dei campi,
produrranno i frutti delle messi e gli alimenti per l'uomo".
Quel barbaro fu preso dall'invidia e per attribuirsi il titolo
di benefattore, gli offrì ospitalità per poterlo aggredire
con un'arma nel sonno; e stava già per trapassargli il petto,
quando in lince lo mutò Cerere, raccomandando al giovane
ateniese di riprendere il volo con la pariglia divina.
La più illustre di noi aveva terminato il suo canto squisito.
E le ninfe dichiararono in coro che avevamo vinto noi,
le dee dell'Elicona. Ma poiché le perdenti lanciavano
insulti, disse Calliope: "Già meritavate una punizione
per averci sfidato, ma visto che non vi basta e alla mancanza
aggiungete le invettive, la nostra pazienza ha davvero un limite:
provvederemo a punirvi, giungendo fin dove ci spinge l'ira".
Ridono le giovani dell'Emazia, ignorando quelle minacce;
ma mentre tentano di parlare e di alzare le mani arroganti
urlando contro di noi, vedono dalle proprie unghie spuntare
penne, le braccia coprirsi di piume, e l'una all'altra
vede sporgere dal volto un becco rigido e adunco
e quelle andarsene nei boschi, diventate uccelli.
E mentre vogliono battersi il petto, agitando le braccia
si librano nell'aria: gazze, che schiamazzano nei boschi.
Ancor oggi in questi uccelli è rimasta la primitiva facondia:
una loquacità roca, una voluttà smodata di ciarlare".