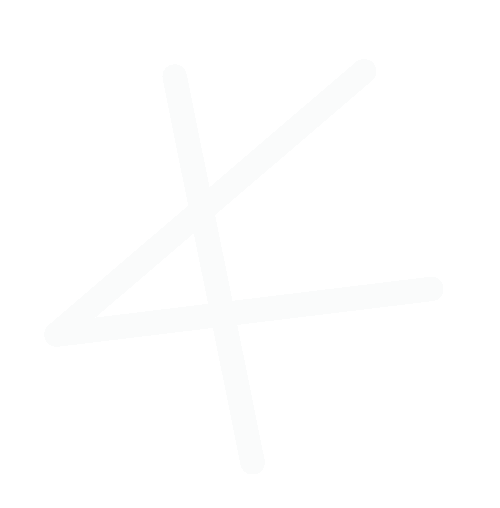Biblioteca:Ovidio, Metamorfosi, Libro III
Abbandonate le false sembianze di toro, ormai Zeus
si era svelato e aveva raggiunto le campagne di Creta,
quando il padre, all'oscuro del rapimento, ordinò a Cadmo
di cercargli la figlia, con la minaccia, per crudeltà e affetto
insieme, di esiliarlo se non l'avesse trovata.
Percorsa invano la terra (e chi potrebbe scoprire i sotterfugi
di Zeus?), come un esule il figlio di Agenore evita la patria,
l'ira paterna, e consulta l'oracolo di Febo
supplicandolo di dirgli in che terra si debba fermare.
"In una landa deserta", afferma Febo, "incontrerai una giovenca
che, non obbligata al curvo aratro, mai ha subito il giogo:
seguila dove ti guida e nella pianura in cui s'adagerà
innalza delle mura e chiama Beozia quella regione."
Appena disceso dall'antro di Castalia, Cadmo
vide passare lentamente una giovenca incustodita,
che sul collo non recava segno di schiavitù.
La segue e con cautela ne ripercorre le tracce,
ringraziando in cuore Febo d'indicargli il cammino.
Superati i guadi del Cefiso e i campi di Panope,
l'animale si fermò e levando al cielo la fronte
ornata di alte corna, riempì l'aria di muggiti,
poi voltandosi a guardare chi lo seguiva,
si accosciò stendendo il fianco sull'erba tenera.
Riconoscente Cadmo imprime baci su quel suolo
straniero e saluta quei monti e campi sconosciuti.
Si accinge poi a onorare Zeus e ordina ai servi di recarsi
ad attingere acqua per la cerimonia a una fresca sorgente.
C'era una foresta antica, inviolata dalla scure,
e in mezzo, tra un intrico di rami e virgulti, una spelonca,
dove, sotto una bassa volta sorretta da un ammasso di pietre,
sgorgava abbondante l'acqua. Qui stava rintanato
un serpente generato da Ares e screziato di squame d'oro:
saettano fuoco gli occhi, gonfio tutto di veleno è il suo corpo,
e in mezzo a tre file di denti guizzano tre lingue.
In questo bosco per sventura s'inoltrò la gente
venuta da Tiro. L'anfora calata nell'acqua
fece un tonfo, ed ecco che livido il serpente dal fondo dell'antro
trae fuori il capo vomitando sibili orrendi.
Sfuggono le anfore dalle mani, esangue si fa il corpo
e un tremito improvviso pervade le membra irrigidite.
Con rapide volute il mostro avvolge in spire
le sue squame e con un guizzo si tende in archi immensi;
ergendosi con oltre metà del suo corpo nel vuoto dell'aria,
domina tutto il bosco: tanto è grande, se tu lo vedessi intero,
quanto il Serpente che separa le due Orse.
Poi di colpo s'avventa sui Fenici, o che s'apprestino a combattere,
a fuggire o che il terrore impedisca loro entrambe
le azioni: e questi li uccide coi morsi, quelli tendendo le spire,
altri infine infettandoli col miasma mortale del suo veleno.
Già il sole altissimo aveva ridotto le ombre a un filo:
stupito del ritardo dei compagni, il figlio di Agenore allora
si mise a cercarli. Addosso portava la pelle strappata
a un leone, per armi un'asta smagliante di ferro,
un dardo e, più efficace di qualsiasi arma, il suo coraggio.
Come penetrò nel bosco e vide i cadaveri
e su questi lo smisurato avversario che vittorioso
leccava le macabre ferite con la lingua lorda di sangue:
"O vendicherò la vostra morte, fedelissimi miei,"
esclamò, "o vi sarò compagno". Disse, e con la destra sollevò
un macigno e grande quant'era con gran furia lo scagliò.
Quell'urto avrebbe raso al suolo anche le mura più massicce
con le sue torri svettanti: incolume rimase il serpente;
le squame compatte della sua pelle nera, che lo proteggevano
come una corazza, respinsero quel colpo spaventoso.
Ma la sua corazza non valse contro il dardo,
che si conficcò in mezzo alla spina dorsale, dove questa
flettendosi s'inarca, e penetrò con tutto il ferro nelle viscere.
Pazzo di dolore il serpente torse il capo verso il dorso
e scorta la ferita, addentò l'asta che vi era confitta
e, dopo averla scossa con violenza da ogni parte,
alla fine la divelse, ma il ferro gli rimase nelle ossa.
Allora che al suo furore abituale si aggiunse
nuovo sprone, un flusso di sangue gli gonfiò la gola,
una bava biancastra gli spumeggiò intorno alle fauci letali;
graffiata dalle sue squame la terra stridette e l'alito nero
che gli usciva dalla bocca infernale ammorbò di fetore l'aria.
Ora si raggomitola in spire che descrivono archi
immensi, mentre a volte s'inerpica più dritto di un alto fusto,
ora con impeto immane, come un fiume ingrossato dalle piogge,
si lancia e col petto abbatte ogni ostacolo che nella selva incontra.
Il figlio di Agenore arretra un po' e nelle spoglie del leone
sostiene l'assalto, con la lancia protesa tiene a bada
la bocca che lo incalza. Quello infuria, a vuoto avventa morsi
contro il duro ferro e ficca i suoi denti nella punta.
Dal suo palato gonfio di veleno ormai il sangue cominciava
a stillare, schizzando di macchie il verde dell'erba.
Ma era ferita leggera, perché il mostro sfuggiva ai colpi
piegando indietro il collo offeso e arretrando impediva
all'arma di piantarsi e di penetrare più a fondo;
finché il figlio di Agenore, puntandogli l'asta contro la gola,
non lo incalzò da presso e, quando alle sue spalle nel ritrarsi
si parò una quercia, insieme trafisse collo e tronco.
Sotto il peso del serpente l'albero s'incurvò e gemette
per le sue fibre sferzate dall'estremità della coda.
Mentre il vincitore osserva le spoglie smisurate del nemico,
si udì una voce all'improvviso (donde venisse non si capiva,
ma certo si udì): "Perché, figlio di Agenore, guardi
quel serpente ucciso? Tu stesso come serpente sarai guardato".
Sbigottito Cadmo smarrì a lungo la mente
e il colore, coi capelli ritti, gelato dal terrore.
Ed ecco che, scendendo dall'alto dei cieli, la sua protettrice,
Pallade gli è accanto e gli ordina, scavata la terra,
di seppellirvi i denti del drago, germi di un popolo futuro.
Lui ubbidisce e, com'ebbe tracciato un solco affondando l'aratro,
ligio sparge al suolo quei denti, semi di stirpe mortale.
Allora, si stenta a crederlo, prende a tremare la terra,
dal solco affiorano prima picche di lance,
poi spuntano elmi con al vento i loro pennacchi variopinti,
poi spalle, petti, braccia cariche di armi
e prolifica infine una messe di guerrieri armati di scudo:
così vedi sorgere le figure, quando nei giorni di festa
si solleva in teatro il sipario: prima mostrano il volto,
poi man mano il resto, finché continuando pian piano a crescere
appaiono intere, coi piedi che poggiano sul bordo del palco.
Cadmo, atterrito dal nuovo nemico, sta per prendere le armi:
"Non farlo!" gli grida uno del popolo spuntato
dalla terra. "Non intrometterti in guerre civili".
E in quell'istante ferì dritto di spada uno dei fratelli nati
dalla terra al suo fianco, ma lui stesso cadde colpito da un dardo.
E chi l'uccise, anche lui, non visse più a lungo
ed esalò quel respiro che aveva appena avuto in dono.
E come questi il gruppo intero infuria: combattendo
fra loro, per reciproche ferite cadono insieme i fratelli.
Ormai quella gioventù, destinata a così breve vita,
col petto insanguinato giaceva nel tepore di madre terra:
cinque solo i superstiti e fra questi Echione
che, ammonito da Pallade, gettò al suolo le proprie armi,
chiese e strinse un patto di pace coi fratelli.
Così lo straniero di Sidone li ebbe compagni di lavoro,
quando fondò la città designata dall'oracolo di Febo.
Tebe ormai era sorta, ormai potevi, Cadmo, sembrare felice
in quell'esilio: per suoceri avevi Ares e Afrodite,
e a questo aggiungi la prole nata da una consorte così illustre,
tanti figli, tante figlie e, pegno d'affetto, i tuoi nipoti,
anche loro ormai giovinetti. Ma vero è che sempre l'uomo
debba attendere il giorno estremo: nessuno mai, prima
della morte e delle proprie esequie, dovrebbe asserirsi felice.
Fra tanta felicità il primo dolore ti fu causato,
Cadmo, da tuo nipote, da quelle strane corna cresciutegli
in fronte, e da voi, cani, che vi abbeveraste al sangue del padrone.
Ma, a ben guardare, in lui vedrai torto di malasorte,
non malvagità: e quale malvagità è in un errore?
C'era un monte intriso del sangue di diversa selvaggina,
e già il mezzogiorno aveva contratto le ombre delle cose,
perché il sole si trovava a ugual distanza dai suoi confini,
quando il giovane Ianteo si rivolse con voce pacata
ai compagni di caccia che si aggiravano per forre isolate:
"Amici, armi e reti sono madide del sangue di animali;
giornata fortunata questa: può bastare. Quando, trascinata
dal suo cocchio d'oro, domani Eos riporterà la luce,
ci rimetteremo all'opera. Ora Febo è a metà
del suo cammino e spacca la terra con la sua vampa.
Sospendete l'opera in corso e togliete l'intrico delle reti".
Gli uomini eseguono e interrompono il loro lavoro.
C'era una valle coperta di pini e sottili cipressi,
chiamata Gargafia, sacra a Artemide dalle vesti succinte,
nei cui recessi in fondo al bosco si trovava un antro
incontaminato dall'uomo: la natura col suo estro
l'aveva reso simile a un'opera d'arte: con pomice viva
e tufo leggero aveva innalzato un arco naturale.
Sulla destra in mille riflessi frusciava una fonte d'acque limpide,
col taglio della sua fessura incorniciato di margini erbosi.
Qui veniva, quand'era stanca di cacciare, la dea delle selve
per rinfrescare il suo corpo di vergine in acque sorgive.
E qui giunta, alla ninfa che le fa da scudiera consegna
il giavellotto, la faretra e il suo arco allentato;
si sfila la veste che un'altra prende sulle braccia;
due le tolgono i sandali dai piedi, e la figlia di Ismeno,
Crocale, più esperta di queste, in un nodo le raccoglie i capelli
sparsi sul collo, che lei al solito portava sciolti.
Nefele, Iale, Ranide, Pseca e Fiala attingono acqua
con anfore capaci e gliela versano sul corpo.
Mentre Artemide si bagnava così alla sua solita fonte,
ecco che il nipote di Cadmo, prima di riprendere la caccia,
vagando a caso per quel bosco che non conosceva,
arrivò in quel sacro recesso: qui lo condusse il destino.
Appena entrò nella grotta irrorata dalla fonte,
le ninfe, nude com'erano, alla vista di un uomo
si percossero il petto e riempirono il bosco intero
di urla incontrollate, poi corsero a disporsi intorno a Artemide
per coprirla con i loro corpi; ma, per la sua statura,
la dea tutte le sovrastava di una testa.
Quel colore purpureo che assumono le nubi se contro
si riflette il sole, o che possiede l'aurora,
quello apparve sul volto di Artemide sorpresa senza veste.
Benché attorniata dalla ressa delle sue compagne,
pure si pose di traverso e volse il volto indietro.
Non avendo a presa di mano le frecce, come avrebbe voluto,
attinse l'acqua che aveva ai piedi e la gettò in faccia all'uomo,
inzuppandogli i capelli con quel diluvio di vendetta,
e a predire l'imminente sventura, aggiunse:
"Ed ora racconta d'avermi vista senza veli,
se sei in grado di farlo!". Senza altre minacce,
sul suo capo gocciolante impose corna di cervo adulto,
gli allungò il collo, gli appuntì in cima le orecchie,
gli mutò le mani in piedi, le braccia in lunghe zampe,
e gli ammantò il corpo di un vello a chiazze.
Gli infuse in più la timidezza. Via fuggì l'eroe, figlio di Autonoe,
e mentre fuggiva si stupì d'essere così veloce. Quando
poi vide in uno specchio d'acqua il proprio aspetto con le corna,
"Povero me!" stava per dire: nemmeno un fil di voce gli uscì.
Emise un gemito: quella fu la sua voce, e lacrime gli scorsero
su quel volto non suo; solo lo spirito di un tempo gli rimase.
Che fare? Tornare a casa, nella reggia, o nascondersi
nei boschi? Quello glielo impediva la vergogna, questo il timore.
Mentre si arrovellava, lo avvistarono i cani. Melampo e Icnobate,
quel gran segugio, per primi con un latrato diedero il segnale
(Icnobate di ceppo cretese, Melampo di razza spartana).
Poi di corsa, più veloci di un turbine, si avventarono gli altri:
Pamfago, Dorceo e Oribaso, tutti dell'Arcadia,
e il forte Nebrofono, il truce Terone con Lelape,
Pterelao e Agre, eccellenti l'una in velocità, l'altra nel fiuto,
e il battagliero Ileo ferito di recente da un cinghiale,
Nape concepita da un lupo, Pemenide già guardiana
di mandrie e Arpia accompagnata dai due figli,
Ladone di Sicione coi suoi fianchi scarni,
e Dromade, Canace, Sticte, Tigri ed Alce,
Leucone e Asbolo, col pelo niveo il primo, di pece il secondo,
il fortissimo Lacone e Aello insuperabile nella corsa,
e Too, la veloce Licisca col fratello Ciprio,
Arpalo con una stella bianca in mezzo alla fronte nera,
e Melaneo e Lacne col suo mantello irsuto,
Labro e Agriodo nati da padre cretese,
ma da madre di Laconia, e Iletore con la sua voce acuta,
e altri, troppi da elencare. Tutta questa muta, avida di preda,
per rupi, anfratti e rocce inaccessibili, dove la via
è impervia o dove via non esiste, l'insegue.
Lui fugge, per quei luoghi dove un tempo li aveva seguiti,
ahimè lui fugge i suoi stessi fedeli. Vorrebbe gridare:
"Sono Atteone! Non riconoscete più il vostro padrone?".
Vorrebbe, ma gli manca la parola. E il cielo è pieno di latrati.
Le prime ferite gliele infligge sul dorso Melanchete,
poi Terodamante; Oresitrofo gli si avvinghia a una spalla:
erano partiti in ritardo, ma tagliando per i monti
avevano abbreviata la via. Mentre essi trattengono il padrone,
il resto della muta si raduna e in corpo gli conficca i denti.
Ormai non c'è più luogo per altre ferite. E geme,
ma con voce che, se non è umana, neanche un cervo
emetterebbe, e riempie quei gioghi di lugubri lamenti:
in ginocchio, supplicando come chi prega,
volge intorno muti sguardi quasi fossero braccia.
I suoi compagni intanto con gli sproni di sempre aizzano ignari
il branco infuriato e cercano Atteone con gli occhi,
poi, come se fosse lontano, 'Atteone' gridano a gara
(al suo nome lui gira il capo) e si lamentano che non ci sia,
che per pigrizia si perda lo spettacolo offerto dalla preda.
Certo lui vorrebbe non esserci, ma c'è; vorrebbe assistere
senza dover subire la ferocia dei suoi cani. Ma quei cani
da ogni parte l'attorniano e, affondando le zanne nel corpo,
sbranano il loro padrone sotto il simulacro di un cervo:
e si dice che l'ira della bellicosa Artemide non fu sazia,
finché per le innumerevoli ferite non finì la sua vita.
I pareri sono incerti: per alcuni troppo crudele
fu la dea; altri la lodano, considerandola degna
della sua verginità austera; ognuno con buone ragioni.
Solo la consorte di Zeus non si perde in pro e contro,
ma esulta per la sciagura che ha colpito il casato
di Agenore, perché su tutta la stirpe riversa l'odio
concepito per la rivale fenicia. E a quell'antico motivo
se ne aggiunge uno nuovo: lo sdegno che in seno porti Semele
il seme del grande Zeus; e affila la lingua per la lite, ma:
"Che mai ne ho ricavato," dice, "tutte le volte che ho litigato?
Colpirla, questo devo; sì, la distruggerò, quanto è vero
che mi chiamo Era la suprema, che ho il diritto d'impugnare
uno scettro sfavillante di gemme, che sono regina, moglie
e sorella di Zeus, sua sorella, certo. Si accontenta
di un'avventura, penso, di poco conto è l'offesa al nostro amore.
No, è incinta! Questo ci mancava! che col suo ventre pregno
la colpa rivelasse, cercando grazie a Zeus d'essere madre,
ciò che a stento mi è toccato, tanto confida nella sua bellezza!
Farò che l'inganni: non sono figlia di Crono, se nelle acque
dello Stige non finirà travolta proprio dal suo Zeus!".
Detto questo, si alza dal trono e, nascosta da una nuvola fulva,
si reca a casa di Semele. Qui scioglie la nube, ma non prima
d'avere assunto l'aspetto di una vecchia, incanutendo le tempie,
solcando la pelle di rughe e trascinando con passo tremante
le membra incurvate; rende senile anche la voce,
ed è Beroe di Epidauro, la nutrice di Semele in persona.
Così attacca discorso, e quando dopo lunghe chiacchiere si arriva
a nominare Zeus, sospira e: "Ti auguro", dice,
"che sia proprio Zeus, ma io sospetto di tutto: spacciandosi
per dei, troppi uomini sono entrati in letti onesti.
E non basta che per te sia Zeus: ti dia una prova del suo amore,
se è vero amore; chiedigli che, grande e splendido
come l'accoglie l'eccelsa Era, grande e splendido così
ti stringa a sé, assumendo prima le sue insegne!".
Con queste parole sobilla Era l'ignara figlia
di Cadmo; e questa chiede a Zeus un dono senza nominarlo.
"Scegli," le risponde il dio; "nulla ti rifiuterò;
e perché tu più mi creda, sia testimone la divinità
del fiume infernale, un dio che anche agli dei incute paura!"
Lieta a proprio danno, eccitata di potere, sul punto di perdersi
per compiacenza dell'amante, Semele: "Come ti abbraccia
la figlia di Crono, quando vi disponete ai giochi d'amore,
così concediti a me!" chiede. Avrebbe voluto il dio, mentre parla,
tapparle la bocca, ma ormai via nell'aria era volata la voce.
Gemette: più non può far sì che non abbia lei chiesto
e lui giurato. E allora tristissimo sale in alto
nel cielo e con uno sguardo raduna docili
le nubi e vi aggiunge uragani e in mezzo ai venti
lampi, tuoni e il fulmine al quale non si sfugge.
Ma, per quanto può, cerca di velare le sue forze;
così non si arma del fuoco con cui aveva abbattuto Tifone,
il gigante dalle cento braccia: troppa ferocia v'era in quello.
C'è un altro fulmine più fioco, nel quale la mano dei Ciclopi
ha infuso meno furia e fuoco, meno rabbia:
gli dei lo chiamano fulmine secondo; lo prende ed entra
nella casa di Agenore. Donna mortale non sopporta
assalto celeste e quel dono nuziale la incenerì.
Ancora in embrione il piccolo viene estratto dal ventre
della madre e tenero com'è viene cucito, se devo crederlo,
in una coscia del padre per compiere la gestazione.
Di nascosto Ino, la zia materna, lo alleva nei primi mesi,
quelli di culla, poi lo affida alle ninfe di Nisa
che lo nascondono nelle loro grotte, nutrendolo di latte.
Mentre in terra avvenivano per volere del fato queste cose
e l'infanzia di Dioniso, tornato a nascere, scorreva tranquilla,
si racconta che, reso espansivo dal nettare, per caso Zeus
bandisse i suoi assilli, mettendosi piacevolmente a scherzare
con la sorridente Era. "Il piacere che provate voi donne",
le disse, "è certamente maggiore di quello che provano i maschi."
Lei contesta. Decisero di sentire allora il parere
di Tiresia, che per pratica conosceva l'uno e l'altro amore.
Con un colpo di bastone aveva infatti interrotto
in una selva verdeggiante il connubio di due grossi serpenti,
e divenuto per miracolo da uomo femmina, rimase
tale per sette autunni. All'ottavo rivedendoli nuovamente:
"Se il colpirvi ha tanto potere di cambiare", disse,
"nel suo contrario la natura di chi vi colpisce,
vi batterò ancora!". E percossi un'altra volta quei serpenti,
gli tornò il primitivo aspetto, la figura con cui era nato.
E costui, scelto come arbitro in quella divertente contesa,
conferma la tesi di Zeus. Più del giusto e del dovuto al caso,
a quanto si dice, s'impermalì la figlia di Crono e gli occhi
di chi le aveva dato torto condannò a eterna tenebra.
Ma il padre onnipotente (giacché nessun dio può annullare
ciò che un altro dio ha fatto), in cambio della vista perduta,
gli diede scienza del futuro, alleviando la pena con l'onore.
Così, diventato famosissimo nelle città dell'Aonia,
Tiresia dava responsi inconfutabili a chi lo consultava.
La prima a saggiare l'autenticità delle sue parole
fu l'azzurra Liriope, che Cefiso un giorno aveva spinto
in un'ansa della sua corrente, imprigionato fra le onde
e violentato. Rimasta incinta, la bellissima ninfa
partorì un bambino che sin dalla nascita suscitava amore,
e lo chiamò Narciso. Interrogato se il piccolo avrebbe visto
i giorni lontani di una tarda vecchiaia, l'indovino
aveva risposto: "Se non conoscerà sé stesso".
A lungo la predizione sembrò priva di senso, ma poi l'esito
delle cose, il tipo di morte e la strana follia la confermarono.
Di un anno aveva ormai superato i quindici il figlio di Cefiso
e poteva sembrare tanto un fanciullo che un giovane:
più di un giovane, più di una fanciulla lo desiderava,
ma in quella tenera bellezza v'era una superbia così ingrata,
che nessun giovane, nessuna fanciulla mai lo toccò.
Mentre spaventava i cervi per spingerli dentro le reti,
lo vide quella ninfa canora, che non sa tacere se parli,
ma nemmeno sa parlare per prima: Eco che ripete i suoni.
Allora aveva un corpo, non era voce soltanto; ma come ora,
benché loquace, non diversamente usava la sua bocca,
non riuscendo a rimandare di molte parole che le ultime.
Questo si doveva a Era, perché tutte le volte che avrebbe
potuto sorprendere sui monti le ninfe stese in braccio a Zeus,
quella astutamente la tratteneva con lunghi discorsi
per dar modo alle ninfe di fuggire. Quando la dea se ne accorse:
"Di questa lingua che mi ha ingannato", disse, "potrai disporre
solo in parte: ridottissimo sarà l'uso che tu potrai farne".
E coi fatti confermò le minacce: solo a fine di un discorso
Eco duplica i suoni ripetendo le parole che ha udito.
Ora, quando vide Narciso vagare in campagne fuori mano,
Eco se ne infiammò e ne seguì le orme di nascosto;
e quanto più lo segue, tanto più vicino alla fiamma si brucia,
come lo zolfo che, spalmato in cima ad una fiaccola,
in un attimo divampa se si accosta alla fiamma.
Oh quante volte avrebbe voluto affrontarlo con dolci parole
e rivolgergli tenere preghiere! Natura lo vieta,
non le permette di tentare; ma, e questo le è permesso, sta pronta
ad afferrare i suoni, per rimandargli le sue stesse parole.
Per caso il fanciullo, separatosi dai suoi fedeli compagni,
aveva urlato: "C'è qualcuno?" ed Eco: "Qualcuno" risponde.
Stupito, lui cerca con gli occhi in tutti i luoghi,
grida a gran voce: "Vieni!"; e lei chiama chi l'ha chiamata.
Intorno si guarda, ma non mostrandosi nessuno: "Perché", chiede,
"mi sfuggi?", e quante parole dice altrettante ne ottiene in risposta.
Insiste e, ingannato dal rimbalzare della voce:
"Qui riuniamoci!" esclama, ed Eco che a nessun invito
mai risponderebbe più volentieri: "Uniamoci!" ripete.
E decisa a far quel che dice, uscendo dal bosco, gli viene incontro
per gettargli, come sogna, le braccia al collo.
Lui fugge e fuggendo: "Togli queste mani, non abbracciarmi!"
grida. "Possa piuttosto morire che darmi a te!".
E lei nient'altro risponde che: "Darmi a te!".
Respinta, si nasconde Eco nei boschi, coprendosi di foglie
per la vergogna il volto, e da allora vive in antri sperduti.
Ma l'amore è confitto in lei e cresce col dolore del rifiuto:
un tormento incessante le estenua sino alla pietà il corpo,
la magrezza le raggrinza la pelle e tutti gli umori del corpo
si dissolvono nell'aria. Non restano che voce e ossa:
la voce esiste ancora; le ossa, dicono, si mutarono in pietre.
E da allora sta celata nei boschi, mai più è apparsa sui monti;
ma dovunque puoi sentirla: è il suono, che vive in lei.
Così di lei, così d'altre ninfe nate in mezzo alle onde o sui monti
s'era beffato Narciso, come prima d'una folla di giovani.
Finché una vittima del suo disprezzo non levò al cielo le mani:
"Che possa innamorarsi anche lui e non possedere chi ama!".
Così disse, e la dea di Ramnunte assentì a quella giusta preghiera.
C'era una fonte limpida, dalle acque argentee e trasparenti,
che mai pastori, caprette portate al pascolo sui monti
o altro bestiame avevano toccato, che nessun uccello, fiera
o ramo staccatosi da un albero aveva intorbidita.
Intorno c'era un prato, che la linfa vicina nutriva,
e un bosco che mai avrebbe permesso al sole di scaldare il luogo.
Qui il ragazzo, spossato dalle fatiche della caccia e dal caldo,
venne a sdraiarsi, attratto dalla bellezza del posto e dalla fonte,
ma, mentre cerca di calmare la sete, un'altra sete gli nasce:
rapito nel porsi a bere dall'immagine che vede riflessa,
s'innamora d'una chimera: corpo crede ciò che solo è ombra.
Attonito fissa sé stesso e senza riuscire a staccarne gli occhi
rimane impietrito come una statua scolpita in marmo di Paro.
Disteso a terra, contempla quelle due stelle che sono i suoi occhi,
i capelli degni di Dioniso, degni persino di Apollo,
e le guance lisce, il collo d'avorio, la bellezza
della bocca, il rosa soffuso sul niveo candore,
e tutto quanto ammira è ciò che rende lui meraviglioso.
Desidera, ignorandolo, sé stesso, amante e oggetto amato,
mentre brama, si brama, e insieme accende ed arde.
Quante volte lancia inutili baci alla finzione della fonte!
Quante volte immerge in acqua le braccia per gettarle
intorno al collo che vede e che in acqua non si afferra!
Ignora ciò che vede, ma quel che vede l'infiamma
e proprio l'illusione che l'inganna eccita i suoi occhi.
Ingenuo, perché t'illudi d'afferrare un'immagine che fugge?
Ciò che brami non esiste; ciò che ami, se ti volti, lo perdi!
Quella che scorgi non è che il fantasma di una figura riflessa:
nulla ha di suo; con te venne e con te rimane;
con te se ne andrebbe, se ad andartene tu riuscissi.
Ma né il bisogno di cibo o il bisogno di riposo
riescono a staccarlo di lì: disteso sull'erba velata d'ombra,
fissa con sguardo insaziabile quella forma che l'inganna
e si strugge, vittima dei suoi occhi. Poi sollevandosi un poco,
tende le braccia a quel bosco che lo circonda e dice:
"Esiste mai amante, o selve, che abbia più crudelmente sofferto?
Voi certo lo sapete, voi che a tanti offriste in soccorso un rifugio.
Ricordate nella vostra lunga esistenza, quanti sono i secoli
che si trascina, qualcuno che si sia ridotto così?
Mi piace, lo vedo; ma ciò che vedo e che mi piace
non riesco a raggiungerlo: tanto mi confonde amore.
E a mio maggior dolore, non ci separa l'immensità del mare,
o strade, monti, bastioni con le porte sbarrate:
un velo d'acqua ci divide! E lui, sì, vorrebbe donarsi:
ogni volta che accosto i miei baci allo specchio d'acqua,
verso di me ogni volta si protende offrendomi la bocca.
Diresti che si può toccare; un nulla, sì, si oppone al nostro amore.
Chiunque tu sia, qui vieni! Perché m'illudi, fanciullo senza uguali?
Dove vai quand'io ti cerco? E sì che la mia bellezza e la mia età
non sono da fuggire: anche delle ninfe mi hanno amato.
Con sguardo amico mi lasci sperare non so cosa;
quando ti tendo le braccia, subito le tendi anche tu;
quando sorrido, ricambi il sorriso; e ti ho visto persino piangere,
quando io piango; con un cenno rispondi ai miei segnali
e a quel che posso arguire dai movimenti della bella bocca,
mi ricambi parole che non giungono alle mie orecchie.
Io, sono io! l'ho capito, l'immagine mia non m'inganna più!
Per me stesso brucio d'amore, accendo e subisco la fiamma!
Che fare? Essere implorato o implorare? E poi cosa implorare?
Ciò che desidero è in me: un tesoro che mi rende impotente.
Oh potessi staccarmi dal mio corpo!
Voto inaudito per gli amanti: voler distante chi amiamo!
Ormai il dolore mi toglie le forze, e non mi resta
da vivere più di tanto: mi spengo nel fiore degli anni.
No, grave non mi è la morte, se con lei avrà fine il mio dolore;
solo vorrei che vivesse più a lungo lui, che tanto ho caro.
Ma, il cuore unito in un'anima sola, noi due ora moriremo".
Dice, e delirando torna a contemplare quella figura,
e con le sue lacrime sconvolge lo specchio d'acqua,
che increspandosi ne offusca lo splendore. Vedendola svanire:
"Dove fuggi?" esclama. "Fèrmati, infame, non abbandonare
chi ti ama! Se non posso toccarti, mi sia permesso almeno
di guardarti e nutrire così l'infelice mia passione!".
In mezzo ai lamenti, dall'orlo in alto lacera la veste
e con le palme bianche come il marmo si percuote il petto nudo.
Ai colpi il petto si colora di un tenue rossore,
come accade alla mela che, candida su una faccia,
si accende di rosso sull'altra, o come all'uva
che in grappoli cangianti si vela di porpora quando matura.
Specchiandosi nell'acqua tornata di nuovo limpida,
non resiste più e, come cera bionda al brillio
di una fiammella o la brina del mattino al tepore
del sole si sciolgono, così, sfinito d'amore,
si strugge e un fuoco occulto a poco a poco lo consuma.
Del suo colorito rosa misto al candore ormai non v'è più traccia,
né del fuoco, delle forze, di ciò che prima incantava la vista,
e nemmeno il corpo è più quello che Eco aveva amato un tempo.
Ma quando lei lo vide così, malgrado la collera al ricordo,
si addolora e ogni volta che l'infelice mormora 'Ahimè',
rimandandogli la voce ripete 'Ahimè',
e quando il ragazzo con le mani si percuote le braccia,
replica lo stesso suono, quello delle percosse.
Le ultime sue parole, mentre fissava l'acqua una volta ancora,
furono: "Ahimè, fanciullo amato invano", e le stesse parole
gli rimandò il luogo; e quando disse 'Addio', Eco 'Addio' disse.
Poi reclinò il suo capo stanco sull'erba verde e la morte chiuse
quegli occhi incantati sulle fattezze del loro padrone.
E anche quando fu accolto negli Ínferi, mai smise di contemplarsi
nelle acque dello Stige. Un lungo lamento levarono le Naiadi
sue sorelle, offrendogli le chiome recise;
un lungo lamento le Driadi, ed Eco unì la sua voce alla loro.
Già approntavano il rogo, le fiaccole da agitare e il feretro:
il corpo era scomparso; al posto suo scorsero un fiore,
giallo nel mezzo e tutto circondato di petali bianchi.
La notizia di queste vicende accrebbe la fama di Tiresia
in tutte le città dell'Acaia e grande divenne il suo prestigio.
Unico e solo, Penteo, figlio di Echione, miscredente incallito,
disprezza il vecchio e si beffa dei suoi presagi,
rinfacciandogli le tenebre in cui vive per la sventura
d'aver perso la vista. Scuotendo le tempie bianche di canizie:
"Che fortuna, se anche tu fossi privato di questa luce",
gli ribatte il vate: "non vedresti i sacri riti di Dioniso.
Verrà giorno infatti, e prevedo non lontano,
che qui giungerà inaspettato Libero, il figlio di Semele,
e se tu degno non lo riterrai dell'onore dei templi,
dilaniato sarai disperso in mille parti, macchiando di sangue
le foreste, tua madre e le sorelle di tua madre.
Avverrà, perché degno d'onore non stimerai quel nume,
e allora ti lagnerai che in queste tenebre io abbia visto troppo".
Ancora stava parlando che il figlio di Echione lo caccia.
Ma alle parole seguono i fatti e s'avverano le profezie.
Libero arriva e un delirio di gioia prorompe nei campi:
la folla si accalca, insieme agli uomini madri e spose,
popolo e dignitari, tutti accorrono a quei riti sconosciuti.
"Che pazzia vi ha sconvolto la mente, figli di serpe,
progenie di Ares?" grida Penteo. "Tanto potere ha dunque
il bronzo percosso dal bronzo, il flauto a becco curvo,
il sortilegio della magia, che persone avvezze a non temere
spade, trombe di guerra o schiere con la lancia in pugno,
si lascino vincere da strepiti di femmine, dal delirio
del vino, da masnade oscene e sciocchi tamburelli?
Di chi stupirsi? Di voi, vecchi, che dopo avere a lungo vagato
sui mari, qui avete insediato Tiro, qui i vostri penati in fuga,
e ora vi piegate senza colpo ferire? O di voi, giovani,
in età più acerba e più vicina alla mia, che dovreste impugnare
armi e non tirsi, cingere elmi e non ghirlande di fiori?
Memori siate, vi prego, della stirpe che vi ha dato i natali,
ritrovate la fierezza di quel serpente che da solo
tanti sconfisse! e che morì per la sua sorgente, per il suo lago:
in nome della vostra fama vincere dovete!
Lui diede morte a prodi, cacciate voi questi rammolliti
e salvate l'onore della patria! Se era intenzione del fato
che Tebe non vivesse a lungo, oh fossero almeno ordigni di guerra
o eroi ad abbatterne le mura in un fragore di ferro e fuoco!
Sventurati saremmo, ma senza colpa; da piangere o celare
nostra sorte non sarebbe e mai nelle lacrime vergogna.
Ora invece Tebe sarà espugnata da un fanciullo inerme,
che non ama guerre, armi o pratica di cavalli,
ma capelli impregnati di mirra, carezza di ghirlande
e vesti color porpora a ricami d'oro.
Ma, se mi fate largo, lo costringerò in un lampo a confessare
che sono un'impostura l'attribuzione del padre e questi riti.
Se Acrisio ha avuto il coraggio di disprezzare
un nume sospetto e di sbarrargli in faccia le porte di Argo,
Penteo con tutta Tebe si lascerà spaventare da un intruso?
Avanti, andate," ordina ai suoi servi, "andate e qui in catene
trascinatemi quel demagogo! Obbedite e senza indugi!".
Lo stesso nonno, lo stesso Atamante e tutti gli altri suoi congiunti
lo rimproverano e invano si sforzano di trattenerlo.
Gli ammonimenti lo incattiviscono e la rabbia repressa
si esaspera e cresce; la critica gli brucia:
così ho visto torrenti che scorrevano quieti, senza troppo
fragore, dove nulla si opponeva al loro corso,
farsi violenti di fronte agli ostacoli, tra spuma e mulinelli,
nei punti in cui li imbrigliavano tronchi o barriere di massi.
Tornano intanto i servi insanguinati e alla richiesta del signore
dove fosse Dioniso, rispondono di non averlo visto; e aggiungono:
"Però abbiamo preso questo suo seguace che officiava",
e spingono avanti un uomo con le mani legate sulla schiena,
un etrusco che si era votato alla religione di quel nume.
Penteo lo squadra con occhi che l'ira rende spaventosi
e benché a stento si rassegni a differire l'ora del supplizio:
"Tu, che stai per morire e che con la tua morte servirai d'esempio
agli altri," grida, "dimmi il nome tuo, il nome dei genitori,
la tua patria e perché segui questi riti di nuova istituzione".
Senza alcun timore quello risponde: "Il nome mio è Acete,
mia patria è la Meonia, povera gente i miei genitori.
Mio padre non mi ha lasciato campi da lavorare a forza
di buoi, non mi ha lasciato greggi da lana e neppure armenti:
povero com'era, s'ingegnava ad adescare col filo e l'amo
qualche pesce che guizzava in acqua e a tirarlo su con la sua canna.
Quell'espediente era tutta la sua ricchezza; tramandandomelo
mi disse: "Prenditi, erede mio che mi succedi in questo lavoro,
i beni che ho", e morendo non mi lasciò nient'altro che distese
d'acqua: questa posso dire è la sola eredità paterna.
Ora io, per non rimanere sempre legato agli stessi scogli,
mi sono addestrato a governare il timone di un'imbarcazione
con mano ferma, a riconoscere le stelle che recano pioggia
della Capra Olenia, la stella Taigete, le Iadi e l'Orsa,
le case dei venti e i porti adatti alle navi.
Per caso, diretto a Delo, avvisto le sponde
dell'isola di Chio, accosto coi remi di destra
e con un agile balzo mi lancio sull'umida rena.
Passata lì la notte, quando appena l'aurora comincia
a rosseggiare, mi levo e dispongo che si attinga
acqua fresca, mostrando il sentiero che conduce alla fonte.
Io rimango a scrutare da un'altura cosa mi prometta
il vento, poi richiamo i compagni e torno alla nave.
"Eccoci qui!" grida Ofelte venendo avanti a tutti,
e trascina per la spiaggia un fanciullo che pare una vergine,
una preda, così dice, trovata in un campo deserto.
Quello sembra barcollare, come stordito dal vino o dal sonno,
e seguirlo a fatica. Io ne osservo la foggia, l'aspetto e l'incedere:
nulla gli vedo che possa attribuirsi a un mortale.
Lo sento e dico ai compagni: "Non so quale nume si celi
in questo corpo, ma in questo corpo si cela un nume.
Chiunque tu sia, aiutaci, ti prego, e proteggi il nostro travaglio!
e anche costoro perdona!". "Per noi puoi risparmiarti di pregare",
obietta Dictis, che non aveva rivali nell'arrampicarsi
in cima a un pennone e nel scivolare giù avvinghiato a una fune.
Gli dà ragione Libis, il biondo Melanto di vedetta a prua,
ragione Alcimedonte ed Epopeo, capo dell'equipaggio,
che con la voce scandiva le pause e il ritmo della voga;
tutti gli danno ragione, tanto la preda li acceca di voglia.
"Ma io non permetterò che per la presenza di un essere sacro
questo legno abbia danno", grido: "chi comanda qui son io!";
e mi pianto a sbarrare l'accesso. Chi s'infuria con più arroganza
è Licabas: cacciato da una città dell'Etruria,
scontava con l'esilio la pena per un orribile delitto.
Mentre lo fronteggio, lui vibrando un pugno mi sfonda
la gola, e con quel colpo m'avrebbe scaraventato in acqua,
se non mi fossi aggrappato per salvarmi, mezzo morto, a una fune.
Quella masnada applaude alla prodezza. Quand'ecco che Dioniso
(perché proprio Dioniso era), come se il chiasso l'avesse destato
dal torpore o, sfumata l'ebbrezza, tornasse in sé:
"Che fate? Cos'è questo chiasso?" chiede. "Dite, marinai,
come mai mi trovo qui? Dove volete portarmi?".
"Non aver paura," risponde Proreo, "di' in quale porto desideri
arrivare: sarai sbarcato nella terra che vorrai."
"Fate rotta su Nasso", dice allora Dioniso.
"Quella è la patria mia, terra che vi sarà ospitale."
Quegli impostori giurano sul mare e su tutti gli dei
che così sarà fatto e m'impongono di dar vela alla mia nave.
Nasso era a destra, e io piego le vele per andare a destra:
"Che fai, pazzo? hai perso la testa?" mi rimbrotta Ofelte.
Ognuno è in ansia per sé. "Va' a sinistra!" mi fanno capire i più
coi gesti, e gli altri sussurrandomi all'orecchio ciò che vogliono.
Allibisco: "Prenda il timone qualcun altro!" sbotto,
sottraendomi al rischio di compiere un misfatto con le mie arti.
M'inveiscono tutti contro, brontola l'intera ciurma;
fra loro poi Etalione sbraita: "Credi proprio che da te solo
dipenda la sicurezza di tutti noi?" e facendosi avanti
prende il mio posto, lascia perdere Nasso e punta su un'altra rotta.
Allora il dio, schernendoli come se solo in quell'attimo avesse
compreso l'inganno, dal ponte di poppa guarda il mare e facendo
finta di piangere: "Non è questa, marinai," protesta, "la costa
che m'avevate promesso, non è questa la terra che chiedevo.
Che ho fatto per meritarmi questo? Che prodezza è la vostra
a ingannare, maturi come siete, un bambino, in tanti uno solo?".
Da un pezzo io piangevo: quella banda di scellerati sbeffeggia
le nostre lacrime e accelera il battito dei remi in acqua.
Ora io ti giuro per quel dio (perché nessun dio più di lui
è presente fra noi) che quanto ti racconto è vero,
anche se supera l'onore del vero: s'arresta in mezzo al mare
la nave, proprio come se la tenesse in secco un cantiere.
Sorpresi, quelli insistono a battere i remi,
spiegano le vele e con entrambi i mezzi tentano di procedere.
Radici d'edera inceppano i remi e serpeggiando in un intrico
di volute vanno a ornare le vele con dovizia di corimbi.
E il nume, con la fronte incoronata di grappoli d'uva,
agita un'asta tutta fasciata di pampini;
intorno gli si accucciano apparizioni spettrali: tigri,
linci e figure selvagge di pantere screziate.
Balzano gli uomini in piedi per un accesso di follia
o di terrore; e per primo Medonte inizia a farsi nero
lungo il corpo e a incurvarsi: a vista d'occhio la spina dorsale
gli s'inarcava. E Licabas gli dice: "In quale mostro
ti stai mutando?", ma mentre parla la bocca gli si allarga, il naso
gli si incurva e la pelle indurita gli si copre di squame.
Libis, mentre cerca di sbloccare i remi impigliati,
vede contrarsi e ritrarsi le mani, mani
che ormai più tali non sono e già pinne possono chiamarsi;
un altro, volendo allungare le braccia sui grovigli di funi,
si ritrova senza braccia e inarcando quel corpo amputato
si getta in acqua: all'estremità vibra una coda falcata,
come la curva che formano le corna della luna nascente.
E da ogni parte si tuffano, sollevando grandi spruzzi,
riemergono per poi tornare ogni volta sott'acqua,
intrecciano una sorta di danza, dimenando con voluttà
i loro corpi, e dalle larghe nari sbuffano l'acqua aspirata.
Di venti che eravamo (tanti ne portava quella nave)
restavo io, io solo: gelato dallo spavento, con un tremito
in tutto il corpo, quasi incosciente, mi conforta il nume, mi dice:
"Scaccia dal cuore la paura: in rotta per Dia!". Lì sbarcato,
aderisco al culto di Dioniso e da quel giorno ne celebro i riti".
"Abbiamo prestato orecchio alle tue fole", gli ribatte Penteo,
"tirate in lungo perché la mia ira potesse intanto sbollire.
Avanti, servi, portatelo via, straziatene le carni
con torture atroci e speditelo nelle tenebre dello Stige!".
Subito trascinato via, l'etrusco Acete viene chiuso in carcere,
ma mentre si preparano, come ordinato, gli strumenti
di tortura per ucciderlo, il ferro e il fuoco,
si narra che da sé si spalancassero le porte, che da sé
gli cadessero i ceppi dai polsi, senza che alcuno li sciogliesse.
Si ostina il figlio di Echione, ma va di persona, non manda altri
nel luogo scelto per celebrare i riti, sul Citerone
dove risuonano i canti e le voci squillanti delle baccanti.
Come un cavallo focoso, quando la tromba scatena l'attacco
con gli squilli del bronzo, freme e smania di combattere,
così Penteo da quei lunghi ululati che scuotono l'aria
è sconvolto e a udire quel clamore riavvampa d'ira.
Quasi a metà del monte, circondata ai margini dal bosco,
c'è una radura sgombra d'alberi dove la vista spazia libera.
Qui, mentre con occhi sacrileghi osserva la cerimonia,
la prima a scorgerlo, la prima ad avventarglisi contro con furia,
la prima a sfregiare il suo Penteo scagliandogli il tirso,
è la madre. "O sorelle, gemelle mie, accorrete!", urlava,
"quel cinghiale enorme che si aggira nei nostri campi, quello,
quello io devo uccidere!". Tutto contro gli si lancia quel branco
inferocito: ammassandosi insieme, tutte lo inseguono e lui
trepida, trepida ormai, usa un linguaggio meno violento ormai,
ormai condanna sé stesso, ormai riconosce l'errore commesso.
Colpito malgrado questo: "Aiutami, Autonoe, aiutami zia!",
grida. "Pietà, abbi pietà almeno per l'ombra di Atteone!".
Ma lei non sa più chi sia Atteone e, mentre la scongiura, gli tronca
il braccio destro; l'altro da un colpo di Ino gli è strappato.
Braccia non ha più lo sventurato da tendere alla madre
e allora mostrandole le piaghe aperte dalle membra mozzate:
"Guarda, madre mia, guarda!" grida. A quella vista Agave
lancia un urlo, squassa la testa agitando nell'aria i suoi capelli,
poi gli svelle il capo e, stringendolo tra le mani lorde di sangue,
esclama: "Compagne, compagne, opera nostra è questa vittoria!".
Non più in fretta il vento strappa dalla cima degli alberi le foglie
battute dal freddo d'autunno e ormai appese a un filo,
di come son disperse le sue membra da quelle mani nefande.
Ammonite da un tale esempio, seguono le donne dell'Ismeno
il nuovo culto e offrendo incenso ne consacrano gli altari.