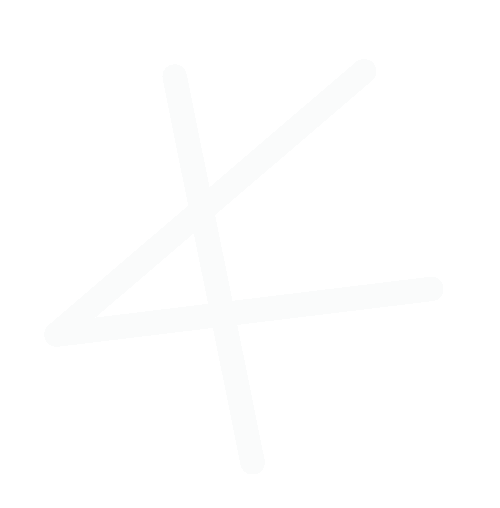Biblioteca:Luciano, Una Storia Vera, Libro II
Da quel momento in poi, dato che non riuscivo più a sopportare la vita dentro la balena ed ero esasperato per quella permanenza forzata, non facevo che cercare qualche via di fuga. Prima decidemmo di metterci a scavare nel fianco destro del mostro e di scappare da quella parte; e cominciammo ad aprire una breccia ma, dopo essere andati avanti per circa cinque stadi senza risultato, desistemmo, prendendo invece la risoluzione di incendiare il bosco: così la balena sarebbe morta e in questo caso per noi sarebbe stato facile evadere. Appiccammo il fuoco a cominciare dalla coda; per sette giorni e altrettante notti la balena non si accorse di bruciare, all'ottavo e nono giorno ci rendemmo conto che soffriva perché apriva la bocca più stancamente e la richiudeva subito, al decimo e all'undicesimo era ormai decisamente in agonia e mandava cattivo odore; al dodicesimo ci venne in mente, appena in tempo, che se non le avessimo puntellato le mascelle finché aveva la bocca aperta, in modo che non potesse più richiuderla, avremmo rischiato di rimanere prigionieri nella carcassa e di morire. E così conficcammo dei grossi pali a sostegno della volta del palato, e rimettemmo la nave in condizioni di navigare, rifornendola della maggior quantità possibile di acqua e di quant'altro necessario; Scintaro l'avrebbe pilotata.
Il giorno dopo, la balena - finalmente - era morta. Allora trainammo fuori la nave, facendola passare attraverso gli interstizi tra un dente e l'altro, e, calandola con delle funi fissate ai denti stessi, la deponemmo con cautela, dolcemente, sulla superficie del mare. Saliti poi sul dorso del cetaceo e offerto un sacrificio a Poseidone lì vicino al trofeo, restammo fermi per tre giorni - era bonaccia - e al quarto riuscimmo a salpare. Nelle acque circostanti ci capitò di urtare - e di... arenarci - contro molti cadaveri dei guerrieri caduti durante la battaglia navale, e, constatando le dimensioni di quei corpi, restammo strabiliati. Navigavamo da qualche giorno in un clima temperato ma poi, sotto le raffiche di una violenta tramontana, venne un freddo terribile, tanto che il mare gelò tutto, non soltanto in superficie ma fino a circa trecento braccia di profondità: e così, sbarcati, ci mettemmo a scorrazzare sul ghiaccio. Siccome però il vento durava, e noi non eravamo in grado di resistere a quelle temperature, escogitammo questo stratagemma - fu Scintaro, per la verità, a lanciare l'idea -: scavata un'enorme caverna nel ghiaccio, rimanemmo lì dentro al riparo per trenta giorni, riattizzando il fuoco di continuo, e nutrendoci dei pesci che trovavamo scavando nel mare gelato. Ma quando i viveri furono esauriti, usciti dal nostro rifugio, disincagliammo la nave prigioniera dei ghiacci, e spiegammo le vele: così scivolando con estrema facilità sulla superficie levigata del ghiaccio, filavamo come se navigassimo. Dopo quattro giorni tornò il caldo, cominciò il disgelo e a poco a poco tutto ridivenne acqua.
Percorse circa trecento miglia, approdammo a un'isola minuscola e deserta, da cui subito ripartimmo dopo esserci riforniti di acqua - ormai non ne avevamo più - e aver abbattuto con l'arco e le frecce due tori selvaggi, che non avevano le corna sulla testa, ma sotto gli occhi, come sarebbe piaciuto a Momo. Non molto più tardi entravamo in un mare non di acqua ma di latte, in mezzo a cui si poteva distinguere un'isola candida ricoperta di vigneti. L'isola non era altro che un mastodontico formaggio ben rappreso - ce ne rendemmo conto più tardi dopo averla assaggiata - e misurava venticinque stadi di circonferenza; le viti, poi, erano cariche di grappoli: pigiandoli, però, ne ricavammo come bevanda non vino ma latte. Al centro dell'isola si ergeva un santuario dedicato alla Nereidi Galatea, come segnalava l'iscrizione. Per tutto il tempo in cui ci fermammo laggiù, il suolo stesso ci serviva da pane e companatico; per bere avevamo il latte delle viti. La regina di quei luoghi - dicevano - era Tiro, figlia di Salmoneo, a cui Poseidone aveva riservato tale onore dopo che ebbe lasciato il nostro mondo.
La sosta nell'isola durò cinque giorni, al sesto salpammo: ci spingeva una brezza leggera sul mare liscio come l'olio. All'ottavo giorno, mentre veleggiavamo non più nel latte, ma ormai in un'acqua salata e azzurrissima, vediamo correre sulla superficie del mare una folla di uomini in tutto e per tutto identici a noi, nella conformazione fisica e nella statura, salvo che nei piedi: li avevano di sughero, e proprio per questo, suppongo, erano chiamati Sugherópodi. Constatammo strabiliati che non andavano a fondo, ma rimanevano a galla sulla cresta delle onde e camminavano tranquillamente; alcuni ci vennero anche incontro, salutandoci in greco; ci raccontarono ch'erano in cammino, e piuttosto di fretta, alla volta di Sugherónia, la loro patria. Fino a un certo punto ci accompagnarono, correndo a fianco della nave, poi però si allontanarono dalla nostra rotta e, dopo averci augurato buon viaggio, se ne andarono per la loro strada. Poco più avanti, comparvero all'orizzonte parecchie isole; vicino, a sinistra, Sugherónia, la meta dei nostri amici, una città costruita su un sughero grosso e rotondo; lontano, più sulla destra, ce n'erano cinque vastissime e molto elevate, da cui si alzavano gigantesche lingue di fuoco. Di fronte alla prua ne avevamo, invece, una larga e bassa, distante non meno di cinquecento miglia.
Eravamo ormai vicini quando prese ad aleggiare intorno a noi una brezza meravigliosa, carezzevole e profumata, come quella che, secondo lo storico Erodoto, spira dalla Arabia felice. Il soave olezzo che giungeva alle nostre narici era come il profumo che emana da rose, e narcisi, e giacinti, e gigli, e viole, e ancora dal mirto, dall'alloro e dal fiore della vite. Estasiati da quelle fragranze e sperando in una migliore fortuna dopo tante disgrazie, ci accostavamo sempre più all'isola. Cominciammo allora a vedere, lungo tutta la costa, una quantità di insenature, ampie e ben riparate, e fiumi limpidissimi che sfociavano placidamente nel mare, e ancora prati e boschi e uccelli cinguettanti, che cantavano parte sulla spiaggia, molti pure sui rami degli alberi. Un'atmosfera delicata e pura circondava quella terra; dolci brezze, soffiando, scuotevano appena la selva, e così anche i rami smossi sussurravano una piacevole e ininterrotta melodia, simile a una musica di flauto in una landa solitaria. Si udiva inoltre un vociare confuso e indistinto, che non aveva nulla di inquietante, e somigliava invece al chiasso allegro di un banchetto, dove c'è gente che suona, altra che intona lodi e altra che batte il tempo al ritmo del flauto o della cetra.
Incantati da tutto questo, approdammo e, ormeggiata la nave, scendemmo a terra, lasciando a bordo Scintaro e due compagni. Mentre procedevamo attraverso un prato fiorito, incontriamo le sentinelle in giro di ronda che, dopo averci legati con ghirlande di rose - in quel paese è la catena più dura - ci portano davanti al governatore; durante la strada abbiamo saputo da loro che quella era l'Isola detta dei Beati e che il potere supremo lo deteneva il cretese Radamanto. Ci condussero appunto in sua presenza, e ci venne assegnato il quarto posto nella lista di coloro che erano in attesa di giudizio.
La prima causa riguardava Aiace Telamonio, se cioè gli spettasse di stare insieme agli eroi o no; lo si accusava di essere pazzo e di essersi tolto la vita. Alla fine, dopo lunghe discussioni, Radamanto sentenziò: per il momento sarebbe stato affidato alle cure del medico Ippocrate di Cos, perché si bevesse un po' di elleboro; poi, una volta rinsavito, avrebbe potuto prendere parte al banchetto.
Il secondo processo verteva su una questione amorosa: Teseo e Menelao erano in lite tra loro per stabilire con chi dei due dovesse convivere Elena. Radamanto decise che la tenesse con sé Menelao, in considerazione di tutte le fatiche sopportate e di tutti i rischi corsi per quel matrimonio; tanto più che Teseo aveva anche altre donne, l'Amazzone e le figlie di Minosse.
La terza era una causa su una questione di "precedenza" tra Alessandro, figlio di Filippo, e Annibale il Cartaginese: il verdetto fu in favore di Alessandro, a cui venne assegnato un bel trono a fianco di Ciro il Vecchio, il Persiano.
Come quarti ci presentammo noi, e il nostro giudice ci domandò in seguito a quali vicende fossimo approdati in quel sacro luogo ancora vivi; allora raccontammo, senza trascurare nessun particolare, la nostra storia. E così, dopo averci allontanato, esaminò per un bel pezzo il nostro caso, consultandosi anche con i suoi collaboratori, che erano molti, tra cui Aristide il Giusto, di Atene. Come ebbe presa la sua decisione, ci venne comunicata la sentenza: avremmo dovuto rendere conto dopo la morte della nostra eccessiva curiosità che ci aveva spinto a intraprendere quel viaggio; per il momento, comunque, ci potevamo fermare un certo periodo di tempo stabilito nell'Isola, vivendo insieme agli eroi, poi ce ne saremmo dovuti andare; la durata del nostro soggiorno venne fissata in non più di sette mesi.
Le catene di rose si sciolsero da sole e da quello stesso istante ci ritrovammo liberi; poi ci accompagnarono in città, al banchetto dei Beati. La città è tutta d'oro, le mura di cinta sono di smeraldo; ci sono sette porte di legno di cannella, ciascuna ricavata da un unico tronco; il selciato della città e l'intera zona all'interno delle mura è d'avorio; i templi di tutti gli dèi sono costruiti in berillo e hanno dentro altari enormi, monolitici, di ametista, riservati ai sacrifici solenni. Intorno alla città scorre un fiume di essenza odorosa, la migliore che esista, largo cento cubiti reali e profondo cinque, tanto che vi si può comodamente nuotare. Le loro terme sono alti edifici di cristallo, scaldati con il legno di cannella; nelle vasche da bagno invece dell'acqua mettono rugiada calda.
Usano come abiti ragnatele sottilissime color porpora.
I Beati non hanno corpo: sono impalpabili e senza carne, si presentano cioè soltanto come una forma visibile; però, pur senza corpo, hanno una loro consistenza, si muovono, pensano e parlano; insomma li potresti definire anime ridotte alla loro pura essenza che vagano rivestite da una parvenza di corpo, tanto è vero che uno, senza toccarli, non potrebbe accertare che quanto ha davanti agli occhi non sia appunto un corpo; sono come ombre che stanno dritte, ma non sono scure. Nessuno invecchia: rimangono della stessa età che hanno quando arrivano laggiù. Non esiste la notte, in quelle regioni, e neppure il giorno pieno; è diffusa perennemente su quella terra una luce simile al chiarore di quando l'aurora è ormai vicina, ma il sole non è ancora sorto. Conoscono pure una sola stagione dell'anno: è sempre primavera e soffia un solo vento, lo zefiro.
Il paese è ricco di ogni genere di fiori e di ogni genere di piante, e coltivate e che donano ombra. Le viti producono dodici volte all'anno, ossia danno frutto una volta al mese; il melograno, il melo e gli altri alberi, addirittura tredici volte all'anno - come mi hanno riferito - perché nel mese che loro chiamano di Minosse il raccolto è doppio. Le spighe poi, invece di chicchi di grano, producono in cima pagnotte bell'e pronte, e finiscono così per somigliare a dei funghi. Nei dintorni della città si trovano trecentosessantacinque sorgenti d'acqua, altrettante di miele, cinquecento di essenze profumate, più piccole, queste; per finire, sette fiumi di latte e otto di vino.
Il convito si tiene fuori della città, nei campi detti Elisi: si tratta di un prato bellissimo, circondato da un bosco fitto di alberi di ogni specie che riparano con la loro ombra i commensali, i quali stanno sdraiati su letti di fiori, mentre i venti servono le singole portate e fungono da valletti. Non versano il vino però, perché non è necessario: ci sono degli alberi intorno al luogo del banchetto, alti, di cristallo lucentissimo, i cui frutti sono coppe di svariate forme e dimensioni; quando uno va a tavola, raccoglie dai rami una o due coppe, se le pone davanti, al proprio posto, e queste subito si riempiono da sole di vino; e così bevono. Non si ornano di ghirlande: gli usignoli e gli altri uccelli canori, raccolgono con il becco dai prati vicini i fiori e li fanno piovere sui convitati, svolazzando sulle loro teste e cinguettando. Si profumano in questo modo: nuvole dense assorbono l'essenza odorosa dalle sorgenti e dal fiume, e stando sospese sul luogo del banchetto, per effetto di una leggera pressione da parte dei venti, stillano una specie di delicata rugiada.
Durante il banchetto si dedicano a musiche e canti: per lo più si declamano, con l'accompagnamento musicale, i versi di Omero, che è presente e prende parte alla comune baldoria, sdraiato a tavola alla destra di Ulisse. I cori, composti da ragazzi e ragazze, sono diretti e accompagnati da Eunomo di Locri, Arione di Lesbo, Anacreonte e Stesicoro. Vidi anche quest'ultimo, infatti, tra i Beati: Elena, evidentemente, s'era già riappacificata con lui. Quando smettono di cantare, li sostituisce un secondo coro di cigni, rondini e usignoli; e allora - all'echeggiare di questa nuova melodia - tutto il bosco li accompagna con un suono come di flauto, mentre i venti danno il la.
In ogni caso hanno un sistema infallibile per assicurarsi l'allegria: ci sono due sorgenti vicino al luogo del banchetto, l'una del riso, e l'altra del piacere; tutti, prima che inizi la festa, bevono a entrambe, e così per il tempo che segue ridono e sono felici.
Voglio anche nominare i personaggi celebri che ho avuto modo di incontrare laggiù: tutti i semidei e tutti gli eroi che combatterono a Troia, salvo Aiace di Locri, l'unico che - a quanto mi raccontarono - scontava la sua pena nel paese degli Empi: tra i non Greci, i due Ciri, lo scita Anacarsi, il tracio Zamolxis e l'italico Numa; poi lo spartano Licurgo, Focione e Tello ateniesi, e i savi, tranne Periandro. Vidi anche Socrate di Sofronisco che cianciava senza sosta con Nestore e Palamede: intorno a lui stavano lo spartano Giacinto, il tespiese Narciso, Ila e una quantità di altri bei giovani. Ebbi l'impressione che fosse innamorato di Giacinto: era l'interlocutore preferito delle sue «dimostrazioni». Anzi, Radamanto - dicevano - era seccato con lui e l'aveva minacciato più volte di cacciarlo dall'isola, se avesse continuato con le sue chiacchiere insulse, e se non avesse lasciato perdere l'«ironia» per divertirsi insieme agli altri. Soltanto Platone non c'era: secondo voci che circolavano, abitava nella città che si era inventata, dove viveva secondo la costituzione e le leggi che aveva personalmente redatto.
Aristippo, Epicuro e i loro seguaci laggiù godevano le maggiori simpatie, perché sono allegri, spiritosi e di compagnia. C'era anche Esopo di Frigia, che impiegano come buffone. Diogene di Sinope aveva talmente cambiato carattere da sposare la cortigiana Laide, e spesso, sotto l'effetto del vino, s'alzava, si metteva a ballare e si comportava in modo indecente. Non c'era nessuno degli Stoici, invece: si diceva che stessero ancora scalando l'erto monte della Virtù. Di Crisippo, poi, si mormorava che non gli era consentito mettere piede nell'Isola dei Beati prima di essersi sottoposto per la quarta volta al trattamento a base di elleboro. Gli Accademici - si diceva - sarebbero voluti venire, ma tenevano ancora in sospeso il giudizio e stavano tuttora esaminando la questione: non riuscivano neanche a capire se un'isola del genere esistesse; ma specialmente temevano - sospetto io - il verdetto di Radamanto, perché avevano distrutto essi stessi la norma per distinguere il vero dal falso. Secondo pettegolezzi, molti di loro si erano avviati al seguito della gente diretta qui, ma per pigrizia, data la loro incapacità congenita a raggiungere qualsiasi scopo, rimanevano indietro e a metà strada facevano dietro-front.
Questi dunque erano, tra i presenti, i personaggi degni di menzione. Riserbano grandi onori soprattutto ad Achille e, dopo di lui, a Teseo. Riguardo ai rapporti sessuali a all'amore, ecco come la pensano: si accoppiano alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti, sia con le donne che con i maschi, e non ritengono la cosa per nulla sconcia. Soltanto Socrate giurava sul suo onore di non avvicinarsi ai ragazzi con intenzioni meno che caste; e naturalmente tutti lo accusavano di giurare il falso, perché spesso Giacinto e Narciso confessavano, anche se lui continuava a negare. Le donne sono in comune fra tutti e nessuno è geloso del vicino: in questo, bisogna riconoscerlo, sono «ultraplatonicissimi»; anche i ragazzi si offrono a chi li desidera senza opporsi.
Non erano passati due o tre giorni che avvicinatomi al poeta Omero - né lui né io avevamo niente da fare - cominciai a tempestarlo di domande: in primis di dove fosse originario; gli spiegai che si trattava di una questione su cui, da noi, stavano ancora compiendo ricerche su ricerche. Neppure lui ignorava - mi rispose allora - che certuni lo ritenevano di Chio, altri di Smirne, i più di Colofone: era babilonese, invece; tra i suoi concittadini non veniva chiamato Omero, ma Tigrane: in seguito, inviato in Grecia come ostaggio, si era cambiato il nome. Gli chiesi poi se avesse scritto veramente lui certi versi ritenuti da espungere, e mi confermò che erano tutti autentici; per cui condannai come davvero eccessiva la pedanteria di Zenodoto e Aristarco e dei filologi loro seguaci. Soddisfatto delle risposte avute sull'argomento, gli domandai ancora perché mai avesse cominciato l'ILIADE dall'«ira» di Achille: mi disse che gli era venuto in mente così, non l'aveva studiato a bella posta. Morivo inoltre dalla voglia di sapere se avesse scritto prima l'Odissea dell'Iliade, come i più ritengono: e lo negò. Che poi non era nemmeno cieco - altra voce che circola sul suo conto - me ne sono accorto subito: ci vedeva, e così non ho avuto neppure bisogno di chiederglielo. Molte altre volte ci siamo intrattenuti a conversare, quando mi capitava di vederlo libero da impegni; mi avvicinavo rivolgendogli qualche domanda, e lui appagava volentieri ogni mia curiosità, specialmente dopo aver avuto la meglio nel processo: infatti Tersite aveva sporto contro di lui una querela per oltraggio, per la maniera in cui lo aveva schernito nel suo poema, e Omero vinse la causa con il patrocinio, per la difesa, di Ulisse.
Più o meno in quel periodo arrivò anche Pitagora di Samo, che dopo aver subito sette metamorfosi e aver vissuto in altrettanti animali, aveva finalmente terminato i cicli della sua anima: metà del suo corpo - la destra - era d'oro. Decisero che poteva coabitare con gli altri; l'unico dubbio era ancora se lo si dovesse chiamare Pitagora oppure Euforbo. Si presentò anche Empedocle, ben arrostito e cotto a dovere in tutto il corpo, ma non fu ammesso, nonostante le sue insistenze e le sue preghiere.
Col passare del tempo, venne l'epoca delle loro feste, le Funeraliadi. Gli organizzatori e arbitri erano Achille per la quinta volta, e Teseo per la settima. Sarebbe troppo lungo fare la cronaca completa di tutte le gare, perciò ricorderò soltanto gli avvenimenti principali. Carano, il discendente di Eracle, sceso in lizza per il titolo, vinse Ulisse nella lotta; nel pugilato, si concluse in parità l'incontro tra Ario l'Egiziano, che è sepolto a Corinto, ed Epeo; per il pancrazio non ci sono premi laggiù, e nella corsa non mi ricordo più chi sia arrivato primo. Tra i poeti, per la verità, era di gran lunga il migliore Omero, ma risultò ugualmente vincitore Esiodo. Per tutti il premio consisteva in una corona di piume di pavone.
I giochi, erano appena terminati quando venne comunicato che i prigionieri, rinchiusi a scontare la loro pena nel paese degli Empi, avevano spezzato le catene e, dopo aver sopraffatto le guardie, stavano muovendo all'assalto dell'Isola: li guidavano Falaride di Agrigento, Busiride l'Egiziano, Diomede tracio, Scirone e Piegapini. Come Radamanto udì la notizia, schierò gli eroi in ordine di battaglia sulla spiaggia, al comando di Teseo, Achille, e Aiace Telamonio ormai rinsavito: si scontrarono e si misero a combattere; la vittoria naturalmente arrise agli eroi, grazie al validissimo contributo di Achille. Si distinse per la verità anche Socrate, schierato all'ala destra, molto più di quando, da vivo, aveva combattuto a Delio: all'avvicinarsi di ben quattro nemici insieme non fuggì, e rimase imperturbabile; per questo, dopo, gli riservarono un premio al valore, un bel parco ampio nelle vicinanze della città, dove poteva invitare i suoi amici per discutere di filosofia. Chiamò quel luogo Mortaccademia.
Dopo aver radunati e ben legati i ribelli vinti, li rispedirono alla loro sede perché fossero puniti ancora più severamente. Omero scrisse un poema anche a ricordo di questa battaglia; e me ne aveva consegnata una copia, quando stavo per partire di là, perché la portassi tra gli uomini, sulla nostra terra: ma in seguito, purtroppo, ho perduto anche quella insieme a tutto il resto. Il poema iniziava: «Ed ora cantami, o Musa, la battaglia dei defunti eroi». In quella circostanza poi, bollite delle fave, come usa dalle loro parti quando si riporta la vittoria in una guerra, celebrarono con un lauto banchetto il trionfo, facendo gran festa. Pitagora, dato il suo orrore per i pasti a base di fave, fu il solo che non vi prese parte: se ne restò seduto in un angolo, senza toccare cibo.
Erano trascorsi sei mesi ormai, quando, a metà del settimo, si verifica un fatto inaspettato. Cinira, il figlio di Scintaro, un giovane alto e bello, già da un pezzo s'era innamorato di Elena e, quanto a lei, si vedeva lontano un miglio che era pazza d'amore per il ragazzo: spesso a tavola si scambiavano cenni d'intesa e brindisi, poi s'alzavano e andavano a passeggiare da soli nel bosco. Insomma un bel giorno, spinto da quel folle amore e dalla impossibilità di soddisfarlo, Cinira decise di rapire Elena - che era consenziente - e di scappare, rifugiandosi poi con lei in una delle isole vicine, magari a Sugheronia o a Formaggino. Avevano da tempo guadagnato alla loro causa, come complici, tre miei compagni - i più temerari. Naturalmente non rivelò il suo progetto al padre, perché sapeva che l'avrebbe impedito. Quando parve loro il momento opportuno, diedero il via al piano concertato; e così, come scese la notte - io non c'ero, caso volle che mi fossi addormentato durante il banchetto - portarono via Elena di nascosto dagli altri e, senza perdere un minuto, presero il mare.
Verso mezzanotte Menelao si sveglia, e quando s'accorge che il letto è vuoto e la moglie è sparita, lancia un urlo, corre a chiamare il fratello e insieme si precipitano dal re Radamanto. Alle prime luci dell'alba le sentinelle riferiscono di riuscire a scorgere la nave, già molto lontana; e così Radamanto, imbarcati cinquanta eroi su un'altra nave costruita con un unico tronco di asfodelo, ordina di lanciarsi all'inseguimento. Remando a tutta forza, verso mezzogiorno li acciuffano, proprio mentre stavano ormai entrando nel mare di latte, nelle vicinanze di Formaggino; tanto poco mancò che riuscissero a fuggire! Legarono quindi la nave a rimorchio con una catena di rose, e rientrarono. Elena piangeva e si nascondeva il viso; quanto a Cinira e ai suoi uomini, Radamanto prima li interrogò per sapere se anche altri fossero a parte del complotto, e quando risposero di no, li fece legare per i testicoli e li spedì nel paese degli Empi, dopo averli fatti fustigare con una malva.
Decretarono di bandire dall'Isola anche noi prima del termine fissato: potevamo fermarci soltanto il giorno successivo. Allora cominciai a piangere e a disperarmi, pensando a quali delizie avrei dovuto lasciare per andarmene di nuovo errando chissà dove. Gli stessi Beati peraltro cercavano di consolarmi dicendo che entro non molti anni sarei tornato di nuovo tra loro; anzi già mi mostrarono il mio futuro seggio e il mio posto a tavola, accanto ai personaggi di maggior riguardo. Andai perciò da Radamanto, scongiurandolo di rivelarmi quello che mi riservava la sorte e di indicarmi la rotta da seguire. Mi rispose che sarei riuscito a rientrare in patria, ma avrei prima vagato a lungo e corso molti pericoli: non volle però aggiungere la data del mio ritorno. In compenso, segnandomi a dito le isole lì attorno - ne apparivano cinque, e una sesta più lontana - mi disse: «Le più vicine, da cui si leva quel gran fuoco che già sei in grado di scorgere, sono le isole degli Empi; quella laggiù, la sesta, è la città dei Sogni; dietro c'è l'isola di Calipso, ma non la puoi ancora distinguere con chiarezza. Le oltrepasserai, quindi raggiungerai il vasto continente che si trova agli antipodi di quello abitato da voi; poi, dopo molte vicissitudini, dopo aver viaggiato tra genti di ogni sorta ed essere vissuto tra i selvaggi, finalmente ritornerai nell'altro continente».
Così sentenziò e, strappata da terra una radice di malva, me la porse, raccomandandomi di votarmi a quella nei momenti di maggiore pericolo; mi consigliò anche, una volta rimesso piede in questo mondo, di non attizzare il fuoco con la spada, di non mangiare lupini, e di non accostarmi a nessun ragazzo maggiore di diciotto anni; se mi fossi ricordato bene di tutto questo, avevo speranza di ritornare laggiù. Mi dedicai allora ai preparativi per il viaggio, poi, siccome era già ora di cena, mi misi a tavola con gli altri. Il giorno seguente andai da Omero chiedendogli di buttare giù per me un'iscrizione di un paio di versi, e, quando l'ebbe composta, la incisi sopra una colonna di berillo che avevo innalzato in precedenza nelle vicinanze del porto. Eccone il testo: «Luciano, prediletto dagli dèi Beati, tutto questo vide e di nuovo ritornò alla sua patria terra».
Mi fermai ancora quel giorno, poi - il successivo - ripresi il mare con la scorta degli eroi. Al momento della partenza mi si avvicina Ulisse e, di nascosto da Penelope, mi affida una lettera da recapitare a Calipso nell'isola di Ogigia. Radamanto mandò con noi anche il pilota Nauplio, perché, se fossimo sbarcati sulle isole, nessuno ci catturasse, visto che approdavamo per altri affari. Quando, procedendo nella navigazione, ci ritrovammo fuori da quell'atmosfera profumata, subito ci avvolse un fetore terribile, come di bitume, zolfo e pece che bruciano insieme e un fumo grasso, acre e insopportabile, come di carne umana che arrostisse. L'aria era scura e nebbiosa, e ne stillava una rugiada di pece; sentivamo anche rumore di sferze e gemiti.
Non toccammo le altre isole, ma quella su cui scendemmo era tutto intorno scoscesa e piena di precipizi, arida, tutta rocce e pietraie, senza alberi e senz'acqua: ci arrampicammo a fatica lungo quei costoni dirupati, avanzando poi per un sentiero pieno di spine e di punte acuminate, in un paesaggio quanto mai squallido e desolato. Giunti alla fine nelle vicinanze del carcere, o meglio, del luogo dei supplizi, prima di tutto restammo stupefatti di fronte alla natura di quella località: il terreno era irto dappertutto di spade e di pali aguzzi, intorno scorrevano tre fiumi, uno di fango, il secondo di sangue, quello più interno, larghissimo e invalicabile, di fuoco che fluiva come acqua e si sollevava in onde come il mare; vi nuotavano anche molti pesci, certi che assomigliavano a tizzoni, altri, più piccoli, a carboni ardenti; li chiamavano «luccioletti».
C'era una sola via d'accesso, stretta, per attraversare tutti e tre i fiumi, custodita da Timone l'Ateniese, che funge da guardiano: siamo passati dall'altra parte, comunque, perché Nauplio ci faceva da guida. E qui ci troviamo di fronte, nell'atto di scontare le loro pene, una quantità di sovrani, ma anche molta gente qualsiasi, tra cui abbiamo riconosciuto qualcuno; ci è capitato sotto gli occhi anche Cinira, che bruciava a fuoco lento appeso per i testicoli. Le guide ci hanno fornito le informazioni sulla vita di ciascuno e sulle colpe per cui veniva punito: i castighi più atroci li subivano quanti hanno mentito in qualche circostanza durante la loro vita, in particolare gli storiografi bugiardi, tra cui Ctesia di Cnido, Erodoto e molti altri. Io, naturalmente, vedendoli, nutrivo le più rosee speranze per la mia sorte futura, perché ero perfettamente consapevole di non aver mai detto una sola bugia.
Poi, ritornato in fretta alla nave - non potevo sopportare oltre quello spettacolo -, mi congedai da Nauplio e salpai. E dopo un breve tratto, ci appariva ormai l'Isola dei Sogni, vicina, ma dai contorni labili e indistinti. C'era qualche cosa, nell'isola, che la rendeva molto simile a un sogno: pareva sottrarsi a noi che cercavamo d'accostarci, e sfuggire, allontanandosi più in là. Alla fine, in qualche modo, riuscimmo a toccarla, entrammo nel porto chiamato Sonno, nelle vicinanze delle Porte di Avorio, dove si trova il santuario del Gallo, e, verso il tramonto, scendemmo a terra; nel raggiungere poi la città, incontrammo molti sogni di ogni genere. Prima però voglio dire qualche cosa di quella città, perché nessun altro ne ha scritto, e Omero, il solo che l'abbia ricordata nella sua opera, non è stato molto preciso nella descrizione.
Le si erge tutt'intorno una selva di papaveri altissimi e di mandragore, su cui nidifica un numero enorme di pipistrelli, l'unico tipo di uccello che nasca nell'isola. In prossimità del bosco scorre un fiume, chiamato dagli abitanti Nottambulo, e vicino alle porte sgorgano due sorgenti, esse pure col loro nome, rispettivamente Nonmisveglio e Nottintera. La cinta di mura della città è altissima e multicolore, cangiante come l'arcobaleno. Le porte, veramente, non sono due come dice Omero, ma quattro; due che guardano verso la pianura dell'Indolenza, una di ferro l'altra di terracotta, attraverso le quali - dicevano - escono i sogni che mettono paura, i sogni di morte e di violenza; due, invece, orientate verso il porto e il mare, una di corno, l'altra, per cui siamo passati anche noi, d'avorio. Sulla destra di chi entra in città c'è il santuario della Nyx, che venerano in particolare fra gli dèi, insieme al Gallo, il cui tempio s'innalza vicino al porto; sulla sinistra c'è invece la reggia del Sonno, il re dell'isola, che governa affiancato da due satrapi, ossia due luogotenenti, da lui stesso nominati: Incubo, della famiglia dei Senza-Fondamento, e Annuncia-Soldi, figlio di Fantasione. In mezzo alla piazza c'è una fontana che chiamano la Bella-Addormentata, e accanto due templi, dedicati all'Inganno e alla Verità; qui si trova il loro sacrario, e l'oracolo a cui sovraintende Contraddittorio, l'interprete di sogni: il Sonno gli ha concesso l'alto onore di emettere le profezie.
Quanto ai sogni poi, non erano dello stesso tipo né si presentavano allo stesso modo: alcuni erano alti, belli, di aspetto gradevole, altri invece piccoli e brutti, gli uni tutti d'oro - almeno pareva -, gli altri miserabili e senza valore. Ce n'erano inoltre alcuni alati, con un che di soprannaturale, e altri paludati come per una processione solenne, certi da re, certi da dèi, certi, infine, con qualche altro abbigliamento del genere. Ne riconoscemmo molti, perché li avevamo già visti in passato nel nostro mondo, e questi ci si avvicinarono, salutandoci affettuosamente, come vecchi amici; dopo averci invitati a casa loro e fatti addormentare, ci trattavano con tutti gli onori, e, oltre alla ospitalità sontuosa che ci avevano riservata, ci promettevano anche di farci diventare re e satrapi. Certi, inoltre, ci riconducevano fino in patria, ci mostravano gli amici e i familiari, e nello stesso giorno ci riportavano indietro.
Per trenta giorni e trenta notti prolungammo il nostro soggiorno laggiù, felici e beati... sempre dormendo. Poi, tutt'a un tratto, il fragore potente di un tuono ci risvegliò: saltammo su dal letto, e, dopo esserci riforniti di viveri, salpammo. Nel giro di tre giorni approdammo all'isola di Ogigia, e scendemmo a terra. Io allora, per prima cosa, apro la lettera e la leggo. C'era scritto press'a poco così: «Mia cara Calipso, salve. Sappi che, appena partito dalla tua terra sulla zattera che mi ero costruito, ho fatto naufragio e sono stato portato in salvo - per un soffio - da Leucotea nel paese dei Feaci, che mi hanno rimandato a casa. Là ho trovato un nutrito gruppo di aspiranti alla mano di mia moglie che gozzovigliavano a spese mie: li ho ammazzati tutti, ma in seguito sono stato trucidato da Telegono, il figlio avuto da Circe. E così ora mi trovo nell'Isola dei Beati, con il rimpianto amaro di aver lasciato la vita insieme a te e rinunciato all'immortalità che mi offrivi. Se riesco a cogliere l'occasione, scappo e corro da te». Questo era il contenuto della lettera e, quanto a noi, Ulisse raccomandava a Calipso di trattarci bene.
Inoltratomi per un breve tratto dal mare verso l'interno, trovo la grotta - tale e quale la descrive Omero - e lei intenta a filare. Una volta avuta la lettera, la lesse e pianse a lungo, poi però ci offrì ospitalità e imbandì una splendida cena in nostro onore, chiedendoci intanto di Ulisse e di Penelope: se era bella e fedele come Ulisse, in passato, era solito affermare con orgoglio di lei; cercammo di rispondere come pensavamo potesse farle piacere. Ce ne ritornammo quindi alla nave, mettendoci a dormire lì accanto, sulla spiaggia.
All'alba levammo le ancore, con un vento che soffiava piuttosto forte. Dopo essere rimasti in balia della tempesta per due giorni, al terzo cadiamo nelle grinfie degli Zucche-Pirati, dei selvaggi che, muovendo dalle isole vicine, depredano chi naviga in quei paraggi. Hanno grandi navi ricavate dalle zucche, lunghe sessanta cubiti. Fanno seccare la zucca, la scavano, togliendone la polpa, e vi si imbarcano, impiegando, come alberi, delle canne e, come vele, le foglie della zucca stessa. Ci attaccarono dunque con due vascelli e incominciarono a combattere, ferendo molti dei miei uomini col lancio non di pietre, ma di semi di zucca. La battaglia durava ormai da tempo, con sorti alterne, e non accennava a risolversi, quando verso mezzogiorno vediamo avvicinarsi, alle spalle dei nostri avversari, i Nocinauti. Erano nemici tra loro, evidentemente, perché appena gli Zucche-Pirati s'accorsero che stavano sopraggiungendo, non si curarono più di noi e, con un rapido dietro-front, si lanciarono all'assalto contro i nuovi venuti.
Noi nel frattempo, issate le vele, fuggimmo, lasciandoli nel pieno dello scontro; era chiaro che avrebbero vinto i Nocinauti, perché erano più numerosi - disponevano di cinque navi - e combattevano con imbarcazioni più solide: si trattava di gusci di noce divisi a metà, svuotati, che raggiungevano ciascuno la lunghezza di 15 orge. Appena ci sottraemmo alla loro vista, medicammo i feriti, e in seguito eravamo costantemente sul piede di guerra, aspettandoci sempre qualche insidia: timore non vano!
Non era ancora tramontato il sole, infatti, che da un'isola deserta si lanciarono all'assalto contro di noi una ventina di uomini, montati su grossi delfini, corsari anche questi: i delfini li portavano saldamente sul dorso, e quando saltavano fuori dall'acqua nitrivano come cavalli. Una volta vicini, si divisero in due gruppi, e, da una parte e dall'altra, cominciarono a bersagliarci con ossi di seppia e occhi di granchio; ma a un certo punto non riuscirono più a resistere alla furia delle nostre frecce e delle nostre lance e, feriti quasi tutti, ripiegarono verso la loro isola per trovarvi rifugio.
Verso mezzanotte - era bonaccia - senza rendercene conto, c'incagliammo in un gigantesco nido di alcione, della circonferenza di almeno sessanta stadi. La femmina stava nel nido che galleggiava sull'acqua, covando le sue uova, ed era grande quasi quanto il nido stesso, tant'è vero che quando si alzò in volo, per poco non fece affondare la nave con lo spostamento d'aria provocato dalle ali; fuggì via emettendo una specie di lugubre lamento. Alle prime luci dell'alba, sbarcati, constatammo che il nido assomigliava a una enorme zattera, costruita mettendo insieme poderosi tronchi d'albero; conteneva cinquecento uova, ciascuno più grosso di una botte di vino di Chio e già i pulcini cominciavano a far capolino dall'interno e a pigolare: spaccammo allora, a colpi di scure, un uovo e ne estraemmo un pulcino implume, più grande di venti avvoltoi.
Quando eravamo ormai lontani circa duecento miglia dal nido, ecco una serie di straordinari fenomeni: il paperotto di poppa all'improvviso cominciò a sbattere le ali e a starnazzare; a Scintaro, il nostro pilota, già calvo, ricrebbero i capelli; e, cosa più assurda di tutte, l'albero della nave mise germogli e rami e infine, in cima, produsse anche dei frutti: fichi e uva nera, non ancora matura. Di fronte a tutto questo, naturalmente, restammo sconvolti, e rivolgemmo una preghiera agli dèi, considerata l'eccezionalità di quel prodigio.
Non avevamo percorso ancora cinquecento miglia, quando vediamo una foresta, sterminata e folta, di pini e cipressi, che supponemmo fosse un continente: si trattava invece di un mare di profondità vertiginosa, completamente ricoperto di alberi privi di radici, che però si ergevano senza oscillare, dritti, galleggiando in qualche modo sul pelo dell'acqua. Avvicinatici, dunque, ed esaminata la situazione da tutti i punti di vista, ci rendemmo conto di essere in un vicolo cieco; non era possibile navigare attraverso la selva, perché gli alberi erano fitti, in pratica a ridosso l'uno dell'altro; né del resto pareva facile ritornare indietro. Allora salii sull'albero più alto per scrutare cosa ci fosse dall'altra parte, e constatai così che la selva si estendeva per cinquanta stadi o poco più ma al di là c'era altro mare. Decidemmo perciò di issare la nave sulle chiome degli alberi - erano ben folte - e, con una traversata... sopraelevata, di trasportarla, possibilmente, fino all'altra parte di Oceano: e così facemmo. L'abbiamo legata con un cavo robusto e, arrampicatici sugli alberi, con molta difficoltà siamo riusciti a sollevarla: depostala poi sui rami e spiegate le vele, filavamo a tutta andatura, spinti dal vento, come sul mare. Allora mi è tornato in mente quel verso del poeta Antimaco - lo dice proprio lui non so dove -: «a quelli che procedevano nella loro selvosa traversata».
Forzata - per usare questa espressione - la foresta, raggiungemmo l'acqua e, calata di nuovo la nave con lo stesso sistema, riprendemmo la navigazione in un mare limpido e trasparente, finché non ci trovammo di colpo sull'orlo di un'enorme voragine formata dall'acqua divisa in due, una voragine simile ai crepacci che spesso si aprono sulla terra per effetto dei terremoti. Ammainiamo immediatamente le vele, e la nave a malapena riesce a bloccarsi, dopo aver rischiato di precipitare là dentro. Ci sporgiamo, allora, e vediamo un abisso profondo circa mille stadi, davvero impressionante e assolutamente straordinario: l'acqua stava dritta e ferma come fosse stata tagliata a metà. Guardandoci intorno, però, scopriamo sulla destra, non molto distante, un ponte d'acqua che congiungeva le superfici dei due mari scorrendo dall'uno all'altro. Arrivati fino al ponte a forza di remi, a prezzo di enormi sforzi riuscimmo ad attraversarlo, quando ormai non speravamo più di farcela.
Da quel momento in poi ci accolse un mare calmo e propizio alla navigazione, e un'isola piuttosto piccola, di facile accesso, abitata: era territorio dei Testadibue, uomini feroci, con le corna, come da noi raffigurano il Minotauro. Sbarchiamo e ci inoltriamo verso l'interno per rifornirci d'acqua e di viveri, se possibile, perché avevamo esaurite le scorte. Troviamo l'acqua lì vicino, ma non si vedeva niente altro: si sentivano soltanto, non molto lontano, dei potenti muggiti. Convinti si trattasse di una mandria di buoi, andiamo avanti con cautela e incontriamo invece un gruppo di quegli esseri di cui ho parlato che, appena ci vedono, si lanciano al nostro inseguimento, catturando tre miei compagni. Noialtri siamo riusciti a rifugiarci sulla spiaggia, ma poi ci siamo armati tutti quanti - non era giusto lasciare invendicati i nostri amici -, siamo piombati addosso ai Testadibue mentre si stavano dividendo le carni di quei poveretti barbaramente trucidati, e li abbiamo costretti alla fuga, inseguendoli e uccidendone una cinquantina; dopodiché, siamo ritornati indietro con due di loro che avevamo presi vivi. Però non avevamo trovato da mangiare; gli altri miei compagni allora cominciarono a insistere perché si sgozzassero i prigionieri, ma io non ero d'accordo; li legai, invece, tenendoli sotto sorveglianza, finché non arrivarono dei messi da parte dei Testadibue a richiederli dietro pagamento di un riscatto: lo capimmo dal loro gesticolare e dal fatto che emettevano muggiti lamentosi, come se supplicassero. Il riscatto consisteva in molti formaggi, pesci secchi, cipolle e quattro cervi con tre zoccoli ciascuno, due dietro e quelli davanti saldati a formarne uno solo. A queste condizioni restituimmo i prigionieri e, dopo esserci fermati ancora un giorno, riprendemmo il mare.
Già cominciavamo a vedere dei pesci e ci volavano intorno degli uccelli: insomma questi e altri fenomeni del genere ci rivelavano che la terraferma era ormai vicina. Poco dopo incontrammo degli uomini che utilizzavano una tecnica di navigazione davvero rivoluzionaria: infatti erano marinai e navi al tempo stesso. Vi dirò come: stavano sdraiati supini sul pelo dell'acqua col pene diritto - ce l'hanno molto lungo - e a questo era fissata una vela ben tesa, di cui reggevano le scotte con le mani: così, quando il vento soffiava nella vela, navigavano. Dopo di loro comparvero altri uomini: seduti su dei sugheri, spronavano e tenevano le redini di due delfini aggiogati, che, avanzando, trainavano i sugheri stessi. Non ci fecero alcun male e non fuggirono: anzi, s'avvicinarono senza paura e con atteggiamento amichevole, contemplando ammirati la forma della nostra nave e osservandola attentamente da ogni lato.
Era ormai sera quando approdammo a una minuscola isola, abitata da donne - così credevamo almeno - che parlavano greco. Ci vennero incontro accogliendoci festosamente, a braccia aperte; erano tutte giovanissime, belle e agghindate in un modo molto simile a quello delle etere: indossavano delle tuniche lunghe fino ai piedi, con lo strascico. Il luogo si chiamava Isola dell'Inganno, e la città Acqua-vorace. Ciascuna di queste donne, dopo un sorteggio, condusse uno di noi a casa propria, offrendogli ospitalità; ma io, che mi ero allontanato un attimo - avevo dei brutti presentimenti - guardandomi intorno con gli occhi ben aperti, scopro in terra ossa e teschi umani in quantità. Mettermi a gridare, richiamare i compagni e correre alle armi, però, non mi parve la soluzione migliore: tirai fuori la malva, invece, e pregai con tutto il mio fervore di riuscire a scampare con il suo aiuto al pericolo incombente. Poco dopo, mentre la mia ospite mi serviva il pranzo, mi accorsi che non aveva gambe di donna, ma zoccoli d'asino; allora, sguainata la spada, la afferrai, la legai e cominciai a interrogarla. E lei, pur con riluttanza, parlò: erano donne, figlie del mare, il loro nome era Gambedasino e il loro cibo era costituito dagli stranieri che capitavano da quelle parti. «Prima li ubriachiamo», mi disse, «e, dopo aver fatto all'amore con loro, li aggrediamo nel sonno». Sentendo questo, la lasciai lì - tanto era legata - e, salito sul tetto, cominciai a urlare, chiamando a raccolta i compagni. Quando furono riuniti, rivelai tutto, mostrai le ossa e li guidai dentro, dalla mia prigioniera. Ma quella subito si trasformò in acqua e sparì; ugualmente, però, infilai la spada in quell'acqua per vedere che cosa sarebbe successo, e l'acqua divenne sangue.
Senza perdere un attimo, naturalmente, ritornammo alla nave e riprendemmo il mare. Alle prime luci dell'alba avvistammo il continente e supponemmo fosse quello che si trova agli antipodi della terra abitata da noi. Prostratici e ringraziati gli dèi con le debite preghiere, cominciammo a riflettere su quello che dovevamo fare a quel punto: certi consigliavano di limitarci a mettere piede a terra e tornare poi indietro, altri di abbandonare lì la nave e di inoltrarci nel cuore di quel continente per vedere che genti l'abitassero. Ma, mentre stavamo discutendo, si abbatté su di noi una violenta tempesta che scaraventò la nave sulla spiaggia, riducendola in pezzi, tanto che noi a malapena siamo riusciti a salvarci a nuoto, recuperando le armi e tutto quanto è stato possibile strappare alla furia delle onde. Ecco le mie vicende fino all'arrivo nell'altro mondo, in mare e durante la navigazione tra le isole e nello spazio, poi nel ventre della balena, e, una volta uscito di là, nel paese degli Eroi e in quello dei Sogni, e, alla fine, tra i Testadibue e le Gambedasino: le mie avventure nell'altro continente, però, ve le racconterò nei libri successivi.